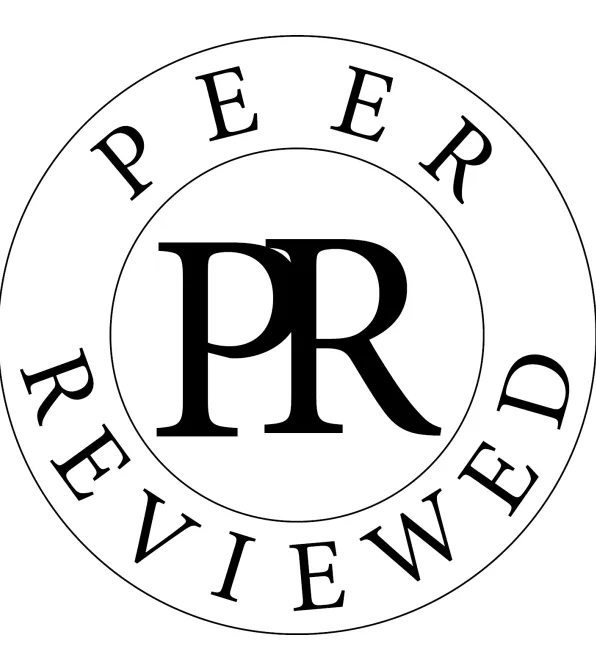D’un phare l’autre. Vagabondaggi letterari per mare e per terra

Elena Grammann, D’un phare l’autre. Vagabondaggi letterari per mare e per terra, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 58, no. 12, dicembre 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.12044
Prospettive
Se il tema sono i fari in letteratura, il primo titolo che ci viene in mente – oltre, si capisce, a To the lighthouse – è Les Phares, sesto componimento di Spleen et Idéal: undici quartine dedicate a giganti della pittura europea.
Leonardo, Rembrandt, Delacroix e gli altri sono, per Baudelaire, i Fari: coloro che hanno via via illuminato porzioni della condizione umana e, passandosi il testimone attraverso i secoli, ne hanno delineato le forme ribelli, tormentate o estatiche: “oppio divino per i cuori mortali”. Baudelaire si attiene dunque, per i fari, al loro effetto sull’esterno – potremmo dire, con espressione sobriamente tecnica, sull’utenza: effetto di illuminazione, disvelamento dalle tenebre, ricognizione. Più spesso però la prospettiva non è quella. In letteratura, del faro interessa più spesso, o più particolarmente, la prospettiva interna: l’isolamento, lo sguardo dall’alto, la segregazione in uno spazio estremamente ridotto. Come se il faro rappresentasse, per chi lo abita, la sede di un esperimento, un laboratorio privilegiato in cui le cose dell’uomo e del mondo si manifestano per quello che sono.
Fari d’acqua
Ar-Men, Bretagna (femminile, maschile / 1)
Al largo della Pointe du Raz, nella Bretagna sud-occidentale, si estende per circa venticinque chilometri nell’Atlantico, in direzione ovest, la cosiddetta Chaussée de Sein, un prolungamento delle formazioni granitiche della Pointe, sommerse o affioranti, la più elevata delle quali costituisce l’isola di Sein. Gli scogli e le correnti rendono questo tratto di mare estremamente pericoloso. Fino alla seconda metà dell’Ottocento i naufragi vi erano frequenti, tanto che dopo il disastro della fregata Sané, nel 1859, fu decisa la costruzione di un faro all’estremità occidentale della Chaussée.
Più facile a dirsi che a farsi. Il punto individuato, lo scoglio di Ar-Men (in bretone: La Pietra), affiora soltanto nella bella stagione, con la bassa marea, per qualche ora al giorno. L’attracco è impossibile, la superficie minima, praticamente appena più larga del faro che vi sarà effettivamente costruito in quattordici anni di lavori, un’impresa titanica, dal 1867 al 1881. Fino al 1990, anno in cui sarà automatizzato, i guardiani si sono avvicendati in squadre di tre, secondo turni che prevedevano sempre due guardiani nel faro e uno a terra a riposo. I turni di presenza erano, teoricamente, di venti giorni. Teoricamente perché il faro non ha approdo, cose e persone vanno e vengono dallo scoglio all’imbarcazione di appoggio sospese nell’aria tramite cavo d’acciaio e poiché spesso, durante la brutta stagione, questa operazione non è affatto possibile, i guardiani possono rimanere bloccati a lungo, mentre le tempeste e la violenza del mare mettono a dura prova la struttura del faro. Insomma, a partire dalla tassonomia che distingue fra Paradisi (fari costruiti sulla terraferma), Purgatori (fari costruiti sulle isole) e Inferni (fari costruiti su uno scoglio in mezzo al mare), Ar-Men si è guadagnato l’appellativo di Enfer des Enfers. Di che affascinare più di uno scrittore.
Nel 1899 Marguerite Eymery, in arte Rachilde1, che si definiva “homme de lettres” e a ventiquattro anni si era imposta all’attenzione del pubblico col romanzo protoqueer, scandaloso e prontamente censurato, Monsieur Vénus (1884), pubblica La tour d’amour, la cui azione si svolge quasi interamente nel faro di Ar-Men.
Disorienta il titolo lezioso, più adatto a qualche revival medievale in filigrana che alla dura realtà del faro. Senonché scopriamo che si tratta di un titolo antifrastico: ci troviamo di fronte a una concezione dell’amore come specchietto per le allodole dietro al quale si cela la lotta feroce dei sessi: uccidere o essere uccisi, uccidere e essere uccisi. Le donne, secondo un diffuso immaginario decadente, altrettante Erodiadi o Salomé, vampiri succhiamidollo, sfingi esiziali con le quali si può scendere a patti soltanto da morte. Sesso e follia, eros e morte, Trionfo della morte – aspettando che passi questa fin de siècle da incubo e si vada oltre, a prezzo di una, o due, guerre mondiali.
La distesa d’acqua in delirio sbavava, sputava, si rotolava davanti al faro mettendo in mostra la sua nudità fino alle viscere.
La baldracca prima si gonfiava come un ventre, poi si incavava, si appiattiva, si apriva spalancando le cosce verdi; e alla luce della lanterna si intravedevano cose che facevano venir voglia di guardare da un’altra parte. Ma lei ricominciava, scarmigliata, tutta in convulsioni d’amore o di follia. Sapeva bene che coloro che la guardavano le appartenevano.2
Coloro che la guardano sono l’anziano farista capo Mathurin Barnabas, che non scende più a terra e vive quasi come un animale: un granchio, un ragno, un mollusco abbarbicato alle pareti viscide del faro, e il suo giovane secondo Jean Maleux, narratore alla prima persona, il quale invece, stanco di navigare e convinto di essersi aggiudicato una sinecura statale, pensa al matrimonio. Cioè: ci pensava – senza fare i conti con la metafora nella quale si è incautamente inserito. Il faro – maschile, simbolo fallico se mai ve ne furono – è in guerra perenne con la mer: femminile, rabbiosa, divoratrice di uomini e scafi. Soltanto la follia del vecchio Barnabas – che non ha mai superato il trauma, diremmo ora, del tradimento della moglie – è in grado di stabilire una tregua. Una specie di contratto: lui rinuncia alla (illusoria?) salute psichica della terraferma, si consegna anima e corpo a la mer, e lei fornisce, con i cadaveri delle naufragate, materia al suo amore. Necrofilia, feticismo, lordure di ogni genere: questo, e non altro, è l’amore di cui è impregnata la torre.
Il giovane Maleux scopre a poco a poco i segreti del vecchio, che lo disgustano, certo, ma che considera alla stregua di perversioni tutto sommato inoffensive; perso com’è, lui, dietro rosei sogni matrimoniali. Si considera, un po’ precipitosamente, fidanzato con Marie, una ragazzina di Brest, una quindicenne troppo giovane o troppo sveglia per fare sul serio. La delusione arriva e Rachilde fa del suo meglio per ampliarne psicologicamente la portata e scavare un abisso antropologico fra il maschio e la femmina.
La scoperta dell’ultimo segreto del vecchio, da film dell’orrore, finisce di precipitare Maleux in uno stato di prostrazione prossimo alla follia. Scende ancora una volta a terra e disperato, ubriaco, allucinato, trova il modo di piantare il coltello nella pancia di una prostituta.
La ragazza, forse ubriaca quanto me, forse perché le mie parole le ricordavano una voce già udita, si precipitò bruscamente fra le mie braccia, mi si avvinghiò alle spalle come una piovra e mi baciò sulla bocca con un lungo bacio suggente, abominevole, fetido di muschio.
– Non bacerai più nessuno! Hei finito di ridere, lurida baldracca!
E le piantai il coltello nella pancia.
Cadde. Io continuai per la mia strada senza nemmeno voltarmi, camminando con passo più fermo, più dignitoso, inebriato da una grande fierezza.
– Beh, che c’è? Ho ucciso il mare!3
La donna è morta o è soltanto ferita e si salverà? Maleux non lo sa e noi neppure; in ogni caso nessuno viene a importunarlo. Di lì a poco il vecchio Barnabas muore e il suo secondo è nominato guardiano capo a Ar-Men. Ma la promozione, che doveva garantire rispettabilità e sicurezza economica, le buone basi per un matrimonio conciliatore dei sessi, sancisce invece l’esilio del guardiano da ogni ragionevole, dunque illusorio, consorzio umano:
Sono stato nominato guardiano capo.
Marie, mia cara, piccola Marie…
Davanti a Dio, se mi ascolta, giuro i non rivedere mai più la terra4.
Cornovaglia / Ebridi (femminile, maschile / 2)
Non troppo lontano in linea d’aria da Armen è il faro di Godrevy in Cornovaglia, che, trasferito per ragioni di finzione nelle Ebridi, fornirà a Virginia Woolf il riferimento visivo per il romanzo Gita al faro (1927). Ancora una donna, e centrale ancora, fra i temi toccati, il rapporto fra i sessi. Non troveremo però simbolismi plateali, passioni torbide, necrofilie letterali o metaforiche, femminicidi catartici. Nessuna fascinazione per gli stati patologici: il decadentismo – in quel senso – grazie a Dio è andato.
Il titolo originale – To the Lighthouse – non indica tanto un edificio o un luogo quanto una direzione, un’intenzione. Del faro non vediamo gran che; quasi soltanto, e raramente, le sciabolate di luce che raggiungono l’isola di fronte, luogo di villeggiatura estiva della famiglia Ramsay e dei suoi numerosi ospiti. Il faro latita – fino alle ultimissime pagine. Per tutta la prima parte del romanzo non è che l’oggetto del desiderio del piccolo James Ramsay, meta della gita sentimentalmente promessa dalla madre e razionalmente5 negata dal padre; niente più che l’occasione per il dipanarsi di un discorso sul femminile e il maschile, sul loro difficile ma secondo la signora Ramsay imprescindibile connubio; nonché sugli effetti che la reale inconciliabilità dei sessi rischia di produrre sui figli più sensibili.
Nella terza e ultima parte, quasi avulsa e dissonante dopo la morte improvvisa della signora Ramsay e la cesura della prima guerra mondiale, anche il faro cambia di segno. La gita stavolta si farà; ma – decisa e voluta dal padre, oggetto di una sua imposizione – perde ogni attrattiva e si riduce all’ennesima manifestazione di un potere vissuto dai figli come tirannico e odioso. Il faro passa dal sognato al conosciuto, dal dominio infantile del desiderio (la madre) a quello adulto della realtà (il padre). Lo stesso James, al timone della barca che li conduce all’isolotto, confronta l’azzurro indistinto e fiabesco della sua infanzia con la materialità precisa e concreta, osservata da vicino, del faro divenuto neutro oggetto di conoscenza:
Il Faro era allora una torre argentea, brumosa, con un occhio giallo che si apriva all’improvviso e in silenzio nella sera. Adesso…
James guardava il Faro. Vedeva le rocce calcinate; la torre, spoglia e dritta; vedeva che era dipinta a strisce bianche e nere; vedeva le finestre; vedeva perfino la biancheria distesa sulle rocce ad asciugare. Dunque quello era il Faro, era quello?
No, anche l’altro era il Faro. Perché nessuna cosa è una soltanto. Anche l’altro era il Faro.6
The other Lighthouse was true too. Come dire che principio femminile e principio maschile, benché ampiamente antitetici, hanno entrambi diritto d’esistenza e sono radicati nella natura delle cose. Si tratterà dunque di conciliarli – cosa non facile e forse impossibile in una dimensione reale. Per fortuna c’è la letteratura, e infatti durante la traversata anche la rigida ostilità dei due ragazzi nei confronti del signor Ramsay si stempera in una sorta di comprensione.
Ma torniamo all’unica reale, benché sporadica, manifestazione del faro nella gran parte del romanzo: i segnali di luce – due brevi, uno lungo – che invia all’isola. Esaminiamone le coincidenze con la psiche della signora Ramsay, sferruzzante vicino alla finestra in un raro momento di solitudine:
Poteva essere se stessa, in compagnia di se stessa. E di ciò sentiva ora spesso il bisogno – di pensare be’, non necessariamente di pensare. Di stare in silenzio, da sola. L’essere e il fare, espansivi, luccicanti, vocali, evaporavano; e ci si poteva ridurre, con un senso di solennità, al proprio sé, in un cuneo di tenebra, invisibile agli altri. […] C’era libertà, c’era pace, c’era, più gradita di tutto, una sensazione di raccoglimento, di quiete su una piattaforma di stabilità. Sapeva per esperienza […] che tale quiete non la si raggiunge restando se stessi, ma diventando quel cuneo di tenebra. Accantonando la propria personalità, si accantonavano l’inquietudine, la fretta, la confusione; e sempre le saliva alle labbra un’esclamazione di trionfo sulla vita, quando le cose si riunivano insieme in quella pace, quella quiete, quell’eternità; e interrompendosi volse lo sguardo verso il raggio del Faro, il raggio lungo e durevole, l’ultimo dei tre, che era il suo raggio.7
Si potrebbe chiamarlo un effetto di spersonalizzazione, precisando però che si conclude con un guadagno: la perdita di ogni determinazione sociale (la superficie, “what you see us by”) permette l’affiorare di quel nucleo autentico e beatificante che è noi stessi ma anche, senza soluzione di continuità, ogni cosa che ci circonda, da vicino o da lontano. Cancellazione dei confini imposti dall’intelletto (non a caso la facoltà tenuta in maggior conto dal signor Ramsay, di professione filosofo), abbandono del superfluo, uno sgravarsi dalla zavorra, estasi. Letteralmente: uno stare fuori dai limiti dell’io diurno: attivo, affaccendato, incasellato, sociale.
Questa la coincidenza della signora Ramsay con il terzo raggio, lungo, del faro; il quale invia i suoi segnali ma sta fuori dalla scena. Un garante dell’ekstasis, in un certo senso.
Non è, certamente, il protagonista. Non è nemmeno il luogo segregato di una follia o di una ascesi. È il punto fuori scena, privo di dimensioni e in fondo di realtà, a partire dal quale sono osservati, descritti e gentilmente messi in dubbio i meccanismi coniugali, famigliari, sociali e psicologici che fanno quella che comunemente si chiama vita. Rappresenta anche, con l’affidabile ritorno dei suoi fasci luminosi – breve, breve, lungo – l’illusione di un’eternità dell’istante, delle situazioni, delle costellazioni. Che nulla, in fondo, cambi. Che il momento benedetto duri per sempre.
Illusione ipnotica; il faro entra materialmente in scena nelle righe conclusive8, quando il tempo ha disatteso e travolto tutte le promesse. Soltanto allora il signor Ramsay, dopo essersi rimboccato i calzoni, salta sulla roccia dell’approdo, e cala il sipario.
Salta però il signor Ramsay, settantunenne, “lightly like a young man”. Così ci viene detto – forse a suggerire una superficialità, una non-serietà di fondo delle sue teatrali sofferenze di maschio; narcisistiche trafitture più che altro, dolorosissime punture di spillo che richiedevano il pronto intervento della defunta signora Ramsay – dispensatrice di balsami egoprotettivi finché visse. O, uscita lei tragicamente di scena, la comprensione compassione consolazione di un’altra rappresentante del sesso femminile, che adempia per favore alla funzione per cui è al mondo, applicare cataplasmi sulle contusioni dell’ego maschile, vedrai carino, se sei buonino, che bel rimedio ti voglio dar. Sotto il pungolo della necessità non si sta a guardare per il sottile, la bruttina Miss Briscoe andrebbe benissimo, non fosse che è così ostinata, così maldestramente chiusa nella sua verginità, così risolutamente célibataire nel suo rifiuto di prestare soccorso psicologico all’altro sesso.
Eppure anche Lily Briscoe, in qualche modo, cede9; come cede la figlia Cam, benché abbia giurato, insieme a James, di “resistere alla tirannia fino alla morte”; e James stesso è sorpreso, all’approdo al faro, da una specie di riconciliazione.
Inutile, mi pare, cercare nel faro di Woolf implicazioni falliche e opposizioni fatali10. Si direbbe al contrario che, appianati i conflitti fra i sessi e fra i ruoli, un’armonia sia possibile. L’ermafrodito originario può ricostituirsi, se non socialmente almeno letterariamente, e la signora Ramsay, benché defunta, trionfa ancora11.
Ar-Men, di nuovo (esteriorità, interiorità)
Nel 1956 uno studente di lettere di belle speranze, Jean-Pierre Abraham, originario di Lorient, pianta lì la Sorbona, i giovedì alle éditions du Seuil, gli amici introdotti e le conoscenze che contano, per fare il servizio militare in marina. Durata della ferma, trenta mesi: sono gli anni della guerra d’Algeria. A bordo del dragamine a cui è destinato, durante un’esercitazione nel mar d’Iroise, vede da lontano il faro di Armen e decide che è lì che vuole vivere. Nel luglio ‘59 inizia la trafila: quasi due anni fra i mesi di prova e i centri di formazione sulla costa bretone. Fedele al suo progetto, rifiuta l’offerta di entrare nella redazione della rivista Tel Quel e nel 1961 è nominato guardiano a Armen.
Lascia il faro nel 1964 per sposarsi e si stabilisce, con la moglie, di nuovo in capo al mondo ma dalla parte opposta: un piccolissimo borgo sulle Alpi di Provenza. Lì riordina i suoi appunti di guardiano e nel 1967 esce, per Le Seuil, Armen.
Perché questa presentazione fin troppo dettagliata di un autore sconosciuto in Italia12 e considerato, anche in Francia, piuttosto di nicchia?
Per mettere subito in chiaro che non c’è, per Abraham, una reale differenza, uno stacco fra letteratura e vita. La letteratura, pur perseguita con grandissima serietà e quasi con acribia, non è un mestiere – né tanto meno una carriera. Si potrebbe dire che è la vita in una forma chiarificata; e la vita – una vita schiva, in cui l’io è sempre un po’ en retrait mentre il primo piano è occupato dalla percezione delle cose, dallo stupore per la qualità delle cose come appare sulla loro mutevole superficie – la vita è l’origine immediata della letteratura, il minerale che la contiene, l’argilla che deve essere cautamente rimossa per portare alla luce il reperto ineguagliabile che si trova soltanto lì. Non stupisce, allora, che i suoi libri (pochi!) siano récits alla prima persona. Non diari, non autobiografie, non autofiction: récits – parola di cui non trovo un traducente italiano. Non indica, di per sé, né un racconto né un romanzo né una cronaca; indica la narrazione come forma-base, senza altre precisazioni, ed è particolarmente adatto a un’epoca – la metà del Novecento – in cui romanzo e racconto perdono le penne e non si sa più bene che uccelli siano. Récits dunque, e alla prima persona, perché qualcuno deve pur prendersi la responsabilità della verità di ciò che viene detto, dell’accuratezza delle superfici che vengono mostrate, e questo qualcuno può essere, naturalmente, solo colui che scrive, dal momento che dell’io degli altri, e di come loro vedono le cose, non sappiamo assolutamente nulla. Tuttavia, ripetiamo, récit e non diario, non autobiografia. Niente di bruto, di non elaborato, di puramente documentario: l’obiettivo rimane l’oggetto letterario.
Il marinaio imbarcato sul dragamine era già l’autore, a vent’anni, di un récit pubblicato sul primo numero della rivista Écrire, dal titolo Le vent. Una prosa da cui emerge, oltre a una sorprendente sicurezza nel maneggiare l’oggetto letterario, un amore quasi esclusivo per la descrizione, una minuzia realistica in un contesto, invece, piuttosto surrealista. Come se tutto l’andare e venire del narratore – lui stesso privo di caratterizzazioni – non fosse che un lunghissimo sogno in cui l’unico compito del sé fosse registrare un paesaggio a cui lo collegano, vitalisticamente, misteriose nervature.
Al giorno d’oggi soprattutto, se uno di vent’anni si vede pubblicata, e recensita positivamente su Le Figaro, una cosa che ha scritto a diciannove, non c’è dubbio che ne pubblicherà un’altra a ventuno e così via, una all’anno. Ma se si conosce Abraham da quello che ha scritto in seguito, leggendo Le vent appare evidente che doveva staccare, che arruolarsi su un dragamine era la cosa da fare: troppo letterario l’esordio, troppo generica la coscienza narrante, troppo poca esistenza in quella letteratura.
Undici anni separano Le vent da Armen, undici anni che servono a definire un io non prevaricante ma personale, particolare, e i suoi rapporti esigenti con le cose, con la loro maggiore o minore disponibilità a aprire una comunicazione; realtà fisica e realtà psichica, esterno e interno, due facce di una stessa esperienza. Il tutto in un faro che schizza su dal mare sottile come una candela, pochissimo spazio sia per il dentro che per il fuori (la distesa infinita dai finestroni della lanterna piuttosto un leurre, un abbaglio), massimo della concentrazione.
Armen è un récit senza trama. La delimitazione cronologica (dall’autunno alla primavera dell’anno seguente, anno peraltro non specificato) tiene luogo di struttura. Sono annotazioni precedute da una data (ma senza indicazione dell’anno, quindi non una vera data); qualcosa a metà fra un diario e un giornale di bordo, però sollevato dalla contingenza, rielaborato, trasferito con grandi precauzioni nel regno della letteratura; senza tuttavia che vi si stenda quella vernice onirica, quasi rimbaldiana, che aderiva alla prosa giovanile. I pochi personaggi che si muovono attorno al narratore, come il narratore stesso, non hanno nulla delle sagome vagamente fiabesche che popolavano Le vent; sono persone reali; unica concessione alla dimensione letteraria: certi nomi (non tutti) sono stati cambiati. Un non facile equilibrio, che Abraham ha probabilmente cercato a lungo, fra esistenza e letteratura.
D’accordo, ma qual è il punto? Di cosa parla precisamente questo libro? Da quali premesse muove e a quali conclusioni giunge? Altrettante domande a cui è difficile, se non impossibile, rispondere. Ciò che è vero di qualsiasi opera letteraria: che nessun resoconto, per quanto accurato, nessuna interpretazione, per quanto geniale, può sostituire la lettura, lo è a un grado ancor maggiore per Armen. Non è il racconto di uno svolgimento, non sfocia su alcuna modificazione, non si può riassumere. È il tentativo, sempre ripreso, della definizione il più precisa possibile di uno stato – stato del sé, stato delle cose – in una condizione da esperimento scientifico – tendente cioè a escludere le variabili che finirebbero per falsare il risultato: la solitudine del faro di Armen13.
16 gennaio
Vento di Nord piuttosto forte. Il mare è appena agitato. Non si vedono i fari di Ouessant. L’aria è tagliente, tintinna di gelo nella scala. Il freddo mi illumina. Ero fatto per un mondo liscio e chiaro, peraltro non esente dalle quotidiane inadeguatezze. Vorrei talmente essere attento, ora, non rischiare una parola a caso. Poiché siamo nel deserto, rallentare il passo, soffocare ogni impazienza…
Nel cerchio della lampada, il deserto con tutte le sue passioni, disgusto, modestia.14
Preoccupazione di esattezza, disgusto dell’inadeguato, del pressappoco, consapevolezza di essere quotidianamente manchevoli rispetto a questo compito, non diversamente da un anacoreta che misura la sua distanza da Dio.
“Non rischiare [di scrivere] una parola a caso”: questo l’obiettivo letterario e umano, letterario perché prima di tutto umano, di Abraham; un obiettivo di onestà intransigente, difficile da conciliare con una letteratura di finzione, col racconto con un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Tutto si gioca nel rapporto fra la cosa e la parola: una parola che sia in grado di dire esattamente la cosa, ma soltanto perché, prima, si è stati capaci di ascoltare la cosa. Il che naturalmente comporta un margine di fiducia: fiducia nella, chiamiamola, loquacità delle cose, e fiducia nella possibilità, da parte nostra, di intenderle.
5 febbraio.
Al crepuscolo la marea saliva. Il vento era ghiacciato. Rabbrividendo, inerpicato sul muretto esterno della lanterna, pulivo le grandi vetrate. […] Quello che scorgevo dall’altra parte dei vetri mi riempiva di stupore. La fodera bianca immobile sull’ottica, lo splendore tranquillo degli oggetti, specchio, chiavi misteriose pensate per un uso preciso. Mi trovavo in esilio. Ero felice di sapere che presto sarei rientrato, avrei abitato vicino a quelle cose. […]
La luce dolce che regna nella lanterna non sembra venire da fuori, non assomiglia a quella che vediamo muoversi sull’acqua, duramente affilata dal vento, fredda, vecchia, qua e là segnata da ombreggiature.
Qui si impone la fermezza estrema, la dolce fermezza dei riti.15
Le cose tanto più ci (cor)rispondono e emanano senso, si direbbe, quanto più sono costrette nello spazio ridottissimo, essenziale, del faro – di questo faro. Costrette e in parte o in toto modificate, snaturate, estraniate, misteriose, irriconoscibili al di fuori dei riti di cui è fatta la specificità di questa vita; cose che l’esiguità dello spazio, la sua circolarità (non ci sono, quasi, pareti dritte), de-formandole e ri-formandole, libera dal mutismo a cui le riduce, sulla terraferma, l’abitudine. Viceversa, le abitudini che si istaurano nella reclusione claustrofobica del faro, dai compiti quotidiani agli spostamenti su e giù lungo la stretta scala a chiocciola, con drastica riduzione di tutte le possibili distrazioni, diventano riti che non distolgono ma concentrano.
Armen è la relazione accurata, precisa, quasi ossessiva nella ricerca della “parola giusta”, di un’esperienza a suo modo estrema. Non è una relazione trionfale. Di questa sobrietà, che non è il più piccolo dei suoi pregi, le siamo grati.
Fari di terra
Potremmo dire che ciò che caratterizza il faro non è tanto l’essere sul o nel mare, quanto l’essere segregato, lontano da ogni distrazione: una concentrazione obbligata. Essere (quasi) irraggiungibile è la sua prerogativa. Il faro deve stare su un’isola; al massimo una penisola smilza e desertica. Più piccola l’isola – idealmente, uno scoglio –, più desertica la penisola, tanto più il faro è faro. Deve costituire una situazione estrema, in modo che i rapporti fra le cose si estremizzino. Come l’ottica, il complesso sistema di lenti della lanterna, moltiplica infinitamente una piccola sorgente di luce, così il faro enfatizza e mostra nei loro tratti reali fenomeni di cui non si aveva che una generica e distorta conoscenza.
Non ci si stupirà, allora, di trovare fari anche nel mezzo della terraferma.
Anza-Borrego, California (sguardo sulla Storia / 1)
…somewhere south of nowhere in the Sonoran Desert or maybe it was the Mojave Desert or another desert altogether.
Point Omega, romanzo breve, enigmatico, difficile, che Delillo pubblica nel 2010, mette in scena la tarda estate 2006 di due uomini – uno anziano, l’altro molto più giovane: un regista agli inizi della carriera – nella casa malandata che il primo possiede in qualche deserto della California, lontano da ogni agglomerato urbano/umano.
La casa era un triste ibrido. Un tetto di lamiera ondulata sopra la facciata rivestita in legno, sul davanti un vialetto di pietra lasciato a metà e da un lato sbucava un terrazzone aggiunto in un secondo momento. Era lì che stavamo, seduti, durante quella sua ora di quiete, il cielo, un bagliore di torcia, la vicinanza di colline appena visibili nel bianco accecante del meriggio.16
“Quella sua ora di quiete” è il tramonto, ora in cui emergono i contorni di un paesaggio apocalittico, altrimenti quasi invisibile nel bagliore bianco del mezzogiorno. La terrazza è il cuore della casa e del racconto, il luogo in cui generalmente si svolgono le conversazioni fra i due uomini. I temi, su sfondo di invasione dell’Iraq, sono la teoria dell’evoluzione secondo Teilhard de Chardin (da cui il titolo), la stanchezza della coscienza giunta al capolinea, la forza incoercibile della materia, il tempo. Durante il giorno, mentre il giovane fa escursioni nel deserto, l’anziano non si muove dalla terrazza – guardiano del faro ancorato alla sua postazione:
Io guidavo e osservavo. Lui rimaneva a casa, seduto in una striscia d’ombra sul terrazzo scricchiolante, a leggere. Io mi addentravo nelle fessure dei canyon e su sentieri non riportati nelle cartine, […] mi fermavo sui promontori sotto un sole proibitivo, mi fermavo e osservavo. Il deserto era al di là della mia portata, era un essere alieno, era fantascienza, saturante e remoto al tempo stesso, e io mi dovevo sforzare per convincermi di essere veramente lì.
Lui sapeva dov’era, sulla sua sedia, cosciente del proto-mondo, così pensavo io, dei mari e delle barriere rocciose sommerse di dieci milioni di anni fa. Chiudeva gli occhi, divinando in silenzio la natura delle estinzioni più recenti, pianure erbose su libri illustrati per bambini, una regione pullulante di cammelli felici e zebre giganti, mastodonti, tigri dai denti a sciabola.
L’estinzione era uno dei suoi temi ricorrenti in quel periodo. Era il paesaggio a ispirargli i temi.17
L’anziano, Richard Elster, è un linguista, un accademico prestato al Pentagono; il suo compito era individuare parole che inquadrassero – che dicessero – l’impresa dell’invasione dell’Iraq in modo inedito, non mutuato dalle narrazioni di guerre precedenti, adeguato alla fondamentale incomparabilità del presente. Dopo un certo periodo abbandona e si ritira, non perché sia contrario alla guerra – non lo è affatto – ma perché si rende conto di non poter esercitare sull’apparato militare la funzione di “guida teorica” che aveva immaginato. Ora, dalla terrazza nel mezzo del deserto, “divina” estinzioni: non solo le recenti ma anche quelle a venire:
– Vogliamo essere la materia inerte che eravamo un tempo. Siamo l’ultimo miliardesimo di secondo dell’evoluzione della materia. […] Non facciamo che inventare leggende popolari sulla fine. La diffusione di malattie animali, tumori contagiosi. Che altro?
– Il clima, – dissi io.
– Il clima.
– L’asteroide, – dissi.
– L’asteroide, il meteorite. Che altro?18
Si può discutere se l’adesione a una guerra il cui scopo, secondo Elster, è riaffermare la potenza dell’America dopo la ferita delle Torri Gemelle, sia o no in contraddizione con il suo fascino per le estinzioni; innegabile tuttavia che dalla terrazza il vecchio scruti la profondità del tempo. Incapsulato nel tempo storico, deluso dall’impossibilità di esercitarvi un’influenza, si rifugia nell’inanità del tempo geologico, nell’ineluttabilità del tempo escatologico.
Tema delle conversazioni non significa però tema o addirittura tesi del romanzo. Tanto più che i monologhi sapienziali (e narcisisti) di Elster vengono a un certo punto a arenarsi – a sbriciolarsi – contro il fatto dell’improvvisa sparizione della figlia.
Il thriller – irrisolto – è a sua volta inserito fra un capitolo iniziale e un capitolo finale in cui un tizio senza nome passa le giornate nella sala di un museo newyorkese, davanti a uno schermo su cui scorre la proiezione, rallentata fino a durare ventiquattro ore, dello Psycho hitchcockiano. È possibile che questo tizio, che forse si chiama Dennis ma non è sicuro, conosca la figlia dell’accademico. Se la ragazza è morta, cosa che non sappiamo, forse è stato lui a ucciderla. O forse no. Come dicevamo, romanzo difficile. Quel che ci interessa rilevare però è come dall’isolamento e dalla sopraelevazione della terrazza, sorta di faro nel deserto, sia possibile una visione generale, sicuramente soggettiva ma conclusa e coerente, mentre l’esame ravvicinato delle singole cose, diciamo l’esame in cui l’osservatore si trova sul loro stesso piano spazio-temporale: il deserto agli occhi dell’uomo che lo percorre, le investigazioni sulla scomparsa della ragazza, si arrestano sulla soglia dell’enigma.
Potrebbe sembrare un truismo, una riproposta della banale constatazione che per vedere (e valutare) le cose nelle loro corrette proporzioni è necessaria una certa distanza e una certa presa di distanza. È anche in fondo l’idea che emerge, pur con rilevanti sfumature, dalla prima parte di nostri vagabondaggi – che si conclude però, lo ricordiamo, nel 1967. Nella prima decade del nuovo millennio le cose sono molto diverse: la visione complessiva che si genera nell’anziano accademico a partire dalla sua postazione isolata e sopraelevata non è né migliore, né più corretta, né in alcun modo preferibile all’enigma dei singoli dati di una realtà ravvicinata. Anzi: ciò che accade è che la visione complessiva non regge il confronto, non sostiene l’urto, si sfascia (l’accademico, letteralmente, si sfascia) contro l’incomprensibilità dei fatti, contro il loro rifiuto a lasciarsi ordinare in una struttura razionalmente o emotivamente soddisfacente. Una impossibilità che comprende alla fine l’intero romanzo: il film che il giovane regista vorrebbe realizzare e che è il motivo del suo soggiorno nel deserto – un unico piano sequenza in cui Elster parli a ruota libera, senza intromissioni o interlocutori, della guerra e della sua esperienza al Pentagono – non si farà.
Fine della funzione dei fari, sostituiti anche nella metafora da quella che, per l’utente, è la cecità del Gps? Vediamo.
Bergland, Turingia (sguardo sulla Storia / 2)
Steffen Popp, nato a Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern nel 1978, quando il Mecklenburg-Vorpommern era ancora DDR, cresciuto a Dresda, domiciliato a Berlino, di professione poeta19, pubblica nel 2006 il romanzo Ohrenberg oder der Weg dorthin (“Ohrenberg o la strada per là”), al momento il suo unico romanzo. Lingua strepitosa, accostamenti inediti, sintassi molto personale; il romanzo di un poeta: piuttosto esigente nei confronti del lettore. Non credo sarà tradotto; non che non lo meriti, però troppo impervio per il mercato.
Possiede anche un sottotitolo: Historische Ansichten und Denkmale des Grafen Ohrenberg, nebst einer Wegbeschreibung seines Sekretärs Aschmann (“Opinioni storiche e pensieri memorabili del conte Ohrenberg, unitamente a una relazione di viaggio del suo segretario Aschmann”), che non può non ricordarci il gatto Murr di hoffmanniana memoria20 e dunque un atteggiamento di base romantico-ironico.
Se da un lato il sottotitolo annuncia una certa “posa” stilistica, quasi il vezzo (giovanile?) di un autore che mischia volentieri arcaismi e erudizione al quotidiano e parlato, dall’altro ci dà una prima indicazione del contenuto. Vi troveremo historische Ansichten: opinioni storiche, punti di vista sulla storia di un tal conte Ohrenberg21; ma ve le troveremo perché Aschmann, un tempo segretario del conte dal quale è stato separato nel caos dell’immediato dopoguerra, è riuscito ora, nei suoi vecchi anni – orientativamente fine degli anni novanta del secolo scorso –, a ritrovarne la traccia: Ohrenberg, anch’egli ormai molto anziano, vive in Turingia, in una regione montuosa e un po’ selvaggia, in una torre della radio eretta dai russi, e fino al crollo dell’Unione Sovietica occupata dagli stessi allo scopo di spiare le comunicazioni a ovest della cortina di ferro. Aschmann parte quindi da Helsinki22, dove si è ritirato dopo una vita sballottata fra est e ovest, allo scopo di annullare la separazione arbitraria operata dalla storia e ricongiungersi con il conte.
Il romanzo alterna i capitoli dedicati al viaggio di Aschmann (personaggio complementare a Ohrenberg, ma che siamo costretti a lasciare nell’ombra) a quelli in cui Ohrenberg, avvertito tramite telegramma dell’arrivo del segretario, sale alla sua residenza: la torre eretta sulla sommità di un’altura in mezzo al bosco; di lì alle sue stanze in cima alla torre e alla piattaforma di trasmissione da cui partivano i discorsi “che da questa torre immettevo nella rete radiofonica: parole di rivoluzione, verità e nuovi mondi che ho annunciato fin che ho avuto a disposizione la necessaria tecnica”23. Capitoli in cui Ohrenberg monologa, ricorda, riflette. Se si considera che le vite dei due personaggi si estendono per un tempo che va dagli anni venti alla fine degli anni novanta, si può facilmente ammettere che il “Weg dorthin” del titolo, “la strada per là”, “il cammino verso quel punto” abbia un significato storico oltre che banalmente geografico. Com’è che siamo arrivati dove siamo? Una valutazione, un bilancio, una resa dei conti: a questo la visita annunciata di Aschmann sprona o meglio costringe Ohrenberg.
Una valutazione e un bilancio dell’esistenza del conte: intellettuale e scienziato, specialista del funzionamento del cervello ma con uno spiccato interesse per una corretta organizzazione sociale, leggi utopia; negli anni settanta transfuga verso il blocco sovietico per tedio e nausea dell’Occidente24; appena oltre il confine, e cioè nei boschi della Turingia occidentale, intercettato dai russi della guarnigione e trattenuto per precauzione nella torre della radio, dove peraltro si trova benissimo e che anzi sfrutta per inviare i suoi messaggi attraverso l’etere. Ma valutazione e bilancio anche di un secolo, il Novecento, che di organizzazioni sociali antitetiche e nemiche, e delle diatribe sulla rispettiva eccellenza, ha fatto il suo tema e il suo motore; un motore che in quegli anni novanta ha definitivamente smesso di girare, così come la preoccupazione per una corretta organizzazione sociale, leggi utopia, pare uscita dall’orizzonte del pensiero.
Le centinaia o migliaia di ore di arringhe e sermoni che Ohrenberg ha sparato nella rete radiofonica sono registrate su nastro e ordinatamente archiviate – così come più tardi, quando i russi se ne vanno e si portano via tutta la tecnica di radiotrasmissione, i monologhi che Ohrenberg continua a affidare a un registratore:
Da qualche parte nel suo archivio Ohrenberg ha conservato questi pensieri: là nell’armadio metallico, appesi in uno schedario attendono la sua morte, attendono un funzionario paziente – il materiale, là c’è tutto, tutto ancora da valutare: l’eterna rimodulazione del mio sistema, seppure non ne sia emerso che una specie di enigma, si sia sviluppato, abbia raggiunto il pieno rigoglio e sia avvizzito, dio! – lo spirito di Ohrenberg, dopo eterne battaglie per logica e amore, è un deserto, una rapa sfatta, un campo di cetrioli calcinato.25
Vegliardo robusto e ostinato, è però sempre più consapevole dell’inanità della sua impresa; tanto più ora che i russi si sono portati via la strumentazione:
Più o meno sono di nuovo al punto in cui ero prima della guerra: su questa torre di trasmissione decapitata non sono più il conte Ohrenberg, non sono più nemmeno il Dottor Ohrenberg, solo e soltanto Ohrenberg, e le mie orecchie, su questo monte, sono sorde – sono sorde, pensa Ohrenberg: si accorge che pian piano il suo monologo comincia a stancarsi, e lui stesso si stanca, e si stancano le parole insieme al suo corpo, il corpo dal quale sono sgorgate – dapprima come un flutto impetuoso, poi più simili a un fiume, alla fine soltanto un rivoletto, uno di quei rivoletti che scorrono giù per i pendii nei solchi scavati dall’erosione, dopo l’inverno […].26
Il faro di terra, divenuto sordo e muto, non capta nulla né è in grado di inviare proposte di riorganizzazione complessiva, per quanto costantemente rimodulate. Come si è arrivati a questo? “Il conte Ohrenberg ha scomposto il mondo nelle sue parti semplici, ma non gli è riuscito di riassemblarle in un nuovo contesto.”27
Al riassemblaggio, così come al ricongiungimento con Aschmann28, non si arriverà. Se nel romanzo di Delillo la visione complessiva dall’alto della terrazza-faro c’è ancora, ma non regge l’urto della realtà, in questo di Popp la strutturazione dei singoli elementi in un contesto globale non è più possibile e Ohrenberg, sulla sommità della torre, oltre che sordo è cieco, come tutti noi.
Il romanzo si chiude su un fallimento – con una possibilità ironica di serenità: osservando l’alba invernale dalla piattaforma di trasmissione,
il conte Ohrenberg socchiude gli occhi, osserva la stella di calcestruzzo che dal basamento della torre artiglia la cima tondeggiante della montagna, poi guarda lontano: stende il viso nel sole che sorge piccolo e invernale sopra il paesaggio boschivo, che emana dura luce splendente.29
Poiché è impossibile stringere – o artigliare – le cose in una struttura concettuale, non resta che cedere alla loro singolarità.
Conclusioni (?)
Voler trarre delle conclusioni da un vagabondaggio au bonheur du hasard è metodologicamente azzardato. Non possiamo tuttavia fare a meno di notare che dagli ultimissimi anni del XIX secolo alla prima decade del XXI siamo passati, riguardo ai fari e assimilati, da un simbolismo fortemente letterario (Rachilde, Woolf), a un esistenzialismo fenomenologico (Abraham), a una meditazione sulla storia con conclusione sull’irrazionalità e casualità della medesima (Delillo, Popp).
È possibile, in effetti, che i fari – la visione diretta, il riassemblaggio delle parti del mondo – siano diventati obsoleti, e che siamo definitivamente entrati nell’era cieca del Gps.
Note
- Rachilde (1860-1953), poco nota in Italia (ma Monsieur Vénus è tradotto e in commercio) e un po’ dimenticata anche in Francia, fu ai suoi tempi scrittrice di successo – al ritmo di uno, due titoli l’anno – e letterata influente. Sposò Alfred Vallette, direttore della rivista simbolista Mercure de France, e fu col marito co-fondatrice delle edizioni omonime. Animatrice di un importante salotto letterario, fu aperta agli stimoli e alle nuove correnti, ma anche risolutamente antifemminista, sciovinista e xenofoba.
- Rachilde, La tour d’amour, Éditions Points 2023, p. 147. Non mi risultano traduzioni italiane. Questa, come la traduzione delle citazioni seguenti, è mia. Qui in particolare il problema è che il mare, in francese, è di genere femminile (“La mer délirante bavait …”). Il genere grammaticale sostiene tutta una serie di immagini e alla fine una macrometafora, in cui sono inglobati i due guardiani, che naturalmente non sta in piedi se, in italiano, parliamo del mare – maschile. Ho ripiegato su ‘distesa d’acqua’.
- Ibid. p. 164
- Ibid. p. 181
- La meteorologia, afferma il padre, non consentirà.
- Virginia Woolf, Gita al faro, trad. Anna Nadotti, Einaudi 2014, p. 186
- Ibid. p. 63
- Precisamente alla fine del penultimo capitolo. L’ultimo, brevissimo, è occupato dalla benedizione che l’arte impartisce a ciò che esiste. Gran sacerdote lo schivo poeta Carmichael, concelebrante la pittrice Lily Briscoe.
- “Ah, ma era sollevata. Qualunque cosa avesse voluto dargli, quando l’aveva lasciata quella mattina, gliel’aveva infine data” (p.208)
- Forse la famosa frase del padre, come la ricorda James: “Pioverà […] Non potrai andare al faro” (p.186) nasconde una minaccia di castrazione? Non sono in grado di avventurarmi su questa pista.
- La prima parte del romanzo – la più lunga, la più densa, dominata dalla figura della signora Ramsay – si chiude con la frase: “E lei lo guardò sorridendo. Perché aveva trionfato ancora una volta.”
- Ma in tedesco è tradotto. Armen ha avuto due distinte edizioni: Der Leuchtturm, Jung und Jung Verlag, Salzburg 2010, e per lo stesso editore l’altra recentissima, arricchita di una postfazione della traduttrice, del 2024. Sempre per Jung und Jung è uscito nel 2012 Der weiße Archipel, traduzione di Fort-Cigogne, récit del 1996.
- Suscitando lo scandalo e perfino la collera del collega, fra gennaio e febbraio Jean-Pierre decide di non scendere a terra nei dieci giorni di riposo fra un turno e l’altro. Passerà nel faro più di cinquanta giorni di fila. D’altra parte, se ha deciso che il faro è il posto giusto per lui, quei giorni a terra sono un esilio: “Ieri sera sono andato a letto presto. Martin aveva il primo quarto di guardia. Non ne potevo più, dopo quei dieci giorni e quelle dieci notti a terra. Quanto tempo mi ci vorrà per riemergere?” Jean-Pierre Abraham, Armen, Éditions Payot & Rivages, 2021, p. 37. La traduzione di questa come delle altre citazioni da Armen è mia.
- Ibid. p. 76. La lampada di cui si parla è a petrolio, così come a petrolio era il fuoco del faro. La scena e il lessico ricordano la Maddalena penitente di Georges de la Tour.
- Ibid. p. 101
- Don Delillo, Punto Omega, trad. Federica Aceto, Einaudi 2019, p. 18
- Ibid. p. 19-20
- Ibid. p. 47
- Dal 2004 ad oggi quattro raccolte di poesie pubblicate presso l’editore Kookbooks di Berlino e apprezzate dalla critica.
- E.T.A. Hoffmann, Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern (“Le idee sulla vita del gatto Murr unitamente a una biografia frammentaria del maestro di cappella Johannes Kreisler su fogli di carta straccia”).
- I lettori di Steffen Popp conoscono questo nome dalla sua prima raccolta di versi, Wie Alpen. Nella postfazione in forma di pastiche, un tale Anders Winterer, dietro cui si cela Popp stesso, cita ampiamente dalle opere di un inesistente Spee von Ohrenberg, anch’egli un alter ego dell’autore.
- Occidente, ma con vista sulle luci di San Pietroburgo. (Questo nel 2006).
- Steffen Popp, Ohrenberg oder der Weg dorthin, Kookbooks 2006, p. 48, la traduzione di questa e delle altre citazioni è mia. Quale sia la “verità” di Ohrenberg e quali questi “nuovi mondi” non viene però detto. Il riferimento è, credo, ai marxismi utopici che si sono sviluppati in Occidente dopo la delusione dei socialismi reali.
- Con le sue precise parole: “spinto dalla collera, tormentato dal dubbio, turlupinato dall’utopia, andai dritto a est […], feci rotta per la Russia, puntai su Mosca, col favore delle tenebre attraversai il confine con la Germania est”. (p. 126. In Russia, però, non arriverà mai.)
- Ibid. p. 48s. In tutto il romanzo la narrazione passa senza soluzione di continuità dalla terza alla prima persona.
- Ibid. p. 56. Nel testo originale c’è un gioco di parole fra le orecchie (Ohren), il monte (Berg), e il nome del personaggio: Ohrenberg.
- Ibid. p.140
- In un’intervista del 2013 (Gespräch mit Steffen Popp 1 – 0,0,Signaturen) Popp suggerisce la possibilità che Ohrenberg e Aschmann siano in realtà un’unica persona: “In fondo però c’è una dissolvenza dei due personaggi uno nell’altro, e la fine lascia spazio alla possibilità che siano la stessa persona.”
- Ibid. p. 144. È la conclusione del romanzo.
Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Elena Grammann