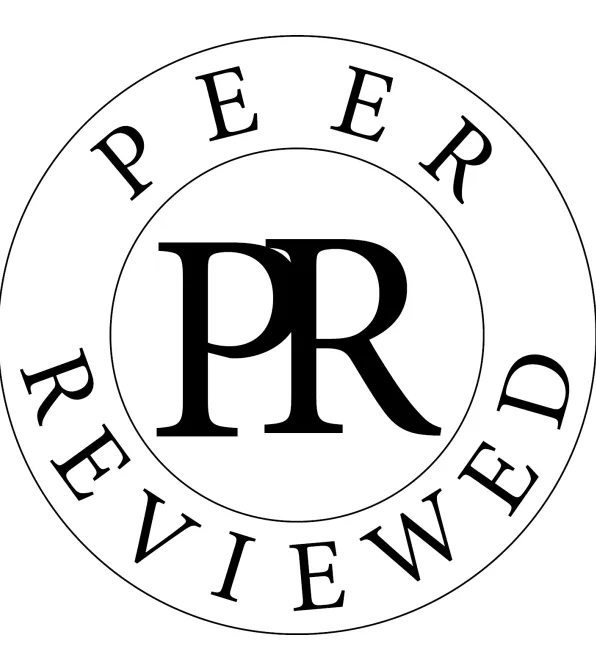Nuovi fari nel Mediterraneo

Ivana Baldi, Liana Baldaccini, Maria Rosaria Catino, Nuovi fari nel Mediterraneo, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 58, no. 9, dicembre 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.12387
Introduzione
Nel passato i fari erano stati progettati e costruiti per aiutare i marinai a trovare un porto sicuro e accogliente. Erano costruzioni enormi non solo perché dovevano essere viste da molto lontano, ma anche per sottolineare l’importanza della loro funzione.
Oggi, nonostante la tecnologia rappresentata dai cellulari che spesso permettono ai soccorritori di individuare la posizione delle imbarcazioni in difficoltà, navigare di notte nel Mediterraneo è sinonimo di pericolo, di incertezza e di cupa oscurità. «Un gommone viaggia al buio, si nota appena una fievole luce bianca intermittente, la torcia di un cellulare, di solito. Un peschereccio al confronto è una luminaria di Natale: c’è il fanale di testa d’albero, la luce verde di dritta, la luce rossa laterale di sinistra. Un peschereccio brilla troppo per essere una barca di disperati che cerca di non farsi notare dalla Guardia Costiera libica e naviga nell’oscurità»1.
Occorre, dunque, trovare nuovi fari per illuminare il Mediterraneo: i fari della pietas, dell’accoglienza, della solidarietà.
È lo spazio emotivo ed empatico che dovrebbe essere riconsiderato e rafforzato attraverso il racconto di storie che hanno un grande potere in chi legge e in chi ascolta. Esse fanno dilatare la nostra sensibilità e ci aiutano ad immaginare con maggior precisione che cosa significhi essere uomini e donne in situazioni molto diverse dalla nostra, ma che, come noi, affrontano l’avventura della vita nella speranza di trovarvi felicità e di riuscire a determinare il proprio futuro2. Questi fari vanno costruiti piano piano nelle menti dei bambini e dei ragazzi che diventeranno così futuri cittadini capaci di “ospitare” nella loro coscienza lo straniero, di accudirlo e di ascoltare le sue storie. In questo modo si può stabilire un contatto empatico con l’altro che porta anche ad un arricchimento personale.
Noi come insegnanti ci siamo chieste quali strumenti abbia la scuola per illuminare il Mediterraneo con i fari della pietas, dell’accoglienza e della solidarietà. Lo strumento privilegiato ci è sembrato il racconto, in particolare quello per immagini, perché lascia la possibilità di dare alla storia una voce arricchita con il proprio vissuto, le proprie emozioni e i propri pensieri.
Il progetto didattico che segue si basa sul volume di Armin Greder intitolato Mediterraneo, una narrazione senza parole, un albo illustrato in bianco e nero. Come ricorda nella postfazione Alessandro Leogrande
«[…] il confine fra il mondo di qua e il mondo di là appare più incerto. Se da una parte i viaggi iniziano molto prima del fatidico approdo sulle nostre coste e, a loro volta, sono fatti di attesa, violenza, paura, sogno, condivisione, dall’altra il nesso tra le responsabilità alla base della loro origine e il cumulo di morti in fondo al mare si rivela in tutta la sua chiarezza»3.
Il racconto muto di Mediterraneo è la denuncia contro una certa indifferenza del genere umano verso quanto accade quotidianamente nel continente liquido rimanendo «intorno alle rive del mare come rane o formiche intorno a uno stagno», così diceva Platone, per bocca di Socrate, nel Fedone (II, LVIII).
Lo stesso sentimento viene espresso anche nel recente film vincitore del premio Oscar “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, che, prendendo come spunto il genocidio del popolo ebreo nei campi di concentramento in epoca nazista, arriva a generalizzare il concetto alla situazione attuale denunciando una sorta di anestesia collettiva.
Mediterraneo illustra il viaggio di speranza e di ricerca di un approdo sulle coste del continente Europa, alla ricerca del faro che illumini la terraferma e l’attesa dell’accoglienza sul territorio. Ma il naufragio fa emergere un corpo senza vita «[…] uno dei tanti nelle acque del Mediterraneo, del nostro mare. Osceno pasto di pesci che imbandiranno le nostre tavole. Commensali, nostri commensali, voraci e spietati mercanti di morte. Cariche d’armi, le loro navi, sicure, solcheranno da nord a sud le acque del Mediterraneo, del nostro mare. Armeranno mani fratricide, dilaniando e svuotando villaggi, regioni, stati. In fuga, interminabili carovane di uomini donne bambini attraverseranno deserti di sabbia e di pietre»4 .
Le immagini del libro di Greder sono molto suggestive e forti, ma nello stesso tempo hanno i contorni poco definiti e questo contribuisce a lasciare spazio alla creatività e all’immaginazione.
Come ha scritto Schopenhauer «[…] I pensieri messi su carta, in fondo, non sono altro che la traccia sulla sabbia di un viandante: è vero, si vede la via che egli ha seguito, ma per sapere che cosa abbia scritto sul suo cammino bisogna adoperare i propri occhi»5.
Il Progetto
Il progetto Mediterraneo è stato realizzato dall’Istituto Comprensivo di Pianoro (Bo) e, precisamente, rientrava nel PON “CARE” 2023 con l’obiettivo di “prendersi cura” degli alunni con difficoltà anche linguistiche perché non italofoni. Al progetto hanno aderito molti alunni stranieri provenienti dalla Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’I.C. Pianoro. Data la diversa età e provenienza degli alunni si è cercato, fin dall’inizio, di riservare uno spazio ricreativo in cui i ragazzi potessero conoscersi meglio e questo ha fatto sì che si creasse un gruppo coeso e compatto in cui gli alunni fossero capaci di collaborare tra loro per raggiungere l’obiettivo comune.
Il percorso è iniziato partendo dal loro vissuto attraverso un brainstorming sulla parola Mediterraneo. I ragazzi hanno cominciato ad elencare parole che ricordavano le loro vacanze appena trascorse: conchiglie, pesci, sabbia, sole, giochi… Insomma tutte parole per ricordare momenti di gioia, spensieratezza e felicità.
Poi è stato introdotto il discorso storico inizialmente attraverso il video di presentazione del libro di Mario Tozzi, Mediterraneo tra mito e realtà, che è la storia del Mare Nostrum raccontata dai suoi abitanti tramite il mito e la sua origine attraverso cui gli uomini hanno cercato di chiarire alcuni aspetti fisici della realtà, che gli antichi non potevano spiegare in altra maniera, se non costruendo dei racconti. Tozzi racconta tutti i passi di una storia affascinante e millenaria che, in qualche modo, sconvolge il nostro punto di vista e ci riporta alla natura vera e propria, intesa come fenomeno quasi inspiegabile agli occhi di un essere umano.
Successivamente sono state illustrate, attraverso la carta del Mediterraneo, alcune civiltà importanti che sono nate sulle coste di questo mare e di come si utilizzassero le sue acque e per commerciare, ma anche per conoscere nuove popolazioni.
Infatti, come è noto, fin dalle origini
«[…] le comunità umane si sono incontrate lungo vie terrestri e fluviali e sugli approdi delle rotte marine, avviando relazioni che hanno consentito conoscenze reciproche, scambi di merci e dialoghi tra le diverse culture ampliandone gli orizzonti. Con i loro spostamenti esploratori, conquistatori, mercanti, profughi, banditi, corsari, viandanti, pellegrini, studenti, turisti, hanno intessuto nei millenni il variegato e ricco mosaico culturale dei continenti. Partendo dalle relazioni tra nomadi e sedentari, passando da fasi di invenzione, sviluppo a quelle di tracciamento e fissazione, le vie della storia hanno intrecciato il reticolo di itinerari che attraverso strade e rotte hanno contribuito a delineare i caratteri dei soggetti in movimento: da coloro che percorrevano le vie della fede, a chi conduceva traffici mercantili. In tale contesto il mare ha rappresentato nei millenni uno dei principali vettori di scambi rendendo i porti luoghi cruciali per l’economia»6.
Ognuno di noi, pertanto, è unico ed irrepetibile, perché è il risultato della confluenza delle eredità del passato con i contesti e gli influssi del presente. Questa consapevolezza servirebbe a far acquisire maggior rispetto per noi stessi e per gli altri. Pensare in quest’ottica significa riflettere sul fatto che, quando due persone si incontrano, a incontrarsi sono due storie così profonde e uniche e allo stesso tempo così condivise e legate, che la conoscenza reciproca può divenire un’esperienza affascinante.
Dunque, conoscere sé stessi e, di conseguenza, gli altri costituisce da sempre uno dei migliori antidoti all’incomprensione e a ll’ostilità, alla difficoltà di comunicare e all’isolamento7.
Per le civiltà del passato l’accoglienza era molto importante perché per loro l’ospite era sacro. A questo proposito è stato letto ed analizzato il brano dell’ Odissea relativo all’incontro tra Ulisse e il gigante Polifemo che rappresenta un momento cruciale della narrazione in cui il protagonista rischia di soccombere proprio perché l’ospite non rispetta i rituali dell’accoglienza.
Richiamare le antiche narrazioni compararle con le storie del presente significa afferrare l’emozione della magia della nostra storia; i racconti della nostra cultura; le parole e le immagini del nostro passato per salire sulle “spalle del gigante” e progredire nella naturale predisposizione dell’uomo di raccontarsi8.
Il passo successivo è stato quello di aprire un’altra prospettiva relativa al
Mediterraneo attraverso la musica. È stato scelto il brano di Mango “Mediterraneo” in cui oltre a descrivere i paesaggi, i profumi, i suoni di questo mare si accenna anche al Mediterraneo come luogo di sofferenza e di morte. Dopo aver analizzato il testo di questa canzone è stato chiesto ai ragazzi di realizzare un caviardage.
Si tratta di un metodo di scrittura poetica che aiuta a scrivere poesie e pensieri partendo da testi già scritti: pagine strappate da libri, articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato digitale.
Grazie alla contaminazione con svariate tecniche artistiche espressive (quali il collage, la pittura, l’acquarello, etc.) si dà vita a poesie visive che attraverso parole, segni e colori rivelano emozioni difficili da esprimere nel quotidiano.
Tutte queste attività sono state propedeutiche alla visione del libro di Greder Mediterraneo sono state utili per preparare il terreno in cui “piantare” e far capire un testo complesso come quello di Greder.
La comprensione è, infatti, un’arte: qualcosa di cui ci si appropria pian piano, progettando esperienze graduate e progressive di contatto diretto col testo evitando la mediazione preventiva di commenti e spiegazioni inutili se prima il lettore non ha la possibilità di attivare i suoi concetti spontanei e di mobilitare il suo repertorio contestuale. Il senso non è nel testo, ma nel “dialogo con il testo”. Nel testo ci sono le tracce da seguire e la costruzione del senso richiede un lettore capace di “adoperare i propri occhi”. Il senso è, infatti, un’architettura che si riempie, nel suo farsi, di voci, di storie, di luoghi, di immagini, di pensieri; la sua logica non prescinde dalla dimensione emozionale e cerca un lettore disponibile a risvegliare esperienze, conoscenze, altri testi, per rendere la visione adeguatamente complessa. È il lettore, non l’insegnante che deve poter scegliere, tra le molte tracce, quelle su cui camminare e non possono che essere del lettore la mobilitazione dei saperi e l’azione immaginativa indispensabili alla comprensione che viene pazientemente conquistata e rimane sempre provvisoria. L’insegnante non può sostituirsi al lettore deve, invece, sostenerne e strutturarne il dialogo9.
Perciò, siccome il libro presenta immagini molto forti, si è deciso di non commentare, come adulti, le immagini, ma di lasciare libero spazio alle voci dei bambini.
È stato necessario presentare il libro più di una volta affinché i bambini riuscissero a trovare le parole giuste per raccontare la storia. Lasciando spazio all’interpretazione dei bambini anche le tavole più forti sono state raccontate con parole lievi e delicate laddove quelle degli adulti sarebbero risultate troppo dure.
Una volta inventata la storia, i ragazzi sono stati aiutati a contestualizzarla sia da un punto di vista geografico – prestando attenzione alla morfologia dei territori da cui provengono i migranti con l’ausilio di una cartina dell’Africa -, sia da un punto di vista storico – la distruzione di interi villaggi, la clandestinità, il coinvolgimento degli europei nel traffico delle armi, il tragitto seguito dai profughi, l’utilizzo dei mezzi di trasporto nel deserto e sul mare, gli scafisti… -.
Ad esempio, nel libro c’era anche una persona bianca ed allora i ragazzi si sono interrogati sulle motivazioni di questa presenza. Documentandosi hanno scoperto che in Africa ci sono molte guerre e le armi sono spesso fornite dai bianchi che ci guadagnano molti soldi, anche addestrando gli eserciti africani all’uso delle armi.
Poi gli alunni hanno voluto scoprire che tipo di armi venissero vendute e che percorsi segreti facessero per raggiungere i paesi africani in guerra. In seguito, hanno ricostruito, attraverso le immagini, il cammino che le popolazioni in fuga dalla guerra devono percorrere per arrivare sulle coste dove imbarcarsi verso l’Europa. È un percorso molto rischioso attraverso il deserto in parte a piedi ed in parte con mezzi pericolanti. Gli alunni si sono chiesti anche quali costi debbano sostenere le persone in fuga per poter affrontare il viaggio in mare spesso con imbarcazioni non adatte.
L’albo illustrato da Greder è stato interpretato come una fonte iconografica da analizzare in modo approfondito esaminando ogni dettaglio. Gli alunni sono stati invitati ad osservare con attenzione anche le espressioni dei volti e le posture dei personaggi via via presentati.
In questo modo è stato più semplice capire non solamente le emozioni e i sentimenti dei protagonisti della storia, ma anche come molti soldati africani armati dagli europei siano incastrati in quei complessi ingranaggi del processo migratorio da cui non possono sottrarsi.
Così il protagonista della storia, che i ragazzi hanno deciso di chiamare Abel, è diventato un simbolo, un emblema, un’icona che rappresenta tutti quei ragazzi, tutti quei migranti che, rincorrendo la speranza di un futuro migliore, hanno dovuto vivere la sua tragica avventura e hanno perso la propria vita nel “continente liquido”.
Per questo motivo Abel ha tante voci sia maschili che femminili. Abel, con il suo racconto, ha voluto dar voce a chi voce non ne ha più.
Una volta costruita, la storia è stata registrata e drammatizzata con le voci degli alunni. Non è stato facile perché molti non conoscevano bene la lingua italiana e facevano fatica a pronunciare alcune parole. Però, alla fine, con molta pazienza, ce l’hanno fatta. Si è deciso, di comune accordo, di mantenere eventuali imperfezioni di pronuncia come testimonianza tangibile dell’impegno dei ragazzi e della loro volontà di offrire il proprio contributo.
Il lavoro si è concluso nello stesso modo in cui era iniziato, con la medesima domanda: «Quali parole ci fa venire in mente “Mediterraneo”?». Alle parole che erano state dette all’inizio se ne sono aggiunte altre come: speranza, coraggio, opportunità, paura, morte. Il “continente liquido” può essere rappresentato come un cerchio in cui la fine è anche l’inizio e viceversa, il Mediterraneo è, in verità, quello spazio-tempo nel quale gli opposti coincidono.
Conclusioni
Nel progetto presentato sono state utilizzate diverse fonti perché lo spirito del tempo e la visione della società in qualsiasi parte del mondo non sarebbero comprensibili senza utilizzare fonti di diverse tipologie: letterarie, figurative, musicali, multimediali. Strumenti che dipingono a noi stessi la nostra storia, attraverso un racconto di aspetti di vita privata e di realtà immaginativa. Nello specifico l’utilizzo delle fonti letterarie può aiutare a comprendere che la relazione dialettica passato-presente si traduce nell’interrogare il nostro assetto sociale, caratterizzato sempre di più dalla compresenza nel territorio di diversi soggetti culturali, portatori di identità e di memorie collettive10. Quando si desidera indagare dunque nello studio delle mentalità, dei sentimenti, delle raffigurazioni reali e ideali di una vita privata in una data società, la fonte letteraria è senza dubbio uno dei migliori strumenti per poterli ricercare. La letteratura permette di comprendere le trasformazioni della cultura, dei comportamenti e le motivazioni che caratterizzano i valori di ogni individuo, di ogni gruppo umano in tutte le epoche e territori. In ogni epoca gli spostamenti umani sono stati indotti oltre che da aspirazioni di scambio e di dialogo, anche dalla volontà di sopraffare e di sottomettere con violenza, guerre, invasioni e colonizzazioni che hanno alimentato per millenni riprovevoli traffici di schiavi e che oggi alimentano i terribili viaggi della speranza di tanti migranti.
Durante questa lunga migrazione planetaria, gli esseri umani hanno espanso e dilatato frontiere naturali, hanno, grazie ai progressi tecnologici, esplorato il pianeta solcando mari e tracciando percorsi viari11.
Viaggi che hanno coinvolto movimenti transcontinentali, tra multiculturalismo e interculturalità. Ogni viaggio ha rappresentato l’incontro/scontro con un’altra componente dell’umanità.
Viaggio tra parole, immagini e speranza
Immaginate di ritornare piccoli per un attimo ritrovarvi un bel mattino soleggiato di fine Agosto, nell’aula di una scuola di provincia, insieme ad una dozzina di bambini e ragazzi di età ed addirittura nazionalità differenti, a voi prevalentemente sconosciute e ingaggiate durante l’estate, come voi, da due insegnanti desiderose di farvi fare un viaggio immaginario della durata di circa due settimane attraverso il Mediterraneo e alcune delle sue dinamica, senza ben conoscere, però, il punto di arrivo di questo viaggio.
Ecco questa era la mia situazione, che tra quella dozzina di alunni, dall’alto dei miei tredici anni, ero la più vecchia, anche se come loro ero in attesa di salpare ed ero all’oscuro delle tappe che ci avrebbero accompagnati a spasso per il Mediterraneo nei giorni successivi.
Eravamo confusi e ansiosi di iniziare, alcuni di noi non parlavano bene l’italiano e probabilmente tutti rimpiangevamo un po’ le nostre vacanze da poco terminate, eppure la curiosità era il filo conduttore che ci univa e ci chiedevamo se, alla fine di quelle due settimane, avremmo davvero imparato a conoscere meglio il Mar Meditteraneo e, soprattutto, se avremmo compreso a fondo la sua importanza e alcune delle sue dinamiche principali.
Il nostro viaggio iniziò così, partendo da quello che il Mediterraneo rappresentava per noi (cosa se non sole, spiaggia e giornate in compagnia?), sino a ciò che storicamente il Meditteraneo rappresenta, ovvero una culla di civiltà e un’immenso luogo si scambio e incontro di una miriade di diverse culture, storie e tradizioni, che hanno una entità unica nella Storia e che hanno permesso alle aree geografiche che lo circondano di essere uniche. Un luogo dunque di opportunità e di scoperta (come raccontano le vicende dell’Odissea, opera analizzata in classe che forse meglio di tutte racconta la visione del Meditteraneo che gli antichi avevano di esso, e che tutt’oggi fa parte del nostro immaginario) ma anche di morte, concetto affrontato per la prima volta attraverso la canzone “Mediterraneo” di Mango.
Un Mediterrano di morte che tendiamo ad ignorare, che speriamo non esista, e che ci convinciamo sia una bufala lontana dalla realtà, sebbene le cronache ci dicano il contrario quotidianamente e nonostante queste ci tocchino più da vicino di quanto possiamo anche solo pensare. Un Mediterraneo di morte che nasce come una ricerca della speranza, una ricerca di nuove opportunità da parte di uomini, donne e bambini come noi che decidono di affrontare un viaggio fatale per non perire comunque, ma molto più lentamente, in una realtà fortemente disagiata, dalla quale sono costretti a scappare anche attraverso i deserti, che nonostante tutto non li scoraggiano, nel desiderio di una vita migliore. Vita migliore che spesso, troppo spesso, finisce sott’acqua, tra centinaia di altri corpi con trascorsi simili ma diversi, tra i detriti di una barca forse troppo vecchia, forse troppo malandata.
Ecco dunque che il viaggio non è più così immaginario e diventa spontaneo chiedersi quante storie diverse sono unite da uno stesso destino o, addirittura, quali fossero le vicende personali che si sono intrecciate tra loro in una tragica fine. Perché è come se solo quando avvertiamo la morte vicina riusciamo a percepire delle sfumature della vita che ci sono sempre state sconosciute, al punto di chiederci se in qualche modo anche le nostre vite, o quelle delle persone che conosciamo, sono legate a quelle tante che muoiono in mare. Così anche il rapporto con i compagni di progetto (o sarebbe meglio dire di viaggio?) assume un significato completamente diverso: si lega, ci si conosce, ci si interessa gli uni agli altri e si cerca di entrare nel vissuto e nelle storie di ognuno di loro, scoprendoli spesso profondamente simili a noi.
Armin Greder, nel silent book “Mediterraneo” fa proprio questo: con un tratto scuro, spesso, ruvido ed essenziale, più profondo di mille parole, prova ad entrare nel passato, nelle vite e nelle vicende personali di uomini, donne e bambini come noi che sfidano la morte per il loro futuro, accompagnandoli silenziosamente nel loro viaggio e catturando i loro volti, le espressioni, i pensieri e le emozioni. Ma non le parole. Quelle, abbiamo dovuto scriverle noi, e poi recitare, davanti ad un microfono, per dare voce ad intere generazioni che giacciono sul fondo del nostro (e del loro) Mediterraneo, “con i pesci”, come direbbe Abel, la vera voce di tutti loro, interpretata da tutti noi, ognuno con il proprio passato, il proprio presente e il proprio futuro, uniti però di fronte alla medesima tragedia e molto, molto più simili di quanto ci si potesse aspettare, nonostante le barriere linguistiche, le differenze di età e le differenti religioni, culture e provenienze, non più problemi ma fonti di arricchimento per noi e per il progetto, che hanno contribuito a rendere il progetto quello che è, e, forse, anche a diventare noi partecipanti delle persone migliori.
Chissà quante persone, quante storie diverse sono passate per il Meditteraneo, passano per il Mediterraneo e passeranno in futuro per il Mediterraneo: è impossibile dirlo.
È stato teatro di guerre, commerci, invenzioni, scoperte, viaggi e molte, molte morti. Constatazione, quest’ultima, fatta al termine del nostro progetto quando, tra l’elenco delle parole che per noi rappresentavano il Mediterraneo, è comparsa anche morte, accanto a sabbia, mare e sole.
È anche, insomma, una storia tragica, quella del Mediterraneo. Ma è la nostra storia, la storia dei nostri antenati e quella dei nostri figli.
E il corso della Storia può essere cambiato solo ed esclusivamente da chi la Storia la vive e la crea. La Storia ci sta chiamando. Sta a noi scegliere se risponderle o meno.
Note
- C. Bonvicini Mediterraneo. A bordo delle navi umanitarie, Einaudi, Bologna 2022, p. 132.
- Cfr. Baldi I., Borghi B., Catino, M. R., Illuminare il Mediterraneo, tra ricerca e didattica della storia, “Dialoghi Mediterranei”, n 65 (2024), p. 1.
- Cfr A. Leogrande,” Postfazione”, in A. Greder, Mediterraneo, Orecchio acerbo editore, Verona 2017, pp. 40.
- Ibid.
- Schopenhauer A., Sul mestiere dello scrittore e sullo stile, Adelphi, Milano 1993, p. 27.
- Borghi B., Galoppini L., Andar per lo mondo. Antologia di viaggi attraverso i secoli tra realtà e immaginario, Pàtron, Bologna 2022, p. 1.
- 7 Cfr. Dondarini R., Quel tempo chiamato Medioevo. Mille anni di vicende, trasformazioni e antefatti dell anostra storia, Liguori, Napoli 2012.
- 8 Borghi B., Dondarini R., Manifesto della Didattica della storia, «Didattica della storia», I (2019): Un Manifesto per la Didattica della Storia | Didattica della storia – Journal of Research and Didactics of History
- Cfr F. Frasnedi, Y. Martari, L. Poli, La lingua in laboratorio, Tecnodid Editrice, Napoli 2005.
- Borghi B., La Storia. Indagare, apprendere, comunicare, Pàtron, Bologna 2016.
- Borghi B., Galoppini L., Andar per lo mondo, cit.
tag: Dialogo, Fari, Mediterraneo, Pietas, Viaggi
Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Ivana Baldi, Liana Baldaccini, Maria Rosaria Catino