Pauca, opinor non ingrata, super felicitate. Rileggere il De felicitate di Filippo Beroaldo seniore (1495)
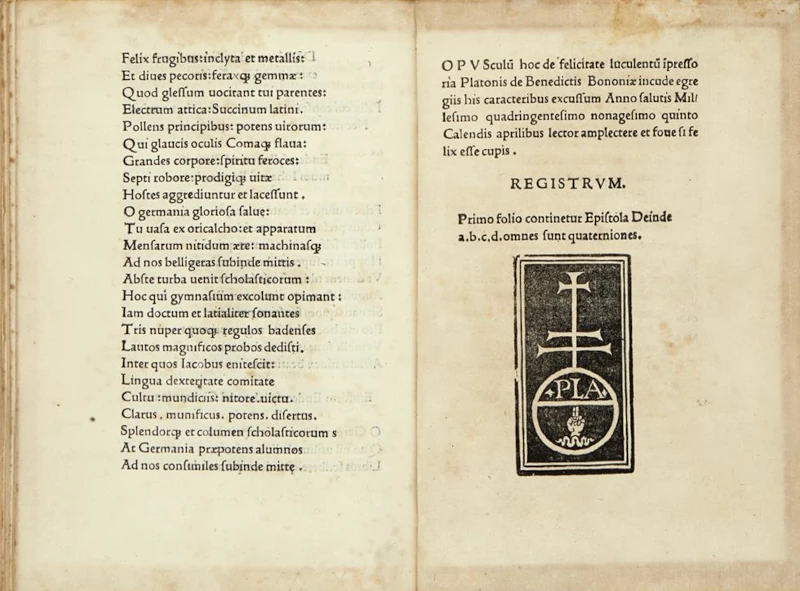
Federico Diamanti, Pauca, opinor non ingrata, super felicitate. Rileggere il De felicitate di Filippo Beroaldo seniore (1495), «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 55, no. 2, giugno 2023, doi:10.48276/issn.2280-8833.10584
Dando avvio all’orazione inaugurale del corso dedicato agli scrittori latini di cose agresti, tenuto presso l’Università di Bologna nell’anno 1494 (gli autori letti e spiegati furono il Virgilio delle Georgiche per la poesia e il De agri cultura di Columella per la prosa), Filippo Beroaldo Seniore1 così si rivolgeva al suo dotto uditorio bolognese:
[1] «Magna res est, viri ornatissimi, et omnibus horis, omnium votis expetita felicitas: huc tendunt cunctorum vota mortalium. Haec est summa curarum, haec est summa rerum expetendarum. Felicitate terminantur nostra desideria. Cui felicitas adest, huic nihili prorsus deest. Inveniuntur qui regna non optent, qui vero felicitatem repudiet nullus existit. Nemo enim non felix esse vult, nemo non felicitatem summum bonorum esse consentit. Quocirca de felicitate humana, tamquam de re rerum omnium maxime expetibili maximeque expetenda, hodierno die dissertare constitui, et in hac dissertatione ex latissimo pratorum virore flosculos non paucos hinc inde decerpere, quorum odoratu olfactantes recreentur»2
Ovvero:
[1] «La felicità, uomini distintissimi, è una gran cosa, ed è desiderata in ogni istante dalle preghiere di tutti; ad essa sono rivolti i voti di tutti i mortali. Questa è la somma delle fatiche umane, questa è la somma delle cose che vanno ricercate. Nella felicità hanno esito i nostri desideri. A chi è felice non manca proprio nulla. È possibile trovare qualcuno che non desideri poteri, ma non esiste nessuno che rifiuti la felicità. Nessuno, infatti, non vuole essere felice; nessuno non concorda nel ritenere la felicità il più grande tra i beni. È per questo che oggi ho deciso di discutere dell’umana felicità – o per così dire della cosa maggiormente desiderabile e agognabile tra tutte le cose umane – e, in occasione di questa dissertazione, di cogliere dall’amplissimo verdeggiare dei prati non pochi fiorellini, dal cui profumo chi li odora sarà ristorato».
Il fulcro tematico dell’orazione appare evidente, ed è ripetuto dall’umanista con una certa retorica insistenza fin dalle prime parole di questo prologo: ci si occuperà della felicità e della sua centralità nella vita degli uomini, sottolineando fin da principio la sua corrispondenza con il summum bonum cui tendono le attività umane e il ‘doppio statuto’ morale del concetto di felicità e della sua stessa ricerca. Essa è infatti da un lato res maxime expetibilis, ma dall’altro lato maxime expetenda in ogni momento della vita. Sia pure non esplicitamente citate dall’autore, emergono già da questi primissimi scorci del discorso le fonti più feconde dell’argomentazione beroaldiana: Seneca con le sue Epistolae ad Lucilium, di cui viene richiamato in modo indubitabile un passaggio assai famoso di una lettera (117, 53) che si rivelerà cruciale per tutto il De felicitate e Plinio il Vecchio con la sua Historia naturalis, oggetto di tante cure umanistiche, che sarà in più di un passaggio dell’orazione non soltanto «enciclopedia di scienze naturali, ma anche miniera di termini e modello di stile»4, un cui celebre passo è sicuramente richiamato dal sintagma omnibus horis5. La trama intertestuale è organizzata mediante un sapiente lavoro di cesello retorico e con quell’abilità oratoria che fu propria di Beroaldo, e particolarmente spumeggiante soprattutto nelle orazioni maggiori. Essa emerge via via in modo sempre più chiaro grazie alla metafora floreale cara già ai retori della classicità e dell’umanesimo (un’immagine non dissimile, seppur in senso contrastivo, avrebbe adoperato un allievo di Beroaldo, Giovan Battista Pio, nel dedicare la sua traduzione metrica dell’Anthologia planudea al Pontefice Paolo III6) ed è rincalzata da una fitta serie di figure retoriche (l’allitterazione di hodierno die dissertare, l’intreccio di negazioni nemo enim non felix, la già ricordata figura etimologica sulla radice del verbo expeto, etc.), che delineano con chiarezza ed ostentata eleganza insieme gli obiettivi e i confini del discorso che Beroaldo tenne al suo uditorio e che volle poi stampare, per i tipi di Platone de’ Benedetti, l’anno dopo la sua pubblica orazione.
Non si sbaglia nell’affermare che all’altezza del 1495 (l’anno di stampa dell’orazione De felicitate) Filippo Beroaldo seniore, molto più del maggiormente appartato e meno prolifico collega Urceo Codro7, non si distingueva soltanto come il più stimato tra i docenti di umane lettere di Bologna, del cui Studio era riconosciuto come il Commentator di testi classici per eccellenza, ma come uno tra gli umanisti più importanti sul panorama nazionale. Anzi, il suo profilo aveva già assunto almeno da un decennio una rilevanza sovranazionale, ben testimoniata da alcuni passi del suo epistolario, che più di altri «è il segno tangibile di una cultura che si organizza che stabilisce rapporti ben definiti, che prende corpo in una società internazionale di dotti», che Eugenio Garin passò in rassegna in alcuni celebri contributi8. Ha da ultimo ben tratteggiato questa straordinaria posizione di Beroaldo Andrea Severi nella sua monografia sull’umanista bolognese e sulla sua fortuna europea, che ha decisamente aggiornato, ampliando in modo significativo il campo di studio, le panoramiche novecentesche sull’umanista9: il più umano di tutti i maestri – così lo ricordava Jean de Pins due anni dopo la sua morte10 – si distinse negli anni del suo insegnamento per un’eccezionale concentrazione di doti umane e professionali. Secondo l’unanime consenso dei contemporanei, spiccavano in lui una formidabile capacità oratoria, che dimostrava a lezione (tale gli era riconosciuta da molti dei suoi allievi che in gran numero si trasferirono a Bologna da ogni parte d’Europa per diventare discepoli di Beroaldo) e la perizia nella capacità di indagine filologica e linguistica (che emerge chiaramente dalle ‘selve’ di annotazioni pubblicate nell’ultimo ventennio del Quattrocento, dalla perizia dei primi commenti, dalle epistole private). Queste due doti per certi versi preliminari si accompagnavano ad un peculiare approccio ‘morale’ ai testi classici (fu il tratto, condiviso con Urceo Codro, che segnò la scuola dell’umanesimo bolognese, così unica, sotto questo aspetto, nel panorama italiano di fine XV secolo11) e ad una singolare modernità nei gusti e nelle scelte letterarie, che simpatizzavano verso la fase argentea della letteratura latina, e che si riproponevano nelle scelte linguistiche del Beroaldo prosatore, che si distingue per un latino sorprendente nei suoi rara verba, di stampo apuleiano, ma ancora gradevole e lontano dagli eccessi del suo allievo (e competitore) Giovan Battista Pio12. Senza voler insistere su altri elementi che già Ezio Raimondi ed Eugenio Garin hanno messo in luce nella seconda metà del secolo scorso13, basti qui premettere che tra il 1494 (anno delle lezioni sugli scrittori di agricoltura) e il 1495 (anno di pubblicazione dell’orazione inaugurale di quel corso, il De felicitate), nonostante dovessero ancora essere pubblicati il celeberrimo commento all’Asino d’oro di Apuleio (1500) e il commento alle Tusculanae disputationes di Cicerone (1496: si tratta di un lavoro meno famoso ma assai interessante, in specie se raffrontato con l’orazione di cui si scriverà nelle prossime pagine), lo straordinario profilo del maestro bolognese era ben tratteggiato, e noto a tutto il panorama umanistico italiano e internazionale.
Già ad un primo sguardo d’insieme al testo del De felicitate stampata da Platone de’ Benedetti nel 149514 si comprende che la felicità della vita rustica, una cui traccia può essere reperita negli scritti di Columella e di Virgilio che gli studenti leggeranno insieme al maestro, altro non è che un pretesto per trattare un argomento universale che già in altre occasioni, in altri tempi e altri ambienti, aveva suscitato interessamenti e stimolato dibattiti e contributi da parte di umanisti colleghi di Beroaldo. La rilevanza dell’orazione è testimoniata dall’ampio numero di edizioni che essa ricevette già in anni immediatamente successivi al 1495 e dal pullulare, poi, di edizioni e riprese cinquecentesche. Esse dimostrano un interesse che non fu soltanto immediato e cittadino, ma che si estese in ambienti via via differenti e per ragioni via via differenti. Si annoverano infatti dapprima una ristampa dell’edizione di Platone de’ Benedetti – che mantiene la stessa data della princeps bolognese – per i tipi di Caligola Bazalieri15; una seconda edizione per i tipi di Ettore Faelli datata 13 aprile 1499, la quale fu ristampata con ogni probabilità nei primi anni del ‘500 (nonostante rechi la stessa data dell’edizione del 149916). Indi, fuori dalle mura bolognesi, l’orazione ebbe un discreto successo oltralpe nel corso della prima metà del Cinquecento. Il De felicitate fu infatti stampato il 28 marzo del 1500 da Thielman Kerver, e Jean Petit a Parigi17 e poi di nuovo, verosimilmente nel 1501, da Michel Toloze, sempre a Parigi18. Esistono poi diverse altre edizioni francesi risalenti al primo decennio del Cinquecento, che sembrano certificare l’esigenza degli stampatori d’oltralpe di «soddisfare le richieste di docenti e studenti» attivi in Francia e che culminano con la traduzione di Calvy de la Fontaine del 154319. Gli interessi degli scolari di tutta Europa per questo opuscolo hanno verosimilmente seguito un doppio binario, come ha già sottolineato Severi: da un lato, l’opuscolo sicuramente risultò fin da subito attraente per l’amplissima mole di citazioni in esso raccolte, e dunque per la sua natura di esercitazione di scuola e campionario di saggezza ed exempla classici. D’altro canto, l’opuscolo suscitò interessi duraturi poiché interveniva in un dibattito filosofico-morale che aveva avuto una certa fortuna lungo tutto l’umanesimo italiano. Non è però da escludere che a suscitare la curiosità e gli interessi dei lettori rinascimentali dell’opera sia stata anche la peculiare posizione beroaldiana. Essa, che emerge nelle fasi finali dell’opuscolo da un fittissimo reticolo di citazioni e reminiscenze classiche (che per un lettore contemporaneo possono alle volte suonare pleonastiche o superficiali), sembra infatti far trapelare più di un profilo di originalità, conciliando in sé un approccio generalmente peripatetico, derivato in particolare dall’Etica Nicomachea che Beroaldo leggeva in latino probabilmente grazie alla versione dell’Argiropulo20, e da un lato un generale scetticismo verso gli estremismi stoici, dall’altro una timida apertura verso gli aspetti meno deteriori di un epicureismo moderato, attento al corpo non meno che alla dimensione contemplativa dell’uomo, di cui Beroaldo aveva letto grazie alle fonti latine e per la quale, forse, provava una qualche simpatia di carattere del tutto ‘personale’. Ma su tutto ciò si tornerà più nel dettaglio21.
Ad un rapido e certamente non esaustivo sguardo sui trattati in qualche modo interessati al discorso sulla felicità umana scritti nel corso dell’umanesimo italiano, alcuni nomi in particolare non possono essere trascurati. Dell’unico trattato del primo umanesimo che menzioni la parola felicitas nel suo titolo definitivo è responsabile l’umanista spezzino Bartolomeo Facio22. Il protagonista della stagione intellettuale legata ad Alfonso di Aragona, attivo nella Napoli degli anni ’40 e ’50, fu infatti autore del De humanae vitae felicitate, databile al 144523. L’operetta dialogica, che tuttora risulta sprovvista di un’edizione critica, ci suggerisce fin dal suo assetto dialogico e dai suoi protagonisti tutte le sue profonde interconnessioni con la cultura contemporanea e con la produzione coeva: dell’argomento, titoli a parte, si discuteva infatti già da tempo negli ambienti umanistici. Per quanto il De humanae vitae felicitate sia il primo trattato a discutere organicamente delle opinioni dei pensatori antichi e la dottrina dei padri della Chiesa a tema felicità umana, si inseriva in un contesto particolarmente fitto di interventi a proposito e – è bene ricordarlo – in una stagione che vedeva Facio impegnato a mettere a sistema alcune riflessioni sull’uomo, sulla sua centralità e sul suo rapporto con Dio, che di lì a qualche anno sarebbero confluite nel De excellentia et praestantia hominis. Questo secondo trattato va a collocarsi, ancor più del De humanae vitae felicitate, in una tradizione di scritti particolarmente fortunata nel corso dell’umanesimo, in cui sono certamente da annoverare il vicino (e di gran lunga più articolato) De eccellentia et dignitate hominis di Giannozzo Manetti24 e il più originale e maturo (nonché legittimamente celeberrimo) opuscolo di Giovanni Pico della Mirandola Discorso sulla dignità dell’uomo25, che in sé racchiude la vera e propria essenza programmatica del concetto stesso di umanesimo, pure non in poche occasioni stereotipato dalla storiografia successiva. Tornando a Facio, sin dalla presentazione dei personaggi in dialogo e dalle primissime battute della prima giornata di discussione si può comprendere in quale retroterra dialettico e culturale sulla felicità – o, se si vuole, sul sommo bene umano: i due concetti si sovrappongono in tutte le opere a proposito, fino all’ouverture di Beroaldo già menzionata poco sopra – aveva trovato origine. Come puntualmente dimostrato da due contributi recenti di Federico Petrucci e di Vera Tufano, erano ben chiari a Facio, fin da principio, i lavori di Lorenzo Valla de voluptate, che risultano essere il vero e proprio controcanto polemico delle tesi di Facio. E così con ogni probabilità Facio teneva da conto anche i prodromi del discorso umanistico sulla dottrina morale di Leonardo Bruni. Entrambi questi umanisti qualche anno prima di Facio si erano infatti a vario titolo occupati di bene umano e di felicità. Il primo, nell’Isagogicon moralis disciplinae, aveva fornito un vero e proprio compendio delle dottrine morali dell’antichità, giungendo ad una soluzione conciliatoria entro la quale «tra le scuole antiche vi riporta la palma non la stoica ma la peripatetica»26, come legittimo aspettarsi da un aristotelico come il Bruni. Meno compilativo e decisamente più controverso fu il cimento di Valla, o per meglio dire i diversi e sovrapposti cimenti di Lorenzo Valla, viste le quattro redazioni differenti che si affastellarono tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del Quattrocento, fino a culminare nel De vero falsoque bono27. L’opera, le cui stratificazioni testuali testimoniano – come ha ben dimostrato la sua editrice critica, Maristella de Panizza Lorch – ripensamenti e aggiustamenti delle tesi propugnate di redazione in redazione, si distinse, fin dai primi momenti della sua circolazione e ricezione in àmbito pavese, per l’originalità con la quale pose in dialogo la dottrina cristiana e tesi di stampo epicureo, in netta antitesi con la morale stoica28. Facio, in risposta a Valla, schiera come virtuali interlocutori del suo dialogo intorno alla felicità alcuni dei più importanti umanisti dell’epoca, due dei quali, Guarino Veronese e Antonio Beccadelli detto il Panormita, figuravano anche nel dialogo di Valla con ruoli da protagonisti. Assume in Facio un ruolo di particolare importanza proprio il Panormita, intellettuale di spicco negli ambienti napoletani, ma non immune a critiche, in specie aventi oggetto alcuni licenziosi versi della sua raccolta poetica: mentre in Valla il Panormita è uno strenuo difensore della voluptas umana, in Facio assume un ruolo completamente opposto, divenendone un detrattore. È in particolare nella seconda parte del dialogo – dopoché, su domanda del terzo interlocutore, il Lamola, sono state scartate alcune vie d’accesso alla felicità – che si rende manifesta l’opinione di Facio, la cui soluzione si configura come sostanzialmente teologica: sulla scorta in particolare di Lattanzio e di Sant’Agostino, il dialogo stabilisce la via religiosa come unica possibilità di felicità umana29. Ha legittimamente notato Alan Ryder, proprio in relazione a questo trattato, «The quietist spirit of these works [il De humanae vitae felicitate e il De excellentia ac praesantia hominis], with their emphasis on the afterlife and the superiority of the contemplative over the active stance in terrestrial affairs, found little favor with Alfonso. Much more to his taste was the thesis of Giannozzo Manetti that man’s true purpose was “to act and to know”»30. L’esigenza di una soluzione ‘pragmatica’ a questa grande questione filosofica, vista sempre più come una questione morale e umana e non teologica, era dunque già sentita nel corso della prima metà del Quattrocento: essa si manifesterà compiutamente proprio col De felicitate di Beroaldo. Ma il discorso sulla felicità, per sua natura pervasivo e totalizzante, interessò certamente altri trattati, epistole filosofiche e orationes dell’umanesimo italiano. Sarebbe qui impossibile, e forse inutile, darne un regesto completo. Un caso, però, non può proprio essere obliterato per via di una importante serie di ragioni che ci avvicinano sensibilmente all’orazione di cui si sta scrivendo. Tra il 1494 e il 1495 il più vicino tra i colleghi bolognesi di Beroaldo, Antonio Urceo Codro, scrisse quello che fin dalla prima edizione a stampa è collocato al primo posto tra i suoi Sermones: il grande discorso sulla fabula – entro il quale Codro spazia con dottrina e umanità tra letteratura e sapienza greche e latine – ospita un brevissimo résumé delle opinioni degli antichi sulla felicità che, come si vedrà nel dettaglio, trovano più di una eco in Codro. Pur senza sviluppare in alcun modo la questione – e fornendo infine una soluzione fideistica (in parte inaspettata per il maestro bolognese) – Codro dimostra interesse e attenzione per la questione del summum bonum. Conviene riportare per intero lo stralcio:
«Summum enim bonum, idest felicitatem, alii in virtute sola posuerunt, ut Stoici; alii in voluptate corporis, ut Epicurus; alii in vacuitate doloris, hoc est sine ulla molestia vivere, ut Hieronymus; Carneades vero bonis naturae primis, aut omnibus aut maximis frui, felicitatem esse dixit; (498) Aristoteles, et ab eo peripatetici, bona animi corporis et rerum externarum; Dinomachus et Callipho voluptatem cum honestate; Diodorus honestatem indolentem. (499) Non desunt etiam qui lusum risumque summam esse felicitatem comprobaverint, ut Tibareni populi, Chalybibus vicini, quorum Apollonius et Pomponius mentionem fecerunt. (500) Erilli vero philosophi summum bonum scientia est, sed Socrates hoc unum scire se dixit, quod nihil scire. (501) Huius autem summi boni quod omnes appetunt et quod propter se appetitur, veritatem scire cupiens, Varro ille, qui undecumque vir doctissimus dictus est, ita diligenter, ita subtiliter de eo locutus est ut ad ducentas octoginta octo sectas, non quae tum essent, sed quae esse possent, adhibens quasdam differentias facillime pervenerit, quas, quia longum nimis esset hic exponere, qui discere voluerit decimumnonum Aurelii Augustini librum De dei civitate percurrat. (502) Ergo philosophorum sectae, seu dogmata, seu placita sint, incertitudines sunt et fabulae. Et praecipue quae de felicitatae huius vitae memorantur, cum nullus sic felix, ut scribit Euripides, “θνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ”, idest “mortalium nullus est felix vir”; et certe summum bonum est aeterna et immortalis vita, quam iuste et fìde viventes speramus».
Ovvero:
«Alcuni pongono il sommo bene, cioè la felicità, solo nella virtù, come gli Stoici; altri nel piacere del corpo, come Epicuro; altri ancora nella mancanza del dolore, cioè nel vivere senza alcun fastidio, come Girolamo; Carneade disse che la felicità sta nell’usare i beni della natura, o tutti o i più importanti; (498) Aristotele, e da lui i Peripatetici, sostengono che i beni sono dell’animo, del corpo e delle cose esterne; Dinomaco e Callifonte dicono che la felicità consiste nel piacere unito all’onestà; Diodoro che consiste nell’onestà priva di dolore. (499) Non mancano poi coloro che affermarono che la somma felicità consiste nel divertimento e nel riso, come i Tibareni, vicini dei Calibi, dei quali fanno menzione Apollonio Pomponio. (500) Varrone, che è detto ovunque uomo dottissimo, desiderando conoscere la verità di questo sommo bene che tutti cercano che è ricercato di per sé, parlò di quello così analiticamente e così accuratamente che arrivò a definire molto agevolmente, sulla base di alcune differenze, duecentottantotto scuole, non effettivamente esistenti allora, ma che sarebbero potute esistere; chi volesse conoscerle, dal momento che qui sarebbe troppo lungo esporle, scorra il diciannovesimo libro del De civitate Dei di Aurelio Agostino (502) Dunque le scuole dei filosofi, le dottrine le opinioni, sono incertezze e favole. E soprattutto quelle che parlano della felicità di questa vita, dato che nessuno è felice, com scrive Euripide: cioè “tra i mortali infatti nessun uomo è felice”; e certamente il sommo bene è una vita eterna e immortale, in cui noi, vivendo giustamente e con fede, confidiamo.»31
Filippo Beroaldo seniore si trovava a scrivere di felicità nel quadro che si è cercato di descrivere, sia pure in modo provvisorio e incompleto. Alla ridda di autori menzionati bisogna di sicuro aggiungere il ruolo che ricoprì Marsilio Ficino – in particolare nel corso dei suoi studi giovanili – per quel che riguarda la teoria della voluptas e la rilettura di alcuni autori greci sotto questa chiave di lettura32. Non è dato sapere con certezza se egli avesse letto gli opuscoli di cui si è data menzione – il maestro bolognese non cita nessuno di questi, né si ha la prova di manoscritti o volumi che li tramandano nella sua biblioteca: ma certamente non poteva non tener conto, da umanista pienamente coinvolto nel dibattito contemporaneo, dei precedenti anche assai recenti e del largo interesse sul tema33. Di alcuni addentellati – più o meno ipotetici ipotesti dell’orazione di Beroaldo – si potrà dire nelle pagine che seguono. Intanto, data l’assenza di un’edizione moderna criticamente fondata dell’orazione, che risulta generalmente negletta, conviene facilitarne la lettura riportando una scansione in paragrafi che suddivida il testo seguendo i suoi principali fulcri tematici e consenta una prima fotografia d’insieme dei temi e dei problemi trattati da Beroaldo34. 1: incipit dell’orazione; 2: definizione del concetto di felicità; 3-4: prime divergenze tra le scuole filosofiche sul tema; 5: seconda introduzione dell’orazione; 6-7: la felicità risiede nel piacere?; 8: la felicità non risiede nel piacere; 9: la felicità risiede nella gloria?; 10: la felicità non risiede nella gloria; 11: la felicità risiede nel potere?; 12: la felicità non risiede nel potere; 13: esempi di persone che hanno anteposto la vita privata a quella pubblica; 14: esempi di persone che hanno trovato la felicità nella vita rustica; 15: la felicità risiede nelle ricchezze?; 16: intermezzo su questioni militari; 17: la felicità risiede nelle ricchezze?; 18: la felicità non risiede nelle ricchezze; 19: l’esercizio della virtù garantisce una vita felice?; 20: l’esercizio della virtù, da solo, non garantisce una vita felice e definizione della felicità tramite la tripartizione dei beni dell’uomo; 21: definizione dell’uomo; 22: i beni del corpo; 23: l’importanza dell’esercizio fisico; 24: i beni che provengono dall’esterno; 25: la felicità come somma delle tre tipologie di beni; 26-27: esempi di persone che hanno cumulato ogni tipo di bene nella loro vita; 28: l’esempio di Creso e Solone; 29: conclusioni sulla possibilità di essere felici nel corso della vita; 30: explicit dell’orazione; 31-32: poesie conclusive.
Già da questo sintetico prospetto degli argomenti dell’orazione si può cogliere la strategia argomentativa di Beroaldo, nonché alcune peculiarità proprie anche delle altre orazioni maggiori. Alla questione costitutiva di ciascuna sezione, esemplificata da un’essenziale titolatura dei singoli paragrafi (an voluptas sit summa felicitas, voluptatem non esse summum bonum, e così via), Beroaldo risponde facendo sfoggio, più che di una vera e propria argomentazione dialettica, di tutta la sua erudizione e del maggior numero di exempla ricavati dai classici: concentrando il maggior numero di citazioni e fatti esemplari tratti dalla biblioteca classica dell’umanista, l’oratore punta sempre più a impressionare e dilettare i suoi ascoltatori e lettori, che a convincerli razionalmente della bontà delle sue tesi. Non a caso, rispetto ai già citati trattati su cui la riflessione di Beroaldo poteva poggiarsi, la strutturale differenza del testo di Beroaldo è però evidente, e affonda nel genere letterario scelto: il maestro bolognese si affida infatti all’orazione e alle sue peculiari particolarità retoriche (al pari, ad esempio, di Pico della Mirandola e della sua Oratio de dignitate hominis); come si è visto, Facio, riprendendo la scelta di Valla, si era contraddistinto per la scelta della forma dialogica, e più segnatamente di quella di esplicito stampo ciceroniano, lasciando, almeno sulla carta, maggiore spazio sia al botta e risposta dialettico, sia all’argomentazione filosofica in senso stretto35. Nell’orazione è invece il maestro, con la sola sua voce, a racchiudere nel suo discorso tesi, antitesi e sintesi. Non va dimenticato, peraltro, che ciò che leggiamo è esito di una trascrizione quanto più fededegna di un’orazione effettivamente tenuta da Beroaldo di fronte ad una platea cittadina (composta, verosimilmente, non dai soli studenti del suo corso): è lo stesso maestro a ricordarlo in un passaggio proprio del suo discorso, quando sulla scorta della sapienza medica di Cornelio Celso, ricorda al suo uditorio la dimensione ‘fisica’ del mestiere di insegnante – una vera e propria exercitatio mediante cui curare il proprio corpo e preservarne i bona, che risulteranno funzionali tanto quanto i bona animi e i benefici provenienti dall’esterno al raggiungimento della felicità: [22] Commode etiam exercent, ut docet Cornelius Celsus, cursus, ambulatio et clara lectio, qua nos prope peculiariter utimur, quotidie publicis lectionibus contentissime boantes et ravim exerta voce repurgantes, ovvero “Ma sono assai comode modalità di esercizi, come insegna Cornelio Celso, la corsa, la camminata e la lezione a voce alta: noi ci esercitiamo soprattutto in quest’ultima, quando ogni giorno, in lezioni pubbliche, gridiamo con forza e, tirata fuori la voce, ci leviamo la raucedine”.
Le dimostrazioni beroaldiane paiono procedere in senso generale per contraria e in senso specifico per exempla: è infatti cura di Beroaldo anzitutto negare alcune possibili vie di accesso alla felicità, dimostrando quanto e come esse si rivelino in realtà ingannevoli e non salde. La prima e più consistente parte dell’orazione è infatti rivolta allo ‘smontaggio’ delle credenze secondo cui la felicità si debba alla pratica dei piaceri della vita, alla ricchezza, all’accumulo di gloria e di potere. A sostegno di queste dimostrazioni, più che una particolare architettura dialettica e dimostrativa, vengono continuamente citati esempi di personaggi storici, o del mito, che parevano aver momentaneamente ottenuto la felicità ma la cui vita dimostra il contrario: il campionario di auctores citati è particolarmente ampio, come si avrà modo di vedere, e spazia tra la poesia e la prosa latina (con particolare attenzione ai poeti satirici per la poesia e a Cicerone, Plinio e Seneca per la prosa, all’Orazio satirico e a Silio italico per la poesia), nonché diversi esempi di greci letti da Beroaldo in traduzione (Strabone, Plutarco, Erodoto). La svolta ‘filosofica’ dell’orazione avviene oltre la metà, quando Beroaldo si trova a trattare la spinosa questione dell’esercizio della virtù come fonte di una vita beata: sarà in occasione di questo passaggio che Beroaldo, trovandosi più esposto dal punto di vista della sua personale posizione, avrà occasione di mettere a sistema le sue idee, in specie quelle rivolte alla dottrina della virtù stoica. Ma converrà seguire il flusso dell’orazione con ordine: di essa si presenteranno, a beneficio del lettore, alcuni stralci tradotti in italiano e brevemente commentati.
Come si anticipava, il De felicitate muove, con un piglio metodologico decisamente aristotelico, da una precisazione circa la vera e propria definizione del concetto di cui si sta trattando, che era stata soltanto retoricamente accarezzata nel roboante incipit dell’orazione. Beroaldo tornerà poi a sentire l’esigenza di definire i concetti chiave della sua dimostrazione (in questo caso l’uomo e i beni che lo riguardano) nel momento in cui aprirà la sezione argomentativa finale, nella quale perverrà a conclusione del suo ragionamento. Leggiamo:
[2] Primum finiamus quid sit ipsa felicitas: cuncta enim per finitionem apertiora fiunt ac magis colliquescunt. Est itaque felicitas, ut inquit Augustinus in V De civitate Dei “omnium rerum optandarum plenitudo” vel, ut ait Boetius in tertio Consolationis, “beatitudo est status omnium bonorum congregatione perfectus”. Aristoteles in primo Ethicorum decernit felicitatem esse finem rerum expetendarum, cetera propter felicitatem expeti, felicitatem vero propter se ipsam.
Ovvero:
[2] In primo luogo, definiamo che cosa sia in sé questa felicità: tutte le cose, infatti, si fanno più chiare grazie alla definizione, e la discussione diventa più fluida. È dunque la felicità, come dice Agostino nel V libro del De Civitate Dei, «la pienezza dei beni che si debbono desiderare» o, come dice Boezio nel III libro del De consolatione philosophiae, è «uno stato perfetto in cui sono assommati tutti i beni». Aristotele, nel I libro dell’Etica Nicomachea, stabilisce che è la felicità il fine di ogni desiderio umano, e che ad ogni altra cosa si ambisce a motivo di felicità, mentre alla felicità per la felicità stessa.
Già da queste prime parole emergono alcuni elementi interessanti. Assai rilevante risulta notare come Beroaldo si serva dapprima di due citazioni di scrittori cristiani per dare avvio al suo collage di fonti utili alla definizione del campo di interesse dell’orazione. Prima ancora di Aristotele, che avrà una funzione chiave lungo tutta l’orazione, vengono presi come punti di riferimento, infatti, Sant’Agostino e Severino Boezio36. Le due citazioni patristiche risultano assai interessanti poiché incastonate nelle due osservazioni più polemiche di tutta l’orazione che paiono una vera e propria stoccata nei confronti di una parte del mondo culturale con cui Beroaldo aveva a che fare (e forse anche con qualcuno del suo pubblico), più che con gli scrittori che lo avevano preceduto sul tema. Appena prima delle menzioni di Agostino e Boezio, nell’incipit dell’orazione, Beroaldo aveva infatti affermato:
[1] Audivi olim ecclesiasticos contionatores non parvae in ecclesia existimationis super felicitate contionantes, sed tam implicata tam spinosa tam incondita erant quae dicebantur ut in predicanda felicitate infelices fuisse merito iudicarentur. Nos ista lucide dicemus et historica fide tractabimus, partim oratorio partim philosophico more, memorantes exempla ad felicitatem pertinentia et veterum philosophorum sententias non incuriose pensitantes.
Ovvero:
[1] Ascoltai una volta dei predicatori religiosi (persone degne di non poca stima in ambienti ecclesiastici) predicare a proposito della felicità. Ma le loro parole erano tanto involute, tanto spinose e tanto grossolane che a ragione potevano essere ritenuti infelici nel predicare la felicità. Noi parleremo chiaramente e tratteremo l’argomento con veridicità storica, in parte more oratorio, in parte more philosophico, ricordando fatti esemplari che abbiano a che fare con la felicità e considerando non negligentemente frasi di antichi filosofi.
E, appena dopo la definizione, in séguito a qualche cursorio e introduttivo cenno alla generale divergenza tra le opinioni delle scuole filosofiche dell’antichità a proposito (le prime menzioni sono riservate agli epicurei e agli stoici), sulle quali poi l’autore sarebbe tornato con maggiore profondità col sostegno di exempla e citazioni dossografiche selezionate tema per tema nel corso dell’orazione, poco più avanti leggiamo:
[5] Ecclesiastici doctores summum bonum esse dixerunt vitam aeternam, summum malum mortem aeternam. Sed nos in praesentia de humana felicitate disseramus, quae, ut inquit Aristoteles, donum est deorum, ad quam cuncti mortales pervenire discupiunt. Quamvis diverso tramite procedant et quamvis variae dissidentesque sententiae sint, tamen omnes in diligendo boni fine (hoc est felicitate) consentiunt.
Ovvero:
[5] I dottori della Chiesa hanno affermato che il sommo bene consiste nella vita eterna, e il sommo male nella morte eterna. Ma noi discutiamo qui della felicità umana che, come dice Aristotele, è un dono degli dèi; tutti gli uomini desiderano ardentemente arrivare ad essa. Per quanto ci si arrivi per tramiti differenti e per quanto vi siano varie e discordanti affermazioni a riguardo, allo stesso modo tutti i buoni concordano nell’apprezzare il bene supremo, ovvero la felicità.
L’atteggiamento beroaldiano è dunque programmaticamente esposto fin da principio, e in questo si differenzia dai suoi predecessori: nell’orazione si tratterà solo e soltanto di una felicità terrena, ovvero di ipotesi di felicità possibili; e lo si farà – pur non evitando del tutto il pensiero dei maggiori pensatori cristiani (che, almeno in fase di definizione generale del concetto, paiono deliberatamente contrapposti tanto ai contionatores quanto ai doctores ecclesiastici)37 – servendosi principalmente, con approccio storiografico, oratorio e filosofico insieme, dei pensatori dell’antichità, delle loro dottrine e delle testimonianze su di esse. Gli esempi e i riferimenti al presente dimostreranno come l’orazione non procederà sottraendosi ad un dialogo con la lezione pratica e quotidiana dell’esperienza, nonché con la lezione della storia. Nessuna tensione verso assoluti ultramondani, dunque, né verso una felicità che si risolva solo ed esclusivamente nella vita eterna o nella speranza di essa (così Bartolomeo Facio aveva risolto la questione): il tentativo beroaldiano risiederà nel ricercare, pur essendo pienamente consapevole delle divergenze di opinioni tra le diverse dottrine filosofiche e gli uomini stessi, una via ‘operativa’ alla felicità (essa stessa è per Beroaldo, che segue Aristotele, un’operatio in capo agli esseri umani, e non un traguardo da raggiungere dopo la morte, né sul punto di morte38), e dunque un tentativo di mediazione tra opinioni apparentemente inconciliabili, ma che abbia come unico fulcro di interesse l’uomo e la sua vita in terra. Viene immediatamente a confermarsi il giudizio di Franco Bacchelli su tutta la produzione beroaldiana e in particolare sul De felicitate: «Negli opuscoli Beroaldo trova modo di divulgare e di esemplificare tutte le dottrine morali dell’antichità; la sua non è però una esigenza di dossografia scientifica, ma la divulgazione di un sapere che si deve fare scuola di vita e di costumi; per questo le dottrine non sono distinte precisamente, ma devono essere presentate nel loro lato di convergenza»39.
Proprio in ossequio a questo spirito pragmatico, Beroaldo è obbligato a muovere i primi passi della sua orazione trattando di un tema particolarmente scottante, ovvero della relazione tra felicità e voluptas. In questa scelta di collocare in una posizione centrale il tema vi era forse, prima di ogni altro riferimento alla cultura coeva, una qualche esigenza personale di Beroaldo, riconducibile alle sue scelte di vita privata che sovente emergono anche tra le pagine dei suoi commenti40. Ma il discorso è sicuramente più profondo. D’altronde, il maestro ammette di trovarsi a fronteggiare una dottrina che, nel corso del tempo, non ha soltanto raccolto i suoi adepti tra i filosofi, ma che riscuote un particolare successo anche tra le scelte quotidiane del popolo. Il problema costituito dagli epicurei – o meglio, da coloro i quali seguono come una divinità la pancia e il sottopancia e dai loro ideologhi (Beroaldo in questo caso si serve di una memoria evangelica, menzionando coloro per i quali Deus venter est et quae sub ventre sunt41) – sembra peraltro essere più che contemporaneo: habet haec secta sectatores paene infinitos (“questa scuola ha allievi quasi infiniti”). Per questo, il repertorio di esempi che Beroaldo utilizza per decostruire l’idea secondo cui la felicità dell’uomo risiede nel piacere umano è particolarmente ampio e particolareggiato. Gli esempi spaziano dall’erudizione storico-aneddotica dell’Historia augusta (con la menzione, tra le altre, alla dissolutezza degli imperatori, che ritornerà nella Declamatio lepidissima del 149942) al molto frequentato Aulo Gellio, ma al contempo consentono a Beroaldo di mettere in luce una forte dipendenza del capitolo dai lavori di traduzione di Gregorio Tifernate: Beroaldo si appoggia certamente alla traduzione latina di Strabone (a doppia firma di Tifernate e Guarino Veronese), da cui trae l’epitaffio metrico di Sardanapalo43 e la descrizione della dissolutezza del popolo tarantino, e probabilmente anche alla traduzione dell’Etica Eudemia di Aristotele, da cui è tratto un singolare aneddoto presente anche nei Deipnosofisti (I 9,19 ed. Kaibel) sicuramente irraggiungibili per Beroaldo: il caso di un provetto epicureo, Filosseno, che sperava – anzi pregava – in un allungamento del suo collo a mo’ di gru per poter consentire un maggior afflusso di ghiottonerie nel suo corpo (Arist. EE 1231a 16). Pare verosimile che questa pagina di Beroaldo sia la fonte diretta dell’emblema XC di Andrea Alciato, dedicato alla gula.

Tav. I: Andrea Alciato, Emblemata, Paris, Jean Richer, 1584, f. 124v. Questa la descrizione dell’emblema: Hac imagine depinguntur lurcones, gulosi, helluones, quibus tribuit collum gruis, quod sibi dari optabat Philoxenus: ventrem maxime prominentem, cum duabus aviculis edacissimis Laro, et Onocrotalo. Bellissima certe gulosorum insignia.
Di particolare interesse risultano poi gli argomenti con cui Beroaldo allontana la tentazione epicurea: tra questi emerge, come dappertutto nell’orazione, l’Aristotele etico (Aristoteles in VII Ethicorum hinc probat voluptatem non esse summum bonum quoniam inquit voluptates impediunt prudentiam et quanto maiores sunt tanto magis obnubilant, quod in aphrodisiis, idest in rebus venereis, patet44), al quale va certamente aggiunto un particolare rilievo dato dall’oratore all’importanza dell’aspetto corporale della vita e della felicità. Beroaldo qui si appoggia, per la prima e non ultima volta nel trattato, alla sapienza della medicina antica: compone un vero e proprio collage di fonti che spazia da Ippocrate a Galeno, trova più di una conferma nell’epistola 95 di Seneca a Lucilio, e si conclude con una esplicita menzione al Decretum Gratiani, che risulta essere la più prolifica fonte intermedia per le citazioni mediche e patristiche che si trovano nel testo, tutte tese a dimostrare che il troppo piacere corporale (sia che esso sia dovuto all’abbondanza di cibo o di vino, sia che esso sia dovuto ad un’eccedenza nelle pratiche sessuali45) è causa più di malanni che di benessere. E anche e soprattutto al benessere del corpo – i bona corporis di cui si dirà – deve guardare l’uomo per potersi garantire una felicità possibile in terra.
Non risulta di particolare interesse la sezione dedicata alla dimostrazione che il sommo bene non risiede nella gloria, la cui evanescente temporaneità è velocemente chiarita tramite alcuni esempi, senza particolare necessità di ulteriori spiegazioni. Beroaldo non manca altresì di notare il punto fondamentale che allontana la gloria dalla felicità umana, ovvero il fatto che essa non dipende in alcun modo da un approccio moralmente attivo dell’uomo, e dunque non riguarda gli aspetti ‘attivi’ del processo di costruzione della felicità ([11] magis enim in laudantibus quam in laudato consistit gloria, quae nihil aliud est quam opinatio de aliena virtute bene sentientium). Di un qualche interesse in più risultano essere le due sezioni successive. Il paragrafo 12 rappresenta infatti un breve stralcio dedicato al rapporto tra felicità e potere terreno: laddove ci si aspetterebbe un Beroaldo più vicino alla sapienza politica degli specula principis, si riscontra invece un’argomentazione abbastanza dimessa, che pare fungere soltanto da ‘gancio’ per rendere onore all’occasione che ha permesso di sviluppare l’orazione, ovvero la felicità associata alla vita agreste. Il Commentator bolognese non scomoda particolari fonti – quelle stesse che avrebbe dimostrato di conoscere assai bene scrivendo il De optimo statu et principe del 1497 – per trattare l’argomento, né si dedica con attenzione agli incommoda della vita del governante. Il problema è liquidato per tramite di una citazione di Dione Crisostomo, retore assai fortunato nell’umanesimo italiano fin dal periodo bolognese di Francesco Filelfo46, e grazie al comunissimo apologo sulla spada di Damocle, tratta con ogni evidenza dalle Tusculanae disputationes (V 61s.) il cui commento Beroaldo scrisse in parallelo alla stesura del De felicitate.
È proprio da questa vicenda mitica ed esemplare di Damocle si passa infatti alle vicende dei molti personaggi dell’antichità che preferirono una vita ritirata agli onori (e alle fatiche) della vita pubblica: l’inascoltato consiglio di Cinea, che suggeriva a Pirro di frenare la sua ambizione e contentarsi delle sue grandi fortune prima di perderle tutte, permette di scendere ancora più nel dettaglio di questa fattispecie di felicità residente nella semplicità della vita dei campi. La sezione non è soltanto dedicata ad un’anticipazione dei temi veicolati dai testi che saranno letti nelle successive lezioni, ma sembra far trasparire una sorta di riabilitazione, per via d’etimologie erudite47, degli aspetti rustici della vita. Beroaldo ricorda la crucialità dell’agricoltura e dell’allevamento nella civiltà greca e della civiltà romana, sulla quale si sofferma, giocoforza, molto di più. Non soltanto viene ricordato come i cognomi delle maggiori familiae romane trovino origini nel mondo rustico; l’orazione insiste piuttosto nel sottolineare – evidentemente in previsione del corso – come il gli ambienti rurali siano argomento di una letteratura tecnica antica che vale la pena di essere letta anche dai moderni: il negotium agreste e i praecepta colendi non sono soltanto argomenti di scienza e sapienza antica, ma anche fonte di sapere contemporaneo, non per forza soltanto erudito. Basti un’ultima sottolineatura: questa sezione è l’unica di tutto il trattato a non culminare con una condanna o con una contro-argomentazione vòlta a smentire la possibilità di ottenere la felicità descritta: se la felicità non risiede nella ricchezza, nella gloria, nel piacere o nel potere, non è detto che non possa risiedere – sembra suggerire e silentio Beroaldo – nella morigerata vita rustica.
Ecco che l’oratore si trova ad avere a che fare con una communis opinio che lui stesso afferma essere diffusissima (Quidam, immo paene omnes – sottolinea – autumant summum bonum esse divitias et solum divitem esse beatum, “molti, anzi quasi tutti, affermano che il sommo bene sia la ricchezza e che solo il ricco sia felice”), ovvero che la felicità sia raggiungibile grazie alle ricchezze. Nel bel mezzo di una panoramica introduttiva su una serie di autori latini ‘canonici’ sull’argomento – sui quali svetta senza dubbio l’Orazio delle Satire – Beroaldo si avventura in una digressione forse inaspettata per un lettore moderno, ma sicuramente di grande effetto sull’ascoltatore coevo. La deviazione interrompe improvvisamente il gran numero di esempi addotti da Beroaldo intorno alle ricchezze e alle testimonianze classiche sul tema. Ma è direttamente Marte, il dio romano della guerra, a stimolarlo coi suoi fulmini e i suoi dardi e a costringerlo a dar menzione, in presentia, di alcune questioni legate al tema della guerra. Seguendo il ragionamento dell’umanista, ciò che più conta in una situazione bellica non è tanto l’abbondanza dei soldati, né la virtù dei comandanti militari: i veri e propri ‘nervi’ della guerra sono i soldi. La certezza per certi aspetti “oracolare” dell’affermazione (Qui vero pecunias bellorum nervos esse dixerunt, oraculo certiora dixisse videntur) consente all’umanista di correggere ad abundantiam addirittura Cicerone, il quale riteneva che per avere un buon generale bastassero, assommati in un unico profilo, il valore strategico, la virtù, l’autorevolezza presso i soldati e la fortuna. La ragione di questo excursus, che potrebbe suonare stonato e poco aderente agli interessi dell’orazione, è però chiara fin dalle parole dello stesso autore: nelle settimane in cui Beroaldo scrisse l’orazione De felicitate più di un vento di guerra doveva soffiare sulla penisola italiana. Nel settembre del 1494 il re di Francia Carlo VIII calò infatti con le sue truppe in Italia, diretto verso il regno di Napoli: fu l’atto che inaugurò la stagione delle cosiddette “Guerre d’Italia”, che tanta parte hanno tra gli storici e i letterati coevi a Beroaldo, la cui felicitas, divagando non inutilmente sulla guerra, i suoi protagonisti e i suoi rischi, pare qui adombrarsi in previsione di una vera e propria deflagrazione della penisola, ovvero di una situazione non certo compatibile con alcuna forma di felicità terrena (in haec divertisse non fuerit alienum, propter gliscentes in dies bellorum rumusculos, quibus Italiam flagraturam ominantur, ovvero “non sarà stato strano fare questa deviazione, dal momento che si susseguono voci di guerra secondo le quali l’Italia è destinata a bruciare tra le fiamme”).
Si apre a questo punto la parte conclusiva (e determinante dal punto di vista filosofico) dell’orazione. L’autore viene infatti a trattare il tema della virtù e del suo rapporto con la felicità. Passate in rassegna come di consueto le fonti più ortodosse sul tema – Seneca e Cicerone sono affiancati dai satirici Orazio e Lucilio – è proprio la dimostrazione del fatto che l’esercizio della virtù di per se stessa (per se ipsa) non garantisce la felicità ad aprire alla ‘soluzione’ beroaldiana. Soluzione che non dovette risultare così pacifica per Beroaldo (come segnala al lettore l’ablativo assoluto re diligenter perpensa et pensitata). Nell’esercizio della virtù risiedono certo molti elementi utili a condurre una vita felicemente, ma non tutti. La cura dell’anima è sicuramente importante, ma non è esclusiva. Per Beroaldo risulta impossibile sposare l’estrema idea degli Stoici secondo cui si possa essere felici anche sotto tortura48, se si stanno esercitando le virtù dell’anima: se da un lato infatti l’assenza di dolore non può essere, di per sé, una garanzia di felicità (anche uno stolto può non provare dolore, ma non per questo potremmo dirlo felice), né come si è visto può esserlo la presenza di piacere, d’altro canto non è in alcun modo possibile seguire gli Stoici o l’Etica aristotelica nel valutare la felicità come un’operatio di ordine esclusivamente contemplativo – il che aprirebbe pericolosamente, com’è ovvio, ad una soluzione teologica alla questione. La natura dell’uomo, infatti, non è soltanto contemplativa. Per trovare una soluzione non ultramondana alla questione, è necessario ritornare alle definizioni, e in particolare alla definizione di uomo. Se ne riporta qui un breve stralcio essenziale per la prosecuzione del discorso:
«Quod ut planius et lucidius percipiatur, quid sit ipse homo, et ex quibus constet quaerendum est. [21] Homo neque solum corpus est, neque anima sola, sed ex anima simul et corpore compactus est. Proinde summum bonum hominis, quo fit beatus, ex bonis utrisque conflatur. […] Qui vero ex animi et corporis ac fortunae bonis felicitatem constituerunt, hii veritatem ipsam propius inspexerunt, eorumque sententia tanquam optima verissimaque comprobatur»
Ovvero:
«Per comprendere in modo ancor più chiaramente luminoso il concetto, è necessario domandarsi che cosa sia l’uomo stesso e da che cosa sia costituito. [21] L’uomo non è solo il suo corpo, né la sola sua anima, ma è formato dall’unione tra anima e corpo insieme. Per questo il sommo bene per l’uomo – ciò che, una volta raggiunto, ti rende felice – è composto da entrambi i beni. […] Coloro i quali hanno stabilito che la felicità dipenda dai beni dell’anima, del corpo e della fortuna hanno davvero raggiunto, con la loro indagine, la verità: e la loro opinione, è provato, è ottima e verissima insieme»
Beroaldo, rivendicando il doppio statuto dell’uomo e non dimenticando i fattori ‘esteriori’ che influiscono sulla vita umana, si trova qui a presentare una tripartizione dei beni utili a raggiungere la felicità, di stampo aristotelico e reperibile anche negli appunti preparatori al De expetendis et fugiendis rebus di Giorgio Valla – come è stato debitamente notato da Severi49. Tra essi spiccano i beni dell’animo, dovuti all’esercizio della virtù, ma senza alcuna posizione di esclusività, come verrà ribadito nell’explicit:
«[25] Ergo igitur, cum sint tria genera bonorum (animi, corporis atque fortunae) haec, ut ait Aristoteles in septimo Politicorum, oportet adesse felici. Felicitas enim et vita beata cumulatur ex cumulo plenitudineque istorum bonorum, quae quanto fuerint cumulatiora, tanto fiet homo beatior, et ita erit vita beata, beatior beatissima secundum Academicos. Stoici vero hos gradus excludunt, apud quos nihil est rectius recto, nihil beatius beato. Bona autem animi haud dubie censemus reliquis anteponenda».
Ovvero:
«[25] Ecco, dunque, dal momento che esistono tre generi di beni (dell’anima, del corpo e della sorte), è necessario che tutti e tre risiedano in un uomo felice, come dice Aristotele nel settimo libro della Politica. La felicità (e dunque la vita beata) aumenta grazie all’accrescersi e al perfezionarsi di questi beni; tanto più saranno accumulati, tanto più sarà reso felice l’uomo, e la sua vita già beata diverrà più beata, e infine felicissima secondo gli Accademici. Gli Stoici, invero, escludono questi diversi gradi, dal momento che per loro non c’è nulla di più giusto del giusto, e niente di più felice del felice. Riteniamo che beni dell’animo vadano senza dubbio anteposti ai restanti»
Per quanto la soluzione teorica sia a questo punto chiara, l’orazione non termina qui. In ossequio all’approccio ‘pratico’ che si è visto contraddistinguere molta parte del testo, a soluzione teoricamente confezionata dovrà corrispondere una verifica tra gli exempla antichi e contemporanei ([26] Superest ut vestigemus exemplis an in ullo mortalium cumulata fuerint simul haec omnia bona, ut merito felix et esse et dici meruerit, ovvero “ci rimane da indagare se si trova un qualche esempio di mortale in cui si siano accumulati tutti questi beni e che si possa dire che a ragione ha meritato di essere felice e di essere definito tale”). La ricerca non va però a buon fine. Nessun personaggio della storia o del mito ha cumulato sino in fondo questi beni e nessuno è stato esentato da sfortunate sorprese del destino. Non potrà essere detto felice Lucio Metello che pure assommava in sé tutte le qualità desiderabili da un uomo, né tantomeno l’imperatore Augusto, l’uomo più potente di tutti i tempi. Ma neppure Creso, alla cui esemplare vicenda è lasciato molto spazio in conclusione, può essere considerato felice, dal momento che, per bocca di Solone, bisogna aspettare la fine vita di un uomo per definirlo felice. Guardando al vivo presente – e forse a se stesso e al suo uditorio – ecco che la conclusione dell’orazione si trova a dover fare i conti con l’ineluttabilità della morte, della vecchiaia e della malattia, non senza una chiosa finale, ironica e assai pratica insieme:
«[29] Natura vero nihil hominibus brevitate vitae praestitit melius: hebescunt senio sensus, membra torquentur, premoritur vivus, auditus, incessus, dentes etiam ac ciborum instrumenta labascunt. Et tamen vitae hoc tempus annumeratur. Ergo pro miraculo et id solitarium reperitur exemplum Xenophilum musicum centum et quinque annis vixisse sine ullo corporis incommodo. Itaque censeo optandum esse orandumque ab ultramundano deo ut, quoniam nemo mortalium felix est, ita nos foveat ne infelices dici iure possimus».
Ovvero:
«[29] La natura non offre agli uomini niente di meglio della brevità della vita: con la vecchiaia i sensi si attenuano, il corpo si intorpidisce, inizia a lasciarci prima di tutti la vista, poi l’udito, la facoltà di movimento, ballano anche i denti e cedono gli organi con cui si mangia. E purtuttavia anche questa viene considerata una stagione della vita. Quasi fosse un miracolo si ricorda quell’esempio di Xenofilo, un musico che visse cent’anni senza alcun problema col suo corpo. Pertanto, ritengo si debba desiderare e pregare il dio che sta al di là dei mondi affinché, dal momento che nessun uomo è felice, ci incoraggi almeno a non poterci dire infelici».
Che ci si limiti, dunque, a considerare una fortuna la nostra non-infelicità. Le non poche e non sgradite parole di Beroaldo a tema felicità che si sono antologizzate qui, se lette in filigrana, aprono orizzonti di dialogo con altri umanisti e con ambienti diversi da quello bolognese; dimostrano ancora una volta il bisogno di discutere con un metodo nuovo gli exempla classici nella scuola del maestro bolognese, una scuola insieme di letteratura e di morale; testimoniano il metodo di lavoro dell’umanista, bibliotheca loquens, e gettano luce su alcuni angoli del suo scrittoio; si propongono come fonte per opere successive. Ma sopra ogni cosa testimoniano il concorrere, nell’animo del maestro alle prese con una questione così universale e insieme di tutti i giorni, di dottrina e senso pratico, di sapienza e saggezza. Ci invitano, da ultimo, a riservare ancora qualche cura all’opera di Beroaldo e, se ce ne fosse bisogno, dimostrano che, al pari di altri classici, occorrerà rileggere questa orazione, non incuriose pensitantes, per trarne ancora una volta qualcosa di nuovo.
Note
- Su Filippo Beroaldo si veda, fin da ora, la monografia più aggiornata: Andrea Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, un maestro per l’Europa: da commentatore di classici a classico moderno (1481-1550), Bologna, Società editrice il Mulino, 2015. A diversi altri contributi presupposti dalla monografia di Severi (gli studi di Ezio Raimondi ed Eugenio Garin in particolare) si farà via via menzione nel corso del contributo.
- Dell’orazione De felicitate, insieme ai Symbola Pythagorae, all’Heptalogus e all’Oratio proverbiorum, è in preparazione un’edizione tradotta e commentata a cura di Andrea Severi, di Scott Blanchard e di chi scrive. Si rimanda alla suddivisione in paragrafi dell’edizione ventura, che si basa sull’editio princeps bolognese del 1495 (Oratio Philippi Beroaldi bononiensis de felicitate […], Bononiae, apud Franciscum Platonem de Benedictis, 1° aprile 1495, in 4°, ISTC nr. ib00482000). Per la suddivisione in paragrafi dell’opera che si propone qui, cf. appena infra. Per una fotoriproduzione dell’edizione bolognese del 1495 cf. De felicitate: mit Gedichten und Widmungsbrief des Autors an Jakob, Markgraf von Baden.
- «Etiamnunc nostris illud quoque opponitur: “vultis sapere; ergo expetenda res est sapere; si expetenda res est, bona est”. Coguntur nostri verba torquere et unam syllabam expetendo interponere quam sermo noster inseri non sinit. Ego illam, si pateris, adiungam. “Expetendum est” inquiunt “quod bonum est, expetibile quod nobis contingit cum bonum consecuti sumus. Non petitur tamquam bonum, sed petito bono accedit”» («Inoltre agli stoici ancora si obietta: “voi volete essere saggi: dunque l’essere saggi è una cosa da desiderare: se è una cosa da desiderare, è buona. I nostri sono costretti a torturare le parole e ad interporre nella parola expetere (desiderare) una sillaba, che la nostra lingua non lascia inserire. Io, se permetti, l’aggiungerò: “è expetendum (da desiderare)” essi dicono “quello che è bene; expetibile quel che ci tocca, quando abbiamo raggiunto il bene. Non è cercato come bene, ma si aggiunge come cosa accessoria al bene cercato”» trad. di Umberto Boella in Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, Torino, Utet, 1983).
- Eugenio Garin, Filippo Beroaldo il Vecchio e il suo insegnamento bolognese, in Id., Ritratti di umanisti, Firenze, Sansoni, 1967, pp. 107-129: 112.
- Si tratta di Plin. NH II 5, 22 ss. (un passo che verrà ripreso in Fel. 23): «Invenit tamen inter has utrasque sententias medium sibi ipsa mortalitas numen, quo minus etiam plana de deo coniectatio esset. Toto quippe mundo et omnibus locis omnibusque horis omnium vocibus Fortuna sola invocatur ac nominatur, una accusatur, res una agitur, una cogitatur, sola laudatur, sola arguitur et cum conviciis colitur […]» («”Però, a mezza via di queste due posizioni, la stirpe mortale si è scovata un potere divino, in modo che le nostre ipotesi su Dio risultassero ancora meno semplici. In effetti, su tutta la terra, in ogni luogo e ad ogni ora, solo la Fortuna è invocata e chiamata per nome dalle voci di tutti: lei solo è accusata, lei è incriminata, lei è pensata, lei è lodata, lei è rimproverata e venerate in mezzo agli insulti […]”»). Gioverà qui ricordare come i primi interessi di Beroaldo, a stampa nel 1476 a Parma presso Stefano Coralli, siano proprio dedicati a Plinio (ISCT nr. ip00790000): per un’analisi dell’opera si rimanda ad Andrea Severi, Il giovanile cimento di Filippo Beroaldo il Vecchio sulla “Naturalis historia” di Plinio: la lettera a Niccolò Ravacaldo, in «Schede umanistiche», XXIV-XXV, 2011, pp. 81-112.
- Si cita dal ms. Vat. lat. 2851, f. Iv, di prossima edizione da parte di chi scrive: Non enim praefatio istec mea flosculos leget oratorios, non pigmenta rhetorica fabulose percurret, sed, christiana simplicitate veritateque contenta, paucis et laconicis utetur, missam faciens pueritiam bonis artibus institutam sub principibus literarum quos fertilis Romana ferebat Academia, qua nulla sapore vernaculo solebat et solet esse conditior. Per la figura dei flosculi oratorî, cf. Cic. Sest. 56, 119 e Quint. Inst. or. X 5,23.
- Su Urceo Codro, si veda almeno Ezio Raimondi, Codro e l’umanesimo bolognese, Bologna, Società editrice il Mulino, 1950. Per aggiornamenti più recenti, cf. Giacomo Ventura, Codro tra Bologna e l’Europa, Quarto inferiore, Pàtron editore, 2019.
- Eugenio Garin, Filippo Beroaldo, cit., p. 109. Sempre di Garin, si tengano presente le Note in margine all’opera di Filippo Beroaldo il Vecchio, in G. Bernardoni Trezzini (ed.), Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti, Padova 1974, II, 437-456.
- Andrea Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, cit.
- La descrizione di Jean de Pins è ora in J. de Pins, Letters and letter fragments, edition, commentary and notes by J.N. Pendergrass, Genève, Droz («Travaux d’Humanisme et Renaissance», CDXXXIII), 2007, in part. pp. 85-86, ma si veda Andrea Severi, Filippo Beroaldo il vecchio, cit., p. 17.
- Per un quadro sulla scuola di umanità bolognese del secondo Quattrocento e del primo Cinquecento, cf. Franco Bacchelli, L’insegnamento di umanità a Bologna tra il Quattrocento e il Cinquecento, in A. Prosperi (ed.), Storia di Bologna. III/2 Bologna nell’età moderna. Cultura, istituzioni culturali, chiesa e vita religiosa, Bologna 2008, pp. 149-178 e ora Gian Mario Anselmi e Stefano Scioli, Literary Culture in Bologna from the Duecento to the Cinquecento, in Sarah R. Blanschei (ed.), A Companion to Medieval and Renaissance Bologna, Berlin-Boston, Brill, pp. 499-529.
- Sullo stile di Giovan Battista Pio e più in generale sulla disputa cinquecentesca tra scrittori ciceroniani e scrittori argentei, si considerino ancora validissime le parole di Carlo Dionisotti, Gli umanisti e il volgare tra Quattro e Cinquecento, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 70-113.
- Agli studi di Garin si è già fatto riferimento supra; si veda inoltre almeno Ezio Raimondi, Politica e commedia. Dal Beroaldo a Machiavelli, Bologna, Società editrice il Mulino, 1972.
- ISCT nr. ib00482000.
- ISCT nr. ib00484000.
- ISCT nr. ib00484500.
- ISCT nr. ib00485000.
- ISCT nr. ib00486000.
- A. Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, cit., p. 73.
- Fulvio Pezzarossa, «Canon est litterarum»: i libri di Filippo Beroaldo, in AA. VV., Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secoli IX-XV). Fonti, testi, utilizziazione del libro / Livres, lecteurs et bibliothèques de l’Italie médiévale (IXe- XVe). Sources, textes et usages. Actes de la table ronde italo-française (Rome, 7-8 mars 1997), Aubervilliers, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), 2001, pp. 301-348.
- Si cercherà, nel prosieguo del contributo, di fare emergere queste posizioni con chiarezza. Una simile giustificazione per la fortuna del De felicitate è data, di nuovo, da A. Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, cit., ibidem.
- Sul profilo di questo umanista, cf., almeno: Paolo Viti, Facio, Bartolomeo, in «Dizionario Biografico degli Italiani», vol. 44, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1994, s. v.; e ancora Gabriella Albanese, Studi su Bartolomeo Facio, Pisa, Edizioni ETS, 2000 e Marco Biagioni, Bartolomeo Facio: umanista spezzino (1400-1457): filosofo, polemista, storico ufficiale di Alfonso d’Aragona, re di Napoli, La Spezia, Ed. Cinque terre, 2011.
- Per un’introduzione preliminare al trattato, cf. Federico Petrucci, Il De humanae vitae felicitate di Bartolomeo Facio, in «Rinascimento Meridionale» I (2010), 33-45. Per una ottima e completa panoramica sulle tesi contrapposte nel dialogo e sulla soluzione di Facio, si veda Vera Tufano, Il De humanae vitae felicitate di Bartolomeo Facio tra modelli classici e fonti patristiche, in «Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge» online, 128-1 (2016).
- Sull’opera di Manetti, si veda ora l’edizione italiana a cura di Giuseppe Marcellino, con introduzione di Stefano U. Baldassarri: Giannozzo Manetti, Dignità ed eccellenza dell’uomo, Milano, Bompiani 2018.
- Si veda la recente edizione a cura di Raphael Ebgi e tradotto da Francesco Padovani, Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo, Torino, Einaudi 2021.
- Felice Tocco, L’Isagogicon moralis disciplinae di Leonardo Bruni aretino, in «Archiv für Geschichte der Philosophie» VI (1892), pp. 157-169: 157.
- Per l’opera di Lorenzo Valla, basti il rimando all’edizione già citata a cura di Maristella de Panizza Lorch, Laurentii Vallae De vero falsoque bono, Bari, Adriatica, 1970. Sui rapporti tra Lorenzo Valla e l’umanesimo bolognese, cf. i contributi in Gian Mario Anselmi e Marta Guerra (edd.), Lorenzo Valla e l’umanesimo bolognese. Atti del Convegno internazionale. Comitato nazionale VI centenario della nascita di Lorenzo Valla. Bologna, 25-26 gennaio 2008, Bologna, BUP 2009.
- Sull’argomento, cf. Maristella de Panizza Lorch, Voluptas, molle quodam et non invidiosum nomen: Lorenzo Valla’s defense of voluptas in the Preface to his De voluptate, in Edward P. Mahoney, Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honour to Paul Oskar Kristeller, Leiden, Brill 1976, pp. 214-228.
- Su tutto questo, Vera Tufano, Bartolomeo Facio, cit.
- Alan Ryder, Alfonso The Magnanimous: King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 327: si cita da Giannozzo Manetti, De excellentia, cit., p. 31.
- La citazione è tratta dalla recente edizione critica dei Sermones di Codro: Loredana Chines e Andrea Severi (ed), Antonio Urceo Codro. Sermones (I-IV). Filologia e maschera nel Quattrocento, Roma, Carocci, 2013, pp. 200-203.
- Sul ruolo di Ficino per gli sviluppi della discussione su voluptas e dintorni, si veda il recente volume di Raphael Ebgi, Voluptas. La filosofia del piacere nel giovane Marsilio Ficino, Pisa-Firenze, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2019.
- Per la biblioteca di Beroaldo, si veda Fulvio Pezzarossa, «Canon est litterarum», cit.
- Per la numerazione dei paragrafi, ci si rifà al testo di prossima edizione.
- Su tutto questo si veda Fulvio Abbamonte, Ut Ciceroni videtur, homini definiendi peritissimo: strutture dialogiche e uso di Cicerone e della poesia latina nel De humanae vitae felicitate di Bartolomeo Facio, in «Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge» online, 128-1 (2016).
- Tra i Padri della Chiesa, Agostino è il più citato. A Lattanzio, così importante per Bartolomeo Facio, viene riservata una sola citazione sulla fortuna umana (cf. par. 24).
- Gli scrittori cristiani non sono affatto assenti dalla trattazione di Beroaldo, ma sono certamente interrogati in modo completamente diverso da quello del De humanae vitae felicitate di Facio, nel quale in particolare Lattanzio assolve una funzione risolutiva per la questione filosofica di fondo: la via alla felicità di Beroaldo non sarà, come anticipato, teologica.
- [29] Aristoteles tamen huic Solonis sententiae alacriter reclamat ac refragatur qui ait, in primo Ethicorum, beatos dici viventes, cum felicitas operatio sit. In questa definizione, come si vede, non c’è soltanto un rifiuto di una prospettiva di felicità ultramondana, ma anche una negazione della prospettiva soloniana – derivata dal mito erodoteo – secondo cui si possa dire felice una persona soltanto il giorno della sua morte, potendone analizzare ex post l’intera vita.
- Franco Bacchelli, L’insegnamento di umanità, cit., p. 161.
- Per qualche esempio a proposito in particolare delle questioni matrimoniali di Beroaldo, cf. Franco Bacchelli, L’insegnamento di umanità, cit., pp. 164-167.
- Fil. 3:19.
- Declamatio ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiositate disceptantium.
- Mi pare che la traduzione di questo epigramma sepolcrale (molto più che i Salmi o altro) possa essere la fonte alla base del carmen de brevitate vitae che Severi ha riattribuito a Tifernate (riattribuzione che trova in questo addentellato un’ulteriore conferma): su tutto questo, cf. Andrea Severi, Leggere i moderni con gli antichi e gli antichi coi moderni. Petrarca, Valla, Beroaldo, Bologna, Pàtron, 2017, pp. 73-98.
- “Aristotele, nel settimo libro dell’Etica a Nicomaco, dimostra che il piacere non è il bene più importante, dal momento che dice che i piaceri impediscono la saggezza e quanti più sono, tanto più la annebbiano, il che è evidente nelle cose amorose”.
- È assai interessante notare come il riferimento all’idea attribuita ad Ippocrate secondo la quale il coito sarebbe una versione ‘in minore’ di un attacco epilettico (Hippocrates prodidit τὴν συνουσίαν εἶναι μικρὰν ἐπιληψίαν, idest coitum esse levem morbum comitalem), tratta o da Aulo Gellio, Noct. XIX 2,9, o da Macrobio, Saturn. II, 8,16, ricorra anche nel De vita di Marsilio Ficino, del 1489 (Harry Vredeveld, Hippocrates coitum morbo similem iudicavit: a note on Marsilio Ficino De Vita I, 7, in «Bibliothéque d’Humanisme et Renaissance» LX/3 (1998), p. 741). La coincidenza non può essere considerata un segno della lettura beroaldiana del testo di Ficino, poiché Beroaldo riporta anche il testo greco che aveva potuto leggere soltanto sui due classici latini, ma testimonia l’interconnessione tra ambienti diversi e testi diversi – ma interessati alla medesima tematica della voluptas – scritti a pochissimi anni di distanza l’uno dall’altro.
- [12] Et illud imprimis quod scribit Dion Prusensis regnum esse rem arduam, laboriosam, plenam curarum, plenam negotiorum quae incommoda principes ipsos saepe perturbant. Filelfo tradusse l’orazione sulla presa di Troia di Dione Crisostomo di ritorno da Costantinopoli: come è noto, di lì a pochi mesi, nel 1428, si sarebbe insediato a Bologna.
- [14] Hinc apud antiquos grecos illustrissumus quisque pastor erat, ex quo alios graeco vocabulo polyarnas, alios polymelas, alios polybustas vocitarunt, a multitudine videlicet agnorum, ovium ac bovum.
- Siamo qui di fronte a quella che Bacchelli ha definito la «condanna agli aspetti più ‘inumani’ dello Stoicismo, che ricomparirà, toccante di vita vissuta, in un excursus al commento delle Tuscolane» (Franco Bacchelli, L’insegnamento di umanità, cit., p. 161).
- «Rerum omnium quibus humanam felicitatem constare certum est tria omnino sunt genera: unum quidem in anima, alterum vero in corpore situm, tertium autem extrinsecus arcessitum, quod externum nominamus», da Andrea Severi, Filippo Beroaldo il Vecchio, cit., p. 74, n. 108.
tag: De felicitate, felicità, Filippo Beroaldo Seniore, Rinascimento, Umanesimo bolognese
Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2023 Federico Diamanti








