Anthroposcenes. L’arte contemporanea e il suo doppio cinematografico al Biografilm Festival di Bologna
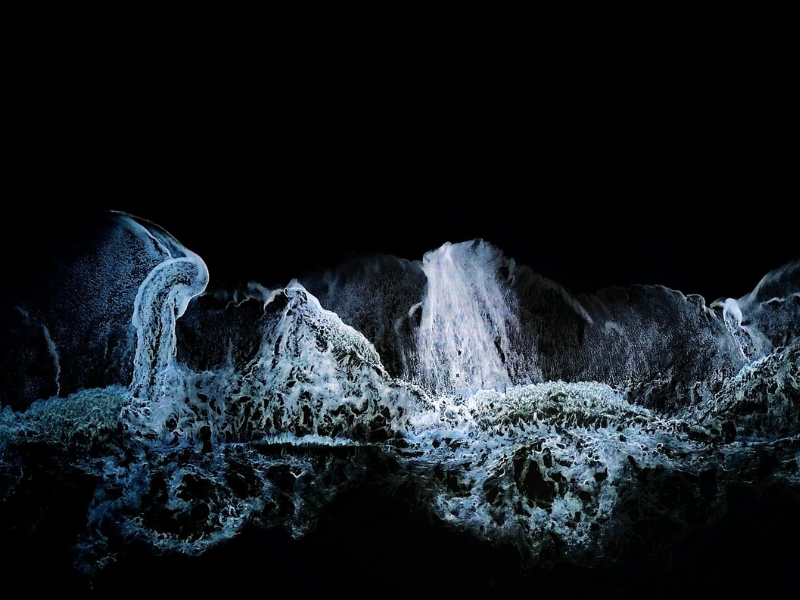
Alessandra Mantovani, Anthroposcenes. L’arte contemporanea e il suo doppio cinematografico al Biografilm Festival di Bologna, «Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche», 57, no. 33, giugno 2024, doi:10.48276/issn.2280-8833.11487
Introduzione
a. Panoramica
Questo studio propone un’analisi delle biografie di artisti contemporanei (film e documentari) in ambito cinematografico, prendendo in esame una rassegna specializzata nel genere biopic, a partire dal titolo programmatico e mai cambiato: il Biografilm Festival.
Inaugurata nel giugno 2005, la rassegna bolognese giungerà nel 2024 alla ventesima edizione. Fin dagli esordi ha presentato programmi dedicati alla celebrazione di “vite” distintesi per eccezionalità in ogni ambito antropologico: spettacolo, musica, scienze, sport, difesa dei diritti umani. Riservando un’attenzione via via crescente alle relazioni tra arti figurative e cinema, con nuove sezioni create a questo scopo.
Un’evoluzione inevitabile, a causa dell’interesse di un pubblico sempre più “emancipato” sull’argomento; cui fa da controcanto un’offerta incrementata di film biografici o autobiografici su vita e opere di artisti nostri coevi.
La ricerca si concluderà tentando una disamina delle reciproche interazioni tra cinematografia e visual art. E formulando alcune ipotesi sulla “traducibilità” del linguaggio di quest’ultima nei vari media, in particolare quello cinematografico.
b. Metodologia adottata
L’esame di un genere così composito come quello (auto)biografico nella cinematografia, a causa delle influenze derivanti dal contesto storico, sociale e politico, nonché culturale in cui nascono queste narrazioni, non può avvalersi di un’ermeneutica esclusivamente “interna”: gli strumenti offerti dalla critica storico-artistica non sono sufficienti per isolare, ad esempio, le ideologie che hanno contribuito all’identificazione o agli scostamenti operati da un cineasta (o da un filone cinematografico) con o “contro” determinati stilemi / cliché.
Si utilizzeranno perciò metodologie di analisi mutuate anche dalla filosofia (di basilare importanza i contributi sul cinema che ci ha lasciato Gilles Deleuze), dalla psicanalisi (Jacques Lacan: la “fase dello specchio” e il “trauma del reale” esposti nei Saggi e nei Seminari), dall’antropologia (Jean-Pierre Vernant), dall’iconografia (Erwin Panofski, George Didi-Huberman), dalla mediologia (Walter Benjamin e i suoi epigoni), nonché dalla teorizzazione spesso formulata dagli stessi cineasti, la c.d. politique des auteurs (Guy Debord, Jean-Luc Godard).
c. Sinossi dei capitoli
Il capitolo I, Prima dei festival. “L’âge d’or” delle vite d’artista su pellicola, introduce una breve storiografia del genere bio-cinematografico, proponendo alcune casistiche esemplari e metodologie di analisi. Si tenta così di isolare “stereotipi” e narrazioni che si ripropongono come mitemi nelle prime celebrazioni di artisti dell’età moderna e contemporanea: ad esempio il cliché “cristologico” dell’artista-genio, folle o emarginato; oppure, al contrario, l’artista-genio che ha raggiunto la fama e il successo in vita, intuendo le possibilità performative offerte dal nuovo mezzo (il caso di Picasso, che inaugura un genere inedito, il film “processuale”, offrendo all’occhio della mdp il proprio gesto creativo).
L’artista e il suo “doppio” melancolico (prima ancora che cinematografico) possono essere indagati utilizzando la lente psicanalitica (Lacan), antropologica (Vernant), oppure iconografico-allegorica (teorie e immagini sulla Melancholia).
Nel capitolo II, Biografilm, non solo biopic, si analizza il festival cinematografico come vettore di ulteriori cliché o, al contrario, di nuove chiavi interpretative.
Famose rassegne cinematografiche (Cannes, Venezia) annoverano numerose selezioni di (auto)biografie di cineasti che hanno deciso di raccontare sé stessi scegliendo come “doppio” un artista del passato (Andrej Tarkovskij con Andrej Rublëv, il monaco pittore); oppure costruendo un flusso di immagini della memoria propria e insieme collettiva (Jean-Luc Godard). Nel caso del Biografilm, forse il caso più luminoso è il documentario di Wim Wenders sul grande fotografo Sebastião Salgado.
Il capitolo III, Melanconici e integrati, completa l’analisi degli exempla tratti dal Biografilm Festival, riprendendo le mosse dagli enunciati del filosofo e regista Guy Debord, che dopo aver sviluppato le teorie situazioniste sulla deriva dell’arte e sulla spettacolarizzazione delle merci, le traduce in un linguaggio cinematografico del tutto inedito.
Ci si chiede poi come la tecnica da lui inventata abbia fatto breccia nel piccolo schermo grazie all’intuizione di un gruppo di critici e autori (tra i quali Enrico Ghezzi), mentre il grande schermo pare aver subìto in molti casi una sorta di involuzione, orientandosi di nuovo verso la comoda soluzione del tributo “celebrativo” alle vite degli artisti e, dunque, rinunciando non di rado al tentativo di adottare, per descriverli, il loro stesso sguardo; e spesso, per di più, con la patente intenzione di adeguarsi a standard documentaristici televisivi in grado di garantire una sicura distribuzione del prodotto su qualsivoglia piattaforma o media.
Troviamo fortunatamente felici eccezioni: nello stesso Biografilm Festival vengono selezionati documentari che nascono con l’intento di raccontare una determinata pratica artistica, o un esponente di rilievo magari scegliendo la poetica di un’unica opera della sua produzione. Ne è un esempio Il padiglione sull’acqua, di Stefano Croci e Silvia Siberini: i due giovani registi hanno scelto la tomba Brion come unico oggetto metonimico della narrazione, concentrandosi sullo splendido, silente “Padiglione della Meditazione”, che in liquide lentezze compendia lo stile e tutte le aspirazioni del grande architetto Carlo Scarpa.
E poi gli outsider: artivisti come Ai Weiwei che utilizzano il proprio fare arte anche allo scopo di denunciare abusi e soprusi del potere; o delle mafie (Letizia Battaglia), o dell’ingiustizia che colpisce di nuovo chi già è stato vittima di una strage impunita (Christian Boltanski). E chi infine, come Elettra Fiumi, ritrova il tesoro archivistico del padre Fabrizio, architetto “radicale” e co-fondatore del Gruppo 9999, e decide di farne un film insieme toccante e divertente.
Scene da un matrimonio – Il connubio arte-cinema – Prefazione
Soltanto ciò che all’inizio fu capace di dissimularsi può apparire. Le cose
di cui cogliamo subito l’aspetto, quelle che somigliano, tranquillamente, non
appaiono mai. Sono evidenti [apparentes], certo – ma niente di più: non si
daranno mai come apparenti [apparaissantes]. Che cosa serve dunque
all’apparizione, all’evento dell’apparente? Che cosa serve subito prima che
l’apparente si richiuda nella sua sembianza che presumiamo stabile o
speriamo definitiva? Serve un’apertura, unica e momentanea, un’apertura
che attesti l’apparizione come tale. E qui emerge un paradosso, perché
l’apparente, nell’istante in cui si apre al mondo visibile, si vota a una sorta di
dissimulazione. Emerge un paradosso perché l’apparente, per un solo
momento, rende accessibile a noi mortali qualcosa che evoca il lato nascosto
o, meglio, l’inferno del mondo visibile – ed è il territorio della
dissomiglianza.
Georges Didi-Huberman, La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini
Il doppio legame tra arti figurative e cinema nasce forse – ante litteram, beninteso – con Las Meninas di Diego Velázquez: un’opera, è stato detto e scritto, “autocelebrativa”.
L’autore si pone a fianco dell’infanta Margherita, accompagnata da quella corte di personaggi che paiono sue emanazioni irrequiete. Quasi fosse un fotografo, poco prima dell’autoscatto si aggiunge a un gruppo, suggellando così la sua appartenenza a una élite. Ma sarebbe riduttivo pensare a una sorta di “autopromozione” del genio pittorico, che mostra, fra il resto, un’autentica familiarità con i reali di Spagna. Tutti i soggetti del ritratto, a eccezione forse dell’infanta, non sono in posa, sembrano essersi aggiunti durante il lavoro del pittore1, o sembrano essere sul punto di andarsene. Come don José Nieto, sul fondo: si appoggia allo stipite dopo aver aperto la porta, oppure rivolge un ultimo sguardo all’atelier prima di sparire risalendo le scale? E queste portano all’esterno, o ad altre stanze che possiamo solo immaginare, in dissolvenza nel chiarore? La coppia reale riflessa nello specchio al centro è il soggetto ri-guardante il lavoro del pittore di corte? Oppure è appena arrivata per una supervisione? Forse per questa visita inattesa Velázquez si discosta dalla grande tela (che noi in sincrono vediamo compiuta), si fa indietro sporgendosi?
A che punto è l’opera? Noi posteri la contempliamo terminata, ma probabilmente dall’altra parte del quadro, in questo preciso istante, non lo è. È nascosta al nostro sguardo, opaca: ne riconosciamo soltanto le dimensioni, l’importanza. Velázquez accondiscende a mostrare come lavora, ma il grande telaio nasconde l’opus, e il suo segreto. Una porta si è aperta sul fondo, apparentemente luminoso ma lontano e inaccessibile. Un’altra, davanti a noi, permette solo di intra-vedere: un’apertura «unica e momentanea, che attesti l’apparizione come tale»2.
Alcuni soggetti sono lì come per caso, una presenza effimera e distratta che non interroga né attribuisce importanza alla registrazione di quei attimi che scorrono. Ma altri personaggi – e lo stesso “regista” (Velázquez) – sanno di essere osservati, si voltano: ma chi guardano? I sovrani? Noi?
In quegli sguardi prevale la circostanza, il rispetto verso i regali committenti? O piuttosto la circospezione verso sconosciuti che si affacciano da un altro spazio e tempo?
Si è stabilito un contatto. Ma le solitudini restano tali. Come in un cinema capovolto, siamo interrogati da “immagini-tempo”3, che scorrono, anche se in un’immobilità apparente e perenne, mentre noi ci muoviamo scrutando ogni prospettiva e dettaglio.
Al cinema, seduti dinanzi allo schermo, possiamo catturare molte delle “immagini-movimento”4: non siamo “passivi”, così come non lo sono i soggetti di un’opera pittorica.
Assistiamo allo svolgersi di una “giornata tipo” nel workshop di Velázquez in Las Meninas (1656 ca), così come – agli antipodi cronologici e geopolitici – diveniamo testimoni di diverse “giornate” (che di “tipico” hanno peraltro ben poco) nella vita dell’artista-architetto e dissidente cinese Ai Weiwei narrate nel film Ai Weiwei: Never Sorry, un documentario del 2012 diretto dalla regista americana Alison Klayman. Insignito di “Premio speciale della giuria” al Sundance Film Festival nello stesso anno, venne inserito nella programmazione di numerosi festival, fra i quali spicca, con ogni probabilità, il Biografilm, ossia – va da sé – il fenomeno petroniano oggetto d’indagine in questa ricerca.
In Never Sorry Ai apre le porte del suo studio a Pechino, il “258 Fake”, e la regista documenta le varie fasi della Citizens’ investigation sulle vittime dei crolli di scuole nel Sichuan: il progetto pubblica i nomi dei cinquemila bambini rimasti schiacciati sotto le macerie degli edifici scolastici distrutti da un terremoto del 2008, denunciando le deliberate negligenze nella costruzione degli edifici.
L’accostamento tra le due modalità di autorappresentazione, quella del grande andaluso di età barocca e del nostro eroe contemporaneo, è meno forzato di quanto potrebbe apparire. È utile per tracciare una mappa che consenta di soffermarsi su un aspetto particolare del rapporto tra arte contemporanea e cinema: quello che riguarda non solo le “Vite de’ più eccellenti” tra gli artisti nostri coevi, o il ciclo di vita di una singola opera, ma anche le narrative sviluppatesi intorno ad esponenti di valore meno noti o emergenti. E che comprenda l’analisi dei nuovi strumenti, stilistici e multimediali, divenuti indispensabili. Che si offrono alla settima arte per riflettere su sé stessa, come mezzo e come fine.
I. Prima dei festival. “L’âge d’or” delle vite d’artista su pellicola
I.1. Come in uno specchio. Tra mitologia e psicanalisi
Per le imago infatti, i cui volti velati è nostro privilegio veder profilarsi nella nostra esperienza quotidiana e nella penombra dell’efficacia simbolica, l’immagine speculare sembra essere la soglia del mondo visibile, sia che ci fondiamo sulla disposizione speculare presentata nell’allucinazione e nel sogno dall’imago del proprio corpo, che si tratti dei suoi caratteri individuali, delle sue infermità o delle sue proiezioni oggettuali; sia che notiamo il ruolo dell’apparato dello specchio in quelle apparizioni del doppio in cui delle realtà psichiche, peraltro eterogenee, si manifestano.
Jacques Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io5
La pazzia di una giovane donna che vive su un’isola disabitata – Fårö, luogo in cui morirà lo stesso Ingmar Bergman – ci introduce al tema del dionisiaco nel cinema: è Karin, e il suo male è incurabile, sempre dilaniato tra l’orrore e l’ossessione delle voci che avverte, e l’euforia di una seconda realtà che sperimenta lei sola, e la fa sentire libera. È consapevole della sua malattia, la legge ogni giorno negli sguardi dei tre uomini che le vivono accanto, senza poterla aiutare: il marito Martin la ama ma vorrebbe appoggiarsi a lei, il fratello diciassettenne Minus la insegue e la fugge tormentato, il padre David la studia cercando un’ispirazione letteraria venuta a mancare o più probabilmente mai conosciuta. La “menade” di Bergman patisce tutta la sofferenza della “divinità” che ha preso possesso del suo destino: la realtà è in frammenti, senza speranza di ricomporsi in una guarigione.
«Come se il velo di Maia fosse stato strappato e sventolasse ormai in brandelli»6.

Il film di Bergman è del 1961, primo lungometraggio della trilogia sul Silenzio di Dio, e il titolo rinvia al Nuovo Testamento.
12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α, 13:127.
12 Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto.
I Corinti, 13:128.
Il termine neotestamentario ἔσοπτρον è ambiguo, e può restituire sia “lente” che “specchio”, anche se viene preferita quest’ultima traduzione (o meglio tradizione). In realtà l’uso testuale originario è in linea con l’uso rabbinico del termine אספקלריה, aspaklaria, un prestito dal latino specularia, pietre chiare e levigate usate per le finestre, traslucide ma non quanto il vetro, né riflettenti come uno specchio. Superfici, lenti, o vetri smerigliati; attraverso i quali era consentita solamente una visione sfocata, dai contorni non definiti.
Nel Talmud Babilonese (Yevamot 49b) si parla del privilegio di Mosé, unico veggente dotato di una percezione se non diretta quantomeno accurata, come se osservasse «attraverso una lente limpida». Mentre a tutti gli altri profeti erano riservate visioni metaforiche, indirette, mediate da «uno specchio oscuro» [aspaklaria]9.
I due strumenti, specchio e lente, non sono semanticamente sovrapponibili, com’è ovvio. Non a caso
Lacan insiste sull’importanza dello studio dell’ottica, per chi come lui si occupi di psicoanalisi: spingendosi fino a spiegare la Traumdeutung (Interpretazione dei sogni) di Sigmund Freud con l’esperimento del “mazzo di fiori capovolto”10. A maggior ragione l’ottica non potrà essere trascurata da chi si occupi di arti visive.
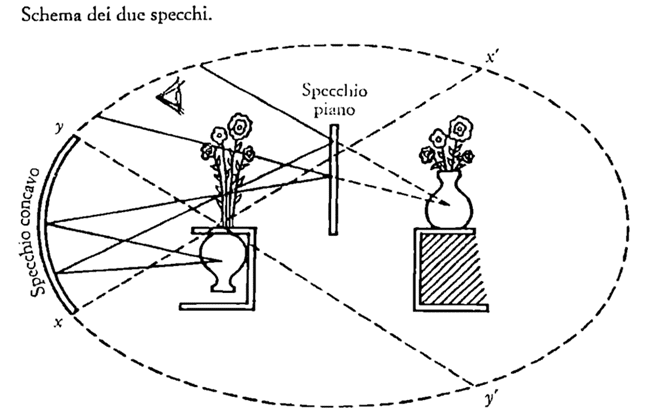
A dieci anni di distanza dagli esiti bergmaniani appena descritti, un altro grande cineasta si cimenta con un soggetto che presenta più di un’analogia con il suo precedente.
Images (1972) di Robert Altman è il secondo capitolo di una trilogia sulla schizofrenia femminile. Qui la scomposizione dell’Io, più che ai dialoghi o monologhi, è affidata alla moltiplicazione di frammenti, oggetti, specchi, fantasmatizzazione della realtà, fino all’incontro della protagonista con il proprio doppelgänger.

Cathryn – a differenza della bergmaniana Karin – non riflette, è riflessa. Apparentemente non soffre per la propria condizione, o comunque trova il modo di sopravvivere e convivere con la propria malattia. Semmai, ciò che accomuna l’umana vicenda dell’una e dell’altra è la desertificazione, che insieme le isola e offre loro rifugio. Ma costituisce anche l’ambiente ideale, nel silenzio, per l’affiorare del disagio psichico.
Come questo “humus”, questa melancholia si leghino alla creatività, alle “Vite de’ più eccellenti” e non solo a quelle di sconosciuti prossimi nostri, è materia fertile, che fin dagli albori ha attirato lo sguardo del cinema.
I.2. Agiografie di artisti. L’immagine e il suo doppio
Un «doppio» è tutt’altra cosa che un’immagine. Esso non è un oggetto «naturale», ma non è neanche un prodotto mentale: né un’imitazione d’un oggetto reale, né un’illusione della mente, né una creazione del pensiero. Il doppio è una realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, s’oppone, per il suo carattere insolito, agli oggetti familiari, allo scenario ordinario della vita.
Jean-Pierre Vernant, L’immagine e il suo doppio. Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte
[Paul] Dirac predisse che in aggiunta agli elettroni dovesse
esistere un’altra particella, chiamata positrone (scoperta al Caltech da Anderson),
che è necessariamente collegata all’elettrone.
Tutte le proprietà di queste due particelle obbediscono
a certe regole di corrispondenza:
le energie sono uguali; le masse sono uguali; le cariche sono opposte;
ma, più importante di qualsiasi altra cosa, le due, quando si incontrano, possono annientarsi l’una
con l’altra, e liberare la loro intera massa in forma di energia, diciamo raggi γ.
Il positrone è detto antiparticella dell’elettrone,
e queste sono le caratteristiche di una particella e della sua antiparticella.
Dall’argomento di Dirac era chiaro che tutte le restanti particelle del mondo
dovessero pure avere antiparticelle corrispondenti.
Richard Feynman, La fisica di Feynman. 3. Meccanica quantistica11
Sostiene Marco Senaldi12, nella nuova edizione del suo saggio Van Gogh a Hollywood, che il metodo detto dell'”anamorfosi culturale” (messo a punto dal filosofo Slavoj Žižek) sia in grado di analizzare con efficacia i vari mitemi soggiacenti a quel particolare genere che si chiama biopic, ovvero la biografia di un artista, sia che si tratti della narrazione di un’intera esistenza, o di una parte di essa, mediante il racconto della genesi di un’opera.
Il termine non va confuso con quello che nella critica d’arte si individua come “anamorfismo”: quest’ultimo infatti è un effetto, un’illusione ottica grazie alla quale un’immagine, intenzionalmente proiettata dall’artefice sul piano in modo distorto, risulta riconoscibile soltanto in determinate condizioni di osservazione. L’esempio canonico è dato dal celebre dipinto di Hans Holbein il Giovane Gli ambasciatori (1533), alla base del quale si nota una figura che attira l’attenzione per la sua estraneità apparente, ma con elementi familiari: ponendosi a destra, vicino al piano dell’opera, si è in grado di cogliere la figura anamorfizzata nella sua interezza, un teschio umano. La tecnica che permette di “sintetizzare” e infine ottenere questo genere di effetto visivo è detta “anamorfosi”: un’arte, per l’appunto. L’autore ne fa un uso consapevole, dimostrando così non soltanto una precisa e sulfurea intenzionalità di lettura, bensì dando prova di una padronanza pressoché totale delle regole prospettiche, e della loro sovversiva distorsione.
Lo stesso metodo viene utilizzato da Žižek e Senaldi per analizzare, decostruendoli, quegli anamorfismi ideologici, culturali, immaginari, che si sono depositati e stratificati “dentro” le varie narrazioni delle vite degli artisti (a seconda del periodo storico), generando, in letteratura ma soprattutto al cinema, identità del tutto differenti (l’ossimoro è voluto) per uno stesso soggetto.
Si tratta di anamorfismi in larga parte inconsapevoli, di cliché che un pubblico proietta su un oggetto del desiderio (in questo caso l’artista-eroe, apollineo o tragico): la captazione degli stessi è compito di sceneggiatori, produttori, registi, e di quanti si occupano di restituire un “prodotto” cinematografico attraente; e, in qualche caso, cinema come arte. «Il campo ideologico infatti è afflitto da una certa “impossibilità strutturale” e il riempitivo immaginario che ottura (e al tempo stesso nasconde) questa falla si scorge solo attraverso una lettura radente, obliqua, anamorfica appunto»13.
Secondo Senaldi, questa pratica sarebbe utile a prevenire, tra l’altro, quel “limite” che il filosofo individua nello strutturalismo di Roland Barthes. In Miti d’oggi14, pur anticipando i tempi nella sua analisi dell'”immaginario” come fenomeno sociale, Barthes si servirebbe del mito come metalinguaggio o sistema semiologico di secondo livello, giungendo ad affermare che “la nostra società borghese” sarebbe paradossalmente la più esposta al mito. Quest’ultimo viene visto come un passaggio dal reale all’ideologico, “svuotando il reale” e trasformando il mondo in “immagine del mondo, rovesciata”, come in una “camera oscura”. Il quadro teorico sarebbe corretto, ma non l’analisi dei singoli epifenomeni.
L’errore, per Senaldi, consisterebbe in una reinterpretazione anacronistica della cultura occidentale, ricondotta a forza entro un quadro “analitico” pertinente al passato. Barthes “non si accorgerebbe” di essere del tutto calato dentro quei miti che vorrebbe demistificare. Occorre tuttavia ricordare che in Barthes l’analisi non è mai disgiunta dal divertissement linguistico, e ogni “mito” è, letteralmente, un racconto, non privo di pennellate surreali.
Se dunque i fenomeni, in questo caso le biografie di artisti (ovvero l’arte contemporanea risemantizzata in narrazioni diverse o rovesciate a seconda del contesto culturale in cui nascono) “ri-generate” dal cinema, vanno osservate con uno sguardo “in sezione”, lo studio non potrà non dotarsi di un proprio “cassetto degli attrezzi”, un glossario di termini che inevitabilmente faranno riferimento anche agli strati più antichi del linguaggio.
Così ad esempio si muove anche Victor Stoichita15. In Breve storia dell’ombra. Dalle origini della pittura alla pop art, il critico rilegge “attentamente” (sic) Plinio il Vecchio, che a sua volta ritorna a parlare del “mito” fondativo dell’arte in due passi della Naturalis Historia. Per poi passare allo “Stadio dell’ombra e stadio dello specchio” (Lacan). Interrogando, sulle orme di ciò che già misero in atto Lacan, Baudrillard, Vernant, anche il lessico arcaico: per giungere a risultati di ricerca sulla natura delle immagini e dei loro “doppi”, che ancor oggi sono imprescindibili. Specie accostandosi alla critica dell’arte alchemica per antonomasia, il cinema, popolato di doppi, duplicati, sosia di sosia, e non soltanto di remake.
Il lavoro di Marco Senaldi16 resta tuttavia un unicum – per la specificità del tema affrontato – nel panorama della critica cinematografica. Suggerisce ulteriori chiavi di lettura delle narrazioni biografiche o autobiografiche di artisti contemporanei, che mi appresto ad illustrare.
I.3. Melancholia e Felicitas. Autobiografie e biografie
Ci sono diversi modi di fare un film. Come Jean Renoir e Robert Bresson, che suonano.
Come Sergej Ėjzenštejn, che dipinge. Come Stroheim, che scriveva romanzi sonori all’epoca del muto.
Come Alain Resnais, che scolpisce.
E come Socrate – intendo Rossellini – che si limita a fare della filosofia.
Insomma, il cinema può essere tutto allo stesso tempo, giudice e parte in causa.
Spesso sorgono dei malintesi perché ci si dimentica di questa verità.
Si rimprovererà Renoir di essere un cattivo pittore quando nessuno direbbe questo di Mozart.
Si rimprovererà Resnais di essere un cattivo romanziere
quando nessuno si sognerebbe di dirlo di Giacometti.
Insomma, si confonderà la parte col tutto,
negando all’uno e all’altro il diritto di escludersi o di appartenersi.
È qui che comincia il dramma. Il cinema è catalogato o come una parte o come un tutto.
Se fate un western, niente psicologia, mi raccomando. Se fate un film d’amore, mi raccomando, nessun pestaggio o inseguimento.
Quando girate una commedia di costume, niente intreccio!
E se c’è un intreccio, allora non approfondite i caratteri.
Guai a me allora, che ho appena girato Una donna sposata, un film dove i soggetti sono considerati come oggetti, dove gli inseguimenti in taxi si alternano alle interviste etnologiche,
dove infine lo spettacolo della vita si confonde con la sua analisi;
insomma, un film dove il cinema scorrazza libero e felice di essere soltanto quello che è.
Jean-Luc Godard17
Nell’ultimo film (Le livre d’image), ancor più di quanto accadde con Histoire(s) du cinéma, Godard ci parla di sé, della sua vita di cineasta di ottantotto anni, poco prima di rinunciarvi. Ricorrerà al suicidio assistito nella sua casa di Rolle in Svizzera, il 13 settembre 2022. Una fonte vicina al regista avrebbe dichiarato: «Non era malato, era solo esausto. È stata una sua decisione e per lui era importante che si sapesse»118. Come che sia, Le livre d’image è l’ultimo film diretto da Godard, e non solo ultimo in ordine cronologico. Non è un testamento. È il suo ultimo dono. Non sappiamo se lo considerasse tale.
Le immagini appaiono e scompaiono in veloce successione, così come il pensiero. Il regista commenta a voce bassa, quasi un sussurro, con lentezza.
La citazione in cui l’Autore si identifica è un apocrifo attribuito a Bertoldt Brecht: «È il frammento a dire la verità». L'”aforisma” tuttavia non è presente in nessuna delle sue opere letterarie o teatrali a noi note. È un fake? Ma ha poi importanza che lo sia, specie considerando che lo stesso Godard intenzionalmente si contraddice in molte dichiarazioni rilasciate a proposito della propria cinematografia? La “verità” è “utile”, secondo Godard? O piuttosto, così come nel predicato brechtiano, soltanto il soggetto, il “frammento”, ha valore?
E che cosa significa la chiusa (che rivela maggiore convinzione proprio perché somiglia al prologo di un nuovo film, una nuova opera) «un film dove il cinema scorrazza libero e felice di essere soltanto quello che è»? Libero e felice. Non è solo un’endiadi, non è un cliché: la condizione di “felicità” è isolata ed esaltata, come un fermo immagine impresso nella rétina. Forse vale la pena soffermarsi per un momento su questo termine di derivazione latina, felicitas, e sul suo corrispettivo greco εὐδαιμονία. Ciò che li accomuna è il riferimento a una condizione di pienezza, bien-être, uno stato di grazia creativo che nulla ha a che vedere con il “superomismo”, ma molto ha invece a che spartire con il nietzchiano “diventare ciò che si è”, un momento in cui una creatura (intesa anche come opera), guidata dal proprio dàimon benevolo, realizza il proprio télos, prima di richiudersi nell’oblio. Uno stato “eudemonico” che ha il proprio corrispettivo opposto nella melancholia, il trauma del Reale, il taglio, la “perdita di senso”.
Si tratta di una coniunctio oppositorum, poiché è evidente quanto spesso opere (d’arte, d’ingegno) che vengono considerate il risultato di uno “stato di grazia”, di una particolare “fecondità/felicità espressiva” (in un autore, un movimento, in un determinato periodo storico), siano scaturite da quel “male di vivere” che affligge ogni atomo, ogni particella di questa parte di universo.
Molti individui ne avvertono “l’aura”, lo riconoscono fin dai primi sintomi poiché ne sono stati spesso visitati; a volte vinti. Il lento salire di un umore oscuro, che può precedere o seguire una svolta decisiva, una trovata, un’intuizione, un parto, o, al contrario, una perdita, un vuoto. E questo umore si concretizza, diventa solido, possiamo anche vederlo materializzarsi davanti a noi, pur senza riuscire a dargli una forma, come fosse un coagulo. Una stele funeraria. Una pietra.
Chi o che cosa ha convocato (o evocato) quell’oggetto? E perché si è materializzato proprio lì, in quello spazio (che è anche tempo) con il quale non ha (più) alcuna apparente relazione?
Così Albrecht Dürer vede improvvisamente quel poliedro ingombrante e alieno, concreto e pesante, regolare ma privo di forma: un ossimoro, Tanto che nemmeno la Sapienza alata, scura in volto, pure con l’ausilio degli strumenti di misura e riproduzione di cui si circonda, riesce a definirlo, e si domanda da dove provenga. Forse possiamo concepire Melencolia come un racconto autobiografico sub specie allegoriae di Dürer: la sua ricerca costellata di interrogativi senza risposta, in un’epoca piena di incognite e inquietudine come l’umanesimo.
E il poliedro ricompare: più levigato e lucido, regolare ma sempre informe, più nero del nero. Il monolito flottante nel vuoto accompagna in silenzio l’Odisseo di Stanley Kubrick, che nel film si chiama David e che, pur non essendo un eroe, è dotato di “multiforme ingegno”: si ritroverà comunque a navigare solo. L’apparizione è rara e sempre inattesa, ma coincide con alcuni “allineamenti” evolutivi, e suggella la fine del viaggio. Il film è del 1968, ma forse la data è più casuale che “fatale”. Non è dato riconoscere, infatti, un Kubrick artista o regista esplicitamente “politico”, nonostante i temi di riflessione ricorrenti: le guerre, la violenza, sono sempre protagonisti. Ma l’altra vena aurifera, la relazione fra le arti (cinema-letteratura, cinema-pittura) è sempre ugualmente presente, nonostante l’autore non si conceda mai estetismi estremi o superflui.
Melancholia stessa ha un’evoluzione: la sua portanza, il suo peso sempre maggiori ne hanno fatto infine un pianeta “errante”. Un luminoso pianeta blu, immagine speculare del nostro. Il gemello oscuro della Terra, la sua fine. In base alle stesse dichiarazioni di Lars von Trier, il film (distribuito nel 2011) è stato concepito durante e dopo un lungo periodo di “depressione”. E il “peso” autobiografico si avverte nel desiderio di annientamento che colpisce duramente la protagonista. La quale “vede” la fine avvicinarsi proprio mentre è al culmine dei festeggiamenti per le sue nozze. Si allontana nel buio, tra l’erba si abbandona a un ultimo disperato rapporto sessuale con un ospite, prima di lasciarsi avvolgere dalle spire della vegetazione, galleggiando su acque scure come Ofelia. E il mattino successivo è già quello di mesi dopo: il male le ha tolto le forze, ogni cura di sé, e il cibo “sa di cenere”. Ma la notte ritrova le energie per alzarsi, perdersi di nuovo tra la vegetazione, sdraiarsi ed esporsi a quella luce blu che si fa sempre più splendente. Vede l’apocalisse avvicinarsi e questo le dona sollievo, le restituisce le forze, ogni notte. Finché arriva il mattino del trauma: per gli “altri”, che perdono tardivamente ogni illusione di salvezza. Non per lei, che il trauma lo ha già vissuto e ora vede compiersi il suo desiderio di cancellazione di un mondo di cui “nessuno sentirà la mancanza”: un atomo oscuro del male. E quel mattino è splendente, sorride, fa colazione, l’appetito è recuperato.
Questo è il mistero di melancolia. Che ha molti epiteti contemporanei: depressione maggiore, schizofrenia, sindrome bipolare, ciclotimia. Ma che potremmo anche evocare diversamente: dea “dagli occhi lucenti”, la “vergine”, la “venerabile”, divinità infera e portatrice di morte come Persefone, ma anche Soteira (“salvatrice”), giacché senza il suo ritorno non esisterebbero stagioni, e l’umanità vivrebbe in perenne carestia.
Dal suo influsso si genera un’opera come Campo di grano con volo di corvi di Van Gogh: una delle “sintesi” più felici, per l’appunto: in cui melancholia e stato di grazia si mostrano insieme.
Marco Senaldi19 sottolinea come, tra tutte le biografie cinematografiche del pittore olandese, forse soltanto i film di Maurice Pialat (del 1991) e di Akira Kurosawa (“Sogni”, del 1990) restituiscano il racconto dell’arte come vita del pittore, senza nulla concedere agli stereotipi hollywoodiani, né alle diagnosi (autorevoli o presunte) sulla sua malattia.
Questi cliché, come si vedrà, affliggono tuttora buona parte del “filone biografico” nella cinematografia, e non soltanto oltre oceano. Per attrarre il “grande pubblico” e interessarlo a un’arte difficile, alchemica come quella contemporanea, il cinema ha ancora bisogno di “miti”?
II. Biografilm, non solo biopic
II.1. Ossessione festival
Tutti i festival si muovono (nel loro tendere alla fiera, nel loro essere attesi e desiderati da essa) tra Duchamp e Warhol, ovvero nello spazio minimo o inesistente tra un senso e l’altro o tra il verso e il retto del nastro di Moebius disegnato dalla fuga dell’/dall’arte più radicale del secolo (troppo rapidamente e poi mai troppo presto e fino in fondo trascorso, la rottura della trasparenza stessa del guardare, nel GranVetro (a sua volta poi comodamente trasportabile in valigetta), e il precipitarsi – attraverso quello squarcio – di/da tutto il mondo readymade. Anche il festival del volo a vela, o delle macchine agricole e dell’agricoltura, o quello del vento (dei venti, convocati e riprodotti come per magie da castelli atlantici…).
Ma quello di cinema è il più abissale nel movimento. Intanto, come fa il cinema, si (ri)occupa di tutto, proprio nel senso riflessivo estremo del poter essere rioccupato da sezioni tematiche dell’infinito esser visivamente occupato di qualunque immagine/film in qualunque istante (festival di ‘cinema e…’ o di ‘cinema di…’). E poi, con semplicità e banalità istituzionali, apparecchia una situazione fantomatica in cui sequenze più o meno organizzate e scelte di immagini registrate (quasi sempre registranti anche o specialmente figure ‘umane’) vengono esposte allo sguardo di persone all’uopo in tale situazione convocate. Situazione esemplare, in cui questo sguardo è supposto giudicare/(ap)prezzare rianimare immagini già registranti e rianimanti il vivere. Nel meccanismo, più o meno felicemente coatto, si ha un’irresistibile contaminazione, uno ‘stadio dello specchio’ moltiplicato (più che nel finale de La Signora di Shanghai) disseminato potenziato, una concomitanza in cui (come in ogni festival) sono esposte insieme sullo stesso set le cose/eventi/prodotti (artistici o meno) e le persone che di tale esposizione godono o soffrono, e nel caso del cinema questa presenza comune diventa un reciproco attestato di (in)esistenza: le immagini registrate irrealizzano e spettralizzano le immagini dei visitatori/spettatori, e questi derealizzano i film rispetto alla loro realtà tecnica propria entrando nel loro spazio squaternato, in contiguità assoluta eppure sempre separati dal vetro che pure si era rotto, acquari umani che si rimirano e sfiorano e intersecano.
Resta da dimostrare che nell’acquario vi sia ancora acqua, e che dall’altra parte vi sia ancora aria da respirare. Non è questione che si affronti, in un festival, rischiando di ledere la sua sostenibilissima leggerezza. Si preferisce trovare descrivere classificare i pesci, anche morti o boccheggianti, attraversando in apnea (il quasi soffocamento può perfino risultare erotico) il set festivaliero. La domanda su quanto questo ‘serva’ al cinema è quasi sempre mera e cinica ideologia, a coprire e occultare proprio quanto di prudentemente ma terribilmente esemplare affiora nella ‘situazione festival’. Quanto serva a far discernere e apprezzare di più i film ‘migliori’, a promuoverli, a distribuirli in seguito. Come se in una manifestazione così eminentemente spettacolare (fragilissima e di modesta incidenza reale su tutto ciò) fosse decisivo il tratto di un ruolo razionale e preciso nello spettacolo non proprio la sua ‘ammirevole’ o ‘spaventosa’ ambiguità parassitaria.
Enrico Ghezzi, Stati di cinema. Festival ossessione
Che genere di dispositivo è un festival? A cosa serve? Nel caso specifico dell’arte contemporanea – di cui il cinema è parte in causa – può realmente spiegarla, avvicinando il grande pubblico a un approccio che si preannuncia difficile? Possiamo/potremmo fare a meno di miti biografici, del pettegolezzo su star dell’arte, della musica, oggi anche della fisica?
Stando al resoconto di Enrico Ghezzi qui in esergo, risalente a ventidue anni fa e del tutto attuale, parrebbe una missione impossibile, essendo ormai anche l’evento festival entrato a far parte a pieno titolo delle mitografie consumistiche.
Interrogativi di questo tenore sono corretti? Sono chiacchiere salottiere? Forse no, in un momento in cui molti si stanno chiedendo come mai tanta risonanza mediatica, attenzione globale, un documentario che ha fatto incetta di premi nel 2022 (di Daniel Roher, approdato anche al Biografilm) non siano stati in grado di formare uno scudo protettivo sulla vita di Aleksej Navalny, il principale oppositore di un ex funzionario del KGB divenuto rapidamente primo ministro e poi presidente-plutocrate della Russia, a capo di un regime totalitario in grado di umiliare, mettere a tacere, eliminare gli oppositori, soffocando qualsiasi manifestazione di dissenso.
Ghezzi, già direttore del Taormina Film Fest, nel suo memoriale è così saturnino che il pulviscolo d’oro – la “sagra” del festival, il suo rito – si trasforma in particolato inquinante. E il male che lo affligge, quella “coazione a ripetere” che ha contagiato gli stessi spettatori, potrebbe essere neutralizzato solo affrontando un ripensamento radicale della “mostra”, che reca in sé qualcosa di “mostruoso”, appunto. Solo diventando esso stesso opera d’arte, e non più “programma” del (non) esserci, il festival potrebbe evitare di implodere, sprofondando sempre più nell’involuzione che lo ha trasformato in una vendita all’incanto. Un mercato che, una volta partite le roulottes, è pronto a far rotta verso luoghi del pianeta in grado di garantire la stessa aura, la stessa “esclusività” dell’evento, e quasi la stessa scaletta: Venezia come Cannes come Toronto…
Il Biografilm Festival – International Celebration of Lives (promosso dall’Associazione Fanatic About Festival), che ha aperto i battenti nel 2005 sotto la direzione artistica del critico cinematografico Andrea Romeo, è nato col proposito di “restringere il campo”, considerando e premiando unicamente narrazioni biografiche.
La prima edizione riserva all’arte contemporanea uno spazio “prudente” (aggettivo usuale nel fair play): Battaglia di Daniela Zanzotto (UK, 2004), sulla grande fotografa, nella selezione ufficiale; e Mu come Mu-nari di Paolo Castelli e Patrizia della Porta (Italia/1995), ritratto di Bruno Munari, presente nella sezione “Gente di Milano”. Quest’ultimo (della durata di soli 30’) era stato già proposto al Torino Film Fest nel 1996, e presentato come “un collage, un sillabario, un’autobiografia semiseria eppure esaustiva con varie testimonianze: di persone e di… oggetti”, una formula documentaristica in realtà serissima, classica.
Poi, per qualche edizione, silenzio. Ovvero: attenzione riservata ai fenomeni musicali e ai loro protagonisti, ma occorrerà attendere il 2008 per avere addirittura un’intera sezione dedicata all’artistar del XX secolo: Pop Lives! Warhol, le sue superstar e la Factory.
Dunque, 1-0 per Enrico Ghezzi? Se «Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo»20, allora possiamo considerare assodato anche il presupposto: “Tutti i festival si muovono (nel loro tendere alla fiera, nel loro essere attesi e desiderati da essa) tra Duchamp e Warhol”… Ergo: il festival ancora oggi deve soddisfare innanzitutto una serie di condizioni rituali necessarie e sufficienti a garantirne la sussistenza, la “felicità economica”, la “riuscita”. Ma forse l’evoluzione del suo destino narrativo, la sua stessa sopravvivenza, dipenderanno invece da una “rottura”, dall’irruzione del Reale, del trauma, da un’ammissione di infelicità.
II.2. Da Andrej a Andy. Andata e ritorno
(…) mi torna alla mente la lavorazione dell’Andrej Rubl’èv.
L’azione del film si svolge nel XV secolo e fu tormentosamente difficile immaginarsi
“come era ogni cosa allora’’. Dovemmo ricorrere a fonti di ogni genere:
all’architettura, ai monumenti letterari, all’iconografia.
Se ci fossimo messi sulla strada della ricostruzione della tradizione pittorica,
del mondo pittorico di quei tempi, ne sarebbe scaturita una realtà
della Russia antica stilizzata e convenzionale, una realtà che, nel migliore dei casi,
avrebbe richiamato alla mente le miniature o la pittura di icone dell’epoca.
Ma questa strada sarebbe errata per il cinema.
Non ho mai capito, per esempio, come sia possibile costruire una messa in scena
basandosi su opere pittoriche di qualsiasi genere.
Ciò significa creare un quadro vivente per poi venire ricoperti di lodi superficiali del tipo:
“Ah, come è stato colto lo spirito dell’epoca!”, “Ah, che persone raffinate!”.
Ma ciò significa uccidere sistematicamente il cinema…
Perciò uno degli scopi che ci prefiggemmo nel nostro lavoro fu quello di
ricostruire il mondo reale del XV secolo per lo spettatore di oggi, ossia di
rappresentare questo mondo in modo tale che lo spettatore non avvertisse
alcun esotismo da museo o da ‘monumento’ né nei costumi, né nel modo di
parlare, né negli aspetti della vita quotidiana, né nell’architettura.
Allo scopo di ottenere la verità dell’osservazione diretta — una verità, se così ci si può
esprimere, ‘fisiologica’ — ci toccò a tratti scostarci dalla verità archeologica
ed etnografica. Cademmo inevitabilmente nella convenzionalità,
ma si trattava di una convenzionalità esattamente opposta a quella del “quadro vivente”.
Ma io ero e resto convinto che possiamo raggiungere i nostri scopi nonostante le
complesse condizioni se andremo fino in fondo per una strada scelta con
precisione. Benché per fare questo occorra lavorare “senza vedere la luce del giorno”.
Sarebbe assai più semplice uscir fuori in una strada della Mosca di oggi
e girare con la macchina da presa nascosta.
Non possiamo ricostruire alla lettera il XV secolo, per quanto studiamo i suoi monumenti.
Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo21.
Il cinema – scrive Andrej Tarkovskij in Scolpire il tempo – deve in primo luogo «descrivere l’avvenimento, e non il proprio atteggiamento nei confronti di esso». Perciò il suo secondo lungometraggio, Andrej Rublëv (1966), non reca impressa l’intenzione di erigere un “monumento” biografico al monaco pittore di icone vissuto tra XIV e XV secolo. Il film descrive le fasi, le “stazioni” della vicenda spirituale del grande artista russo, che riflette sulla sua opera e sulla sua vocazione di pittore: prima coltivata con passione, poi rifiutata dopo il trauma di un omicidio, e infine ritrovata divenendo testimone di un’eccezionalità, lo stato di grazia di un fanciullo privo di ogni esperienza che riesce a forgiare una campana. Quest’ultimo episodio, l’ottavo girato in bianco e nero, segna la riconciliazione del monaco, “uomo tra gli uomini”, con l’arte, il medium in grado di raccogliere le istanze spirituali rendendole visibili e tangibili. Il senso ritrovato, la pace interiore raggiunta non prima di aver attraversato i fiumi infernali, vengono suggellati dal passaggio al colore nell’epilogo, con l’ostensione degli affreschi e delle icone realizzate dall’artista.
Il film venne censurato dal regime sovietico fino al 1971, ufficialmente a causa della “crudezza” realistica con cui erano state girate le scene di occupazione della città di Vladimir da parte dei Tartari: il momento in cui il Reale si squarcia, e Andrej Rublëv (e lo stesso Tarkovskij) entra in contatto con la condizione della sofferenza. Accade nel sesto episodio: gli invasori entrano in città e massacrano gli abitanti; ad essi si uniscono i russi ribelli. Per difendere una sordomuta che ha trovato rifugio in chiesa, mentre Rublëv sta dipingendo un giudizio universale, si trova costretto ad uccidere un russo. La profonda lacerazione lo travolge non soltanto in quanto vittima di violenza, ma quale involontario carnefice.
In questo episodio centrale si compie il suo destino di figura cristologica. La descente aux enfers lo renderà muto e incapace di dipingere per anni.

LE MYTHE: CROIRE
Dans Toutes les histoires, Godard soutient que le producteur de Citizen Kane est Irving Thalberg. Or ce n’est pas le cas. Mais en faisant volontairement l’erreur, l’important est ailleurs: il s’agit de mêler la figure d’un très grand producteur – convoquer la symbolique de l’argent – à la figure de l’artiste par excellence en la personne d’Orson Welles – y associer la symbolique de l’art. L’association argent/art rend compte de la définition la plus élémentaire du système hollywoodien. La démarche de Godard invite à croire à la valeur plus spécifiquement symbolique que proprement historique de la définition de ce système.
Frédéric Hardouin, Le cinématographe selon Godard22
[IL MITO: CREDERE
In Toutes les histoires, Godard sostiene che il produttore di Citizen Kane è Irving Thalberg. Ma non è così. L’errore viene enunciato intenzionalmente, l’importante è altro: consiste nell’accostare la figura di un grande produttore – che evoca il simbolismo del denaro – alla figura dell’artista per eccellenza nella persona di Orson Welles – e associarvi il simbolismo dell’arte. Il binomio denaro/arte è la sintesi più immediata del sistema hollywoodiano. L’approccio di Godard invita a considerare l’evidenza propriamente simbolica di questo sistema, piuttosto che la sua definizione puramente storica.]
«Orson Welles se moque de l’histoire», sentenzia la voce narrante dello stesso regista nelle Histoire(s) du cinema. «Si prende gioco». Una frase pronunciata “un po’ per celia”; ma che cela peraltro un programma. Come quando, rispondendo al critico André Bazin che nel 1956 tuonava “Montage interdit” nei Cahier (de doléances) du Cinéma, in aperta polemica replicò “Montage, mon beau souci” (Montaggio, mia bella occupazione). Secondo Bazin, il cinema avrebbe dovuto privilegiare campi lunghi e piani sequenza a scapito del montaggio. Godard, al contrario, aveva già iniziato a interessarsi al framing inteso come tecnica e insieme teoria: le immagini costruiscono il film, il montaggio è lo strumento che le cattura nel film stesso. Un’operazione complementare e opposta a quella che sperimenteranno oltreoceano fotografi come Cindy Sherman e Jeff Wall, appropriandosi di formule “cinematografiche” nei loro lavori a partire dagli anni Settanta.
Godard assiste all’alba di un nuovo predominio, e la stessa conquista del museo da parte dell’immagine proiettata coinciderà con quella nozione di “morte del cinema” espressa nel suo Histoire(s) du cinéma, e poi nell’ultimativo Le livre d’image (2018). Riflessioni sui rapporti tra cinema e storia, tra il cinema e le altre arti, in particolare la tradizione pittorica23.

Così pure la visita museale forse più famosa della settima arte ha l’ultima parola sul “post-cinema” in un film di Godard.
Preconizzando l’era del turismo di massa e la sottomissione globale al dominio delle immagini prodotte industrialmente, il regista fa compiere ai tre protagonisti di Bande à part (1964) una sorta di epica “scorreria” pirata nei corridoi del Louvre, per surclassare il record di un turista di San Francisco che aveva visitato l’intero museo in nove minuti e quarantacinque secondi. La corsa a perdifiato del trio, osservata dai capolavori con sovrana indifferenza, verrà ripresa (con innesti della versione originale) in The Dreamers (2003) di Bernardo Bertolucci.
By dying, cinema simply joins the celebratory or melancholy diagnoses of the
death of ideologies (Lyotard), industrial society (Bell), the real (Baudrillard),
authorship (Barthes), history (Kojève, Fukuyama), man (Foucault) and, last
but not least, modernism. The launch of a term combining the post-prefix
with cinema was written in the stars24.
«Morendo, il cinema unisce la propria sorte a quelle già celebrate nelle diagnosi malinconiche sulla morte delle ideologie (Lyotard), della società industriale (Bell), del reale (Baudrillard), dell’autore (Barthes), della storia (Kojève, Fukuyama), dell’uomo (Foucault) e, non ultimo, del modernismo. L’introduzione di un termine che combina il prefisso “post” con il cinema era scritta nelle stelle».
Il cinema tutto “si prende gioco” della storia. Non importa se dichiari di essere intrattenimento o documentario. Vuole tutto, chiede di “credere”, come il mito, come la religione.
Nelle Histoire(s) trovano posto le “vite”, ritratti/autoritratti di molti artisti, del passato e contemporanei (ma come già enunciato da Benedetto Croce in molte sue opere, “Tutta la storia (dell’arte) è contemporanea”): sono istantanee, frammenti che compaiono come i fasmidi di Georges Didi-Huberman25, poi rientrano nella “notte” della storia, pronti a riemergerne. Un frame mostra per pochi istanti il volto di Picasso, sopraffatto dall’orrore, poco dopo le immagini del trauma che il cinema non ha saputo raccontare: i genocidi, e su tutti l’Olocausto.
Quattro capitoli, divisi in due episodi ciascuno. Un’opera la cui composizione alchemica richiese dieci anni, dal 1988 al 1998, per non conservare traccia alcuna di “spore” diacroniche.
Capitolo 1(a): 51 min. Toutes les histoires (1988) – Tutte le storie
Capitolo 1(b): 42 min. Une Histoire seule (1989) – Una storia sola
Capitolo 2(a): 26 min. Seul le cinéma (1997) – Solo il cinema
Capitolo 2(b): 28 min. Fatale beauté (1997) – Fatale bellezza
Capitolo 3(a): 27 min. La Monnaie de l’absolu (1998) – La moneta dell’assoluto
Capitolo 3(b): 27 min. Une Vague Nouvelle (1998) – Una nuova onda
Capitolo 4(a): 27 min. Le Contrôle de l’univers (1998) – Il controllo dell’universo
Capitolo 4(b): 38 min. Les Signes parmi nous (1998) – I segni in mezzo a noi.
Un’immensa imagerie, un volume pari soltanto a quello delle onde che s’infrangono contro lo schermo, e travolgono lo spettatore che osserva sgomento.
Splendeurs et misères, commenta più volte lo stesso Godard. L’universo scintillante dei desideri, lo splendore dell’arte e della cultura occidentale, s’incrinano e cedono dinanzi alla miseria, il repertorio di immagini dell’orrore che non lasciano scampo, bruciano lo schermo alternandosi con sequenze di battaglie cinematografiche come quella della cittadina di Vladimir: il massacro raccontato in Andrej Rublëv, che divenne bersaglio della censura perché “troppo violento”.
«Non cambiare niente perché tutto sia diverso», così si apre il primo episodio. Le frasi dell’autore formano sotto i nostri occhi un libro, e molte apparizioni torneranno anche nell’ultimo Livre d’image.
Wednesday, November 24, 1976—Vancouver—New York
Got up at 7 A.M. in Vancouver and cabbed to the airport ($15 plus $5 tip,
magazines, $5). This is the end of the trip to Seattle for the opening at
the Seattle Art Museum there, then we’d gone to Los Angeles for Marisa
Berenson’s wedding to Jim Randall, then to Vancouver for my Ace
Gallery show opening there. Nobody in Vancouver buys art, though—
they’re not interested in painting. Catherine Guinness didn’t get edgy
till the last day when she started this annoying thing the
English do—asking me over and over, “What exactly is Pop Art?” It was
like the time we interviewed that blues guy Albert King for Interview,
when she kept asking, “What exactly is soul food?”
Andy Warhol, The Andy Warhol Diaries
Mercoledì 24 novembre 1976 – Vancouver – New York
Sveglia alle 7:00 del mattino a Vancouver, poi taxi per l’aeroporto (15$ più 5$ di mancia, riviste 5$). Questo è il finale del viaggio a Seattle per l’inaugurazione del Seattle Art Museum, poi a Los Angeles per il matrimonio di Marisa Berenson con Jim Randall, e infine a Vancouver per l’inaugurazione della mia mostra alla Ace Gallery. A Vancouver, però, nessuno compra arte, non sono interessati alla pittura. Catherine Guinness è diventata fastidiosa solo l’ultimo giorno, quando ha iniziato a fare quella cosa fastidiosa che fanno gli inglesi, chiedendomi continuamente “Cos’è esattamente la Pop Art?”. Era come la volta in cui abbiamo intervistato il bluesman Albert King per Interview, e lei continuava a chiedere “Cos’è esattamente il soul food?”.
Questo accadeva al di là dell’oceano, una dozzina d’anni prima delle Histoire(s).
Dai Diari di Andy Warhol è stata tratta recentemente una miniserie televisiva di notevole successo (disponibile da marzo 2022 su Netflix), per la regia e produzione di Andrew Rossi: la voce narrante è quella dell’autore, ottenuta campionando pochi minuti dell’originale poi rigenerato grazie all’intelligenza artificiale predittiva. Il risultato sotto questo punto di vista è rimarchevole, anche se (ed è quasi paradossale) la AI non è riuscita a riprodurre quella particolare timbrica “piatta e robotica” che Warhol conferiva volutamente alla sua voce. Una “sprezzatura” ben più esangue di quella raccomandata da Baldesar Castiglione nel Cortegiano (1528): ogni sua performance puntava alla mimesi della superficialità, e non soltanto a dissimulare lo sforzo del suo impegno.
La stesura delle memorie (lo stile è singolare, telegrafico, pare già concepito per la lettura o l’oversound cinematografico) iniziò nel 1976, quando Warhol chiese all’amica Pat Hackett di trascrivere quotidianamente quanto gli accadeva, dietro dettatura o condivisione telefonica: 1200 pagine pubblicate nel 1989, due anni dopo la scomparsa dell’artista. Non c’è giornata, non c’è tessera di questo mosaico che non contenga una drop list di persone e luoghi famosi: l’apoteosi della sua ossessione, sublimata fino a consacrarsi manifesto programmatico del suo fare arte. Warhol non vuole riflettere sul proprio tempo. Al contrario, vuole esserne il riflesso. Il culto della sua personalità è un’implosione: l’artista scompare nell’accettazione sociale (inseguita dall’adolescente Andrew Warhola, figlio di immigrati ucraini) della propria inconsistenza soggettiva. Ed emerge al suo posto la figura dell’artistar nel nuovo firmamento: il business dell’arte.
La presa di coscienza di Warhol, formatasi in una condizione di marginalità sociale nell’infanzia e giovinezza, traguarda verso la società dello spettacolo, facendone arte e parte. Come prendendo le mosse dalla lacaniana “destituzione soggettiva”26, ne predica l’ineludibilità. La sua parabola esistenziale si compie nell’immaginario.
Speculare e opposta era stata la riflessione di Guy Debord, che già nel 1967 – in 221 tesi suddivise in nove parti – aveva previsto e descritto il predominio della mistificazione, della «merce come spettacolo» e della «negazione e consumo nella cultura»27. Nel 1973 lo stesso Debord tradurrà in linguaggio cinematografico la sua opera, conservandone il titolo: La Société du Spectacle (La società dello spettacolo), in bianco e nero, è il primo lungometraggio di Debord. La sua stessa voce fuori campo legge le tesi della sua opera, insieme a brani di Marx, Machiavelli e altri autori. Utilizzando la tecnica del détournement situazionista, accorpa parti di altri lungometraggi, fotografie, filmati industriali, pubblicità, e filmati di eventi storici. Una critica marxista radicale della società di massa, con effetti dirompenti e a lungo termine sulla stessa produzione dello stesso Godard.
Warhol, dal canto suo, pur intuendo le nuove possibilità offerte dal mezzo filmico, ci lascia una produzione underground significativa e prolifica, ma frammentaria. Le sue apparizioni si limitano quasi a dei camei, in biopic che riguardano personaggi da lui influenzati o addirittura lanciati, come l’amico/rivale Basquiat. Curiosamente, nessuna pellicola è stata finora consacrata al suo personaggio, se si esclude la miniserie prodotta da Netflix. Andy Warhol’s Stories (1966), unico film che l’artista girò su sé stesso, non venne mai distribuito, dato che i testimoni (tra questi Edie Sedgwick e il critico René Ricard che scoprì Basquiat), una volta messi di fronte alla macchina da presa, scaricarono il loro rancore con critiche al vetriolo rivolte all’ex “nume tutelare” che li aveva “adottati” per poi ignorarli. Questo era, d’altra parte, il comportamento ambivalente di Warhol: rifletteva quello del sistema mediale. Una ricerca febbrile e continua di nuovi personaggi, meteore destinate alla distruzione dopo una breve parabola.
Una “caccia al talento” (non necessariamente contemporaneo) che oramai da molti anni caratterizza il redditizio filone delle biografie di artisti, del tutto remunerativo se si considera anche solo il positivo “ritorno” d’immagine per gli sponsor di questo genere cinematografico.
A questa regola non si è sottratto neppure il Biografilm Festival di Bologna (del resto dedicato alla “celebrazione di vite eccellenti”), fin dalla sua prima edizione. L’attenzione all’arte ha preteso uno spazio via via più significativo nell’ambito della programmazione, e già nella stagione 2008 il cambiamento appare evidente: una intera sezione dedicata a Andy Warhol, Pop lives! Warhol, le sue superstar e la Factory, con nove titoli nel palinsesto, tra corti e lungometraggi.
Andy Warhol, di Marie Menken (USA/1965/22’)
Pie in The Sky: The Brigid Berlin Story, di Vincent Fremont, Shelly Dunn Fremont (USA/2000/75’)
Award Presentation to Andy Warhol, di Jonas Mekas (USA/1964/12’)
Superstar in a Housedress: The Life and Legend of Jackie Curtis, di Craig Highberger (USA/2003/95’)
Andy Warhol: A Documentary Film, di Ric Burns (USA/2006 /240’)
Where Did our Love Go?, di Warren Sonbert (USA/1966/15’)
Ciao! Manhattan, di John Palmer, Davis Weisman (USA/1972/87’)
A Walk into the Sea: Danny Williams and the Warhol Factory, di Esther B. Robinson (USA/2007/75’)
Factory, October 14-25, 1965, di Danny Williams (USA/1965/22’)
Se è vero che il cinema mainstream non ha dedicato finora nessuna produzione importante a Warhol, quello indipendente non è mai stato indifferente all’argomento; e si lascia ritrovare da un organizzatore esperto.
Al Biografilm va riconosciuto il merito di provare a rintracciare autori attenti all’operato degli artisti, più che alle loro biografie. Non sempre riesce nell’intento, soprattutto se l’artista in questione è considerato un émulo, anzi “il nuovo Andy Warhol”.
Ossessione Vezzoli, di Alessandra Galletta (nella sezione Biografilm Arte del 2016) riprende due anni di vita di Francesco Vezzoli (2013-2015), artista di fama oramai transcontinentale, e, parte bene mostrandolo al lavoro mentre prepara le proprie mostre in alcuni dei musei più famosi del globo e nel contesto delle maggiori istituzioni artistiche: il MAXXI di Roma, il MoCA di Los Angeles, la Biennale di Architettura a Venezia, Pitti Immagine a Firenze, il Doha Qatar Museum of Modern Art, il MoMA PS1 di New York e Aurora Museum di Shanghai. Ma cade nella tentazione dei luccichii e delle coccarde: ed ecco a pioggia i commenti “esclusivi” di autorevoli protagonisti della scena artistica e culturale. In primis il compianto Antonio Paolucci, da poco scomparso, che definisce Vezzoli come “un interprete capace di cogliere la persistenza dell’antico”. E, a seguire, il filosofo francese Bernard Henry Lévy, il direttore di W Magazine Stefano Tonchi, il direttore del MoCA di Los Angeles Philippe Vergne, il direttore del MoMA PS1 e capo curatore generale del MoMA di New York Klaus Biesenbach; e Cindy Sherman, esibita come un diamante, che Vezzoli ha convinto ad interpretare la parte di Maria Callas in un video da lui prodotto, vincendo “la sua maniacale ossessione per il controllo della propria immagine” (parole pronunciate da Sherman durante l’intervista).
Su questa stessa linea “mitografica” si pongono altri due biofilm del festival: The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil di Marco Del Fiol (Brasile, 2016, presente nella medesima sezione inaugurata l’anno precedente, “BIOGRAFILM ARTE”) e Guest of Cindy Sherman di Tom Donahue, Paul H-O (USA, 2008), quest’ultimo nella selezione ufficiale dell’edizione 2010.
L’”ospite” di Cindy Sherman è l’ideatore e conduttore Paul H-O, prima intervistatore e poi per diversi anni compagno dell’artista. Il “documentario” non ha alcuna pretesa di oggettività, anzi è una sorta di diario passionale e sentimentale. Paul Hasegawa-Overacker era divenuto piuttosto famoso negli anni ’90 per le sue incursioni nella scena artistica newyorkese. Il suo programma televisivo, GalleryBeat, era seguìto dal grande pubblico con lo stesso divertimento che il suo humour pungente provocava negli artisti (spesso anche sgomenti) da lui intervistati “a sorpresa”. Poi l’incontro galeotto con Sherman alla Metro Pictures nel 1998: il Museum of Modern Art aveva già acquisito l’intera sua serie Untitled Film Stills, progetto iniziato nel 1977 in cui Sherman si riprende in bianco e nero come fosse sul set di film mai realizzati.
Lei decide di concedergli una serie di interviste esclusive, e videoregistrazioni nel suo studio che ancora oggi costituiscono un documento importante sul metodo e sul processo creativo della celebre visual artist. La stretta collaborazione si trasforma in relazione sentimentale. Paul segue Cindy in tutti gli eventi che la coinvolgono, comprese le cene (post-inaugurazione) animate da decine di celebrità che sono parte del suo mondo. A lungo andare Paul accusa un crescente disagio, la sensazione di essere non solo un “principe consorte” (e non più il protagonista), ma un ospite a séguito della star. Alla soglia dei quindici anni (tutti rigorosamente documentati, e in questo consiste il pregio del lungometraggio), il rapporto si incrina e poi termina. In realtà Paul H-O prosegue la sua attività di “disturbatore speciale” durante tutto il quindicennio, e la vicinanza di Cindy gli permette di avviare dialoghi interessanti e godibili con personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto dell’arte, rendendoli familiari a una platea molto vasta di spettatori, non più soltanto agli “addetti ai lavori” o a un pubblico di connoisseurs. Ma anche in questo caso le celebrities e il gossip (l’ansia maschile del protagonista) finiscono per avere un peso ingombrante, troppo per un film che avrebbe potuto prestare maggiore attenzione al “fare arte” di una personalità unica come quella di Sherman. Il film quindi non solo pecca di eccessivo biografismo, con punte patetiche (alla cena che inaugura una mostra di Robert Mapplethorpe curato da Sherman, si siede davanti a un cartello che recita “ospite di Cindy Sherman”), a tutto svantaggio dell’arte. Ma Hasegawa-Overacker e il co-regista Tom Donahue appaiono seriamente in difficoltà per non aver potuto dimostrare la loro tesi sulla “bolla del mercato d’arte” dinanzi a un’artista della statura di Sherman.
Allo stesso filone appartiene il film The Space in Between: Marina Abramovic and Brazil, pure se con variazioni di tipo “antropologico” sul tema. Abramovich affronta un viaggio di formazione e guarigione, placando la brama del suo pubblico ormai sempre più avido di performances spettacolari o sconcertanti: mette a nudo il suo passato difficile in un “diario intimo” punteggiato di incontri con medium, sciamani e pure erboristi, toccando località come Abadiania, Chapada, Curitiba. Riflette sulle affinità tra performance artistiche e rituali, partecipando a cerimonie di purificazione e trip psichedelici. Il regista brasiliano Marco Del Fiol la segue puntualmente, senza interrompere questa sua autocelebrazione e promozione.
Operando queste selezioni, il Biografilm Festival pare ribadire che per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea non si possa evitare la “leva” della curiosità per “il fenomeno” e la sua vita fuori dell’ordinario. E forse è così, nulla di scandaloso in fondo.
Vale tuttavia la pena chiedersi se davvero il pubblico (o meglio “i pubblici”, anche quelli apparentemente più disinteressati e lontani) debbano essere in qualche modo sedotti, indotti al consumo artistico, quando in realtà la “domanda” per gli stessi artisti di questo secolo tocca oramai vette impensabili solo dieci anni fa. Le esposizioni temporanee o le installazioni (anche singole) di grandi nomi dell’arte nostra coeva non conoscono crisi: lo dimostra il recente caso di Anish Kapoor a Firenze, che a Palazzo Strozzi ha generato code di visitatori degne di rispetto (ammesso che il fenomeno possa considerarsi una metrica attendibile per la “riuscita” di un evento). Ormai l’arte contemporanea non fa più tanta paura: anzi, il carattere “esclusivo” dell’evento costruito (innanzitutto) sulla figura di un artista vivente e con quotazioni altissime possono costituire un richiamo altrettanto seduttivo di una mostra su Caravaggio o Canova.
Esistono tuttavia altre narrative, che non puntano su aspetti diaristici o spudoratamente (auto)celebrativi, e che ci avvicinano di nuovo allo sguardo dell’artista, alla sua concentrazione e gestualità, alla sua filosofia e ricerca. Come nel caso di Andrej Rublëv.
II.3. In girum imus nocte et consumimur igni.
Ma niente traduceva questo presente senza via d’uscita e senza riposo
come l’antica frase che ritorna integralmente su sé stessa,
essendo costruita lettera per lettera come un labirinto da cui non si può uscire,
di modo che essa accorda così perfettamente la forma e il contenuto della perdizione:
In girum imus nocte et consumimur igni.
Giriamo in tondo nella notte e siamo consumati dal fuoco.
“Una generazione passa, e un’altra le succede, ma la terra resta sempre.
Il sole sorge e tramonta, e ritorna al luogo di partenza…
Tutti i fiumi si gettano nel mare, e il mare non trabocca affatto.
I fiumi ritornano allo stesso luogo da dove erano partiti, per scorrere ancora…
Ogni cosa ha il suo tempo, e tutto passa sotto il sole, alla scadenza del termine prescritto…
C’è un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
un tempo per abbattere e un tempo per costruire…
C’è un tempo per disgiungere e un tempo per ricongiungere,
un tempo per tacere e un tempo per parlare…
È meglio vedere ciò che si desidera, che sperare ciò che si ignora:
ma anche questo è vanità e presunzione di spirito…
Che bisogno c’è che un uomo vada alla ricerca di ciò
Che è al di sopra di lui, quando ignora ciò che gli conviene
nella vita durante i giorni in cui è straniero sulla terra,
e durante il tempo che passa come un’ombra?”
Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni
Questo passo di Debord è forse il più “atrabiliare” nella letteratura degli ultimi due secoli. E nel cinema, naturalmente, considerato che si tratta della trascrizione dell’omonima sua opera cinematografica del 1978.
La melancholia trabocca, chiede un antidoto e lo ricusa. Nessuna meraviglia che l’insania descritta da Debord richiami la vanitas trattata dall’anonimo filosofo che si cela nel Qohelet. L’Ecclesiaste (questo il titolo nella versione greca dei Settanta) è forse il testo biblico più citato dal cinema, insieme col Cantico dei Cantici. Miseria e splendore. Alcuni passi del Qohelet (così come in altri testi sapienziali del canone biblico) sono così lucidi e spietati nel descrivere la duplice natura della creazione divina, da mettere in difficoltà qualsiasi commentatore.
L’alienazione denunciata da Debord (così come da Theodor W. Adorno) è figlia dell’antagonismo fra l’uomo e le forze che egli stesso ha creato, e gli si oppongono infine come esseri indipendenti. Soprattutto è il trionfo dell’economia trasformatasi da mezzo in fine, il conflitto tra la crescita delle forze produttive divenuta fine a sé stessa e i bisogni umani. Quel che Debord chiama “spettacolo”, non è altro se non il meccanismo inarrestabile, non più controllabile dall’uomo:
14. La società basata sull’industria moderna non è fortuitamente o superficialmente spettacolare, essa è fondamentalmente spettacolista. Nello spettacolo, immagine dell’economia dominante, il fine non è niente, lo sviluppo è tutto. Lo spettacolo non vuole realizzarsi che solo in sé stesso.
16. Lo spettacolo sottomette gli uomini viventi nella misura in cui l’economia li ha totalmente sottomessi. Esso non è altro che l’economia sviluppantesi per sé stessa. È il riflesso fedele della produzione delle cose e l’oggettivazione infedele dei produttori28.
Ne La società dello spettacolo (1967) lo stile, già “sapienziale”, con pochi tratti descrive una suprema forza di alienazione, dove la vita appare sempre più priva di qualità. Mentre le immagini di questa vita si staccano, rifiutandosi di morire e formando un insieme che comincia a proliferare in una vita indipendente: lo spettacolo in senso stretto. L’individuo non ha più alcun contatto con ciò che lo riguarda, è costretto ad accettare la mediazione di immagini scelte da altri e falsificate. I rapporti umani trasformati in rapporti tra merci, descritti da Marx, si sono evoluti e sono divenuti rapporti tra immagini. La metamorfosi investe l’uomo divenuto infine spettatore passivo, incapace di intervenire su forze da lui stesso generate.
Ma in Debord lo sguardo del filosofo cela lo sgomento che fu del monaco-pittore Andrej Rublëv posto di fronte all’ineluttabilità del reale, e trapela nell’immedesimazione con la voce umana dell’Ecclesiaste.
Identificarsi con questa modalità del vedere non significa necessariamente soccombere dinanzi al reale.
Così come Tarkovskij e molti altri cineasti approdati alla fotografia dopo la regia, e spesso sospesi tra queste due attività, anche Wim Wenders ha “rimesso in scena” sé stesso come fotografo dedicando uno dei suoi lungometraggi più significativi a Sebastião Salgado, oggi considerato il più grande documentarista vivente.
Wenders s’interroga di continuo sulla veridicità delle immagini. Quello che Guy Debord e in seguito Slavoj Žižek descrivono come «il deserto del reale»29 è per lui così vuoto da «traboccare di essenziale»30. E l’atto fotografico viene celebrato nei suoi film con inquadrature fisse e immagini polaroid (Alice nelle città, 1974). Ne L’atto di vedere (la prima edizione italiana uscì nel 1992 per i tipi di Ubulibri) Wenders tratta il tema della manipolazione digitale delle immagini molto tempo prima dell’avvento (nel linguaggio comune) di termini come fake news e “post-verità”.
Il regista tedesco inizia a confrontarsi con il genere documentaristico sin dal 1980 (Lampi sull’acqua – Nick’s Movie, un omaggio commosso all’amico e collega Nicholas Ray negli ultimi giorni di vita): le biografie di artisti lo appassionano, e nel 2011 decide di raccontare vita e opere della coreografa Pina Bausch (Pina, 2011, lungometraggio in 3D).
Nel 2014 dedica al fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado31 Salt of the Earth (Il sale della terra), un ritratto (girato in tandem con il figlio di Salgado, Juliano Ribeiro) pieno di ammirazione per il grande documentarista-antropologo. Wenders filma la fotografia di Salgado, che presta la sua bella faccia e la sua voce a commento delle immagini. Lo segue con devozione nei suoi reportage, in ogni angolo del globo. In cima alle vette, in mezzo al deserto, sull’orlo di un abisso. La sua solitudine è dovuta allo status di “vedetta”, una sentinella cui “importa davvero degli esseri umani” (il commento è di Wenders, nel prologo del film). La “vita in viaggio” di Salgado è così ampia e tocca mete così lontane tra loro, che è un’impresa raccontarla in poche righe, e infine al cinema. Il suo cursus honorum comprende onorificenze di stato e accademiche, riconoscimenti umanitari e premi per reportage e mostre, e finalmente la fama presso il pubblico cinematografico grazie a Wim Wenders. Ma al regista (come al protagonista) non importa il racconto epico dei momenti di gloria, della pregressa carriera universitaria di economista e statistico, abbandonata senza ripensamenti in seguito a una missione in Africa, nel momento in cui Salgado decide di diventare fotografo. Wenders lo filma mentre è al lavoro, per documentare le condizioni di carestia e povertà estrema nei Paesi in via di sviluppo, e gli effetti devastanti prodotti dall’economia di mercato.
Fin dal suo primo apparire, il binomio Wenders-Salgado domina i festival del cinema (Cannes, San Sebastiàn), con una pioggia di premi e menzioni speciali. La rassegna bolognese non poteva lasciarselo sfuggire. E infatti eccolo, subito inserito nel programma della stagione 2014, sezione What’s Culture?.
In ottima compagnia, certamente: con National Gallery di Frederick Wiseman, e The Fallen Body di Davide Pepe. E in una sezione forse perfino migliore – per offerta e selezione di titoli – di quella che a partire dal 2015 verrà chiamata Biografilm Art.
Ma nessuna stagione del festival pregressa e futura potrà annoverare una biografia d’artista che regga il paragone con l’alchimia Wenders-Salgado.
Il primo sempre alla ricerca di testimonianze di vita per pratiche cinematografiche che ogni giorno di più si rivelano mappe antropologiche. Salgado, lontano dai riflettori, è ritornato al suo lavoro, la sua diuturna ricerca su tracce superstiti di umanità che lo porta in territori dove è obbligatorio arrivare con la giusta attrezzatura e un quantitativo pesato di rullini e pellicola, per viaggiare leggero, a piedi.
Alcuni mi considerano un fotogiornalista. Non è vero.
Altri, invece, un militante. Nemmeno questo è vero.
La sola cosa vera è che la fotografia è la mia vita.
Tutte le mie foto corrispondono a momenti che ho vissuto intensamente.
Queste immagini esistono perché la vita, la mia vita, mi ha condotto a farle.
Perché c’è una rabbia in me che mi ha portato in un determinato posto.
A volte a guidarmi è stata un’ideologia, a volte semplicemente la curiosità oppure
la voglia di trovarmi là.
La mia fotografia non è affatto obiettiva, è profondamente soggettiva.
Come tutti i fotografi, scatto immagini in funzione di me stesso, di quello che mi passa per la testa,
di ciò che sto vivendo e pensando. E me ne assumo la responsabilità.
A me interessa produrre racconti fotografici suddivisi in diversi reportage scaglionati su più anni;
mi interessa lavorare a fondo intorno a un problema per cinque o sei anni,
non ho voglia di svolazzare da un argomento all’altro, da un posto all’altro.
Sono capace di raccontare storie soltanto ritornando a più riprese nello stesso posto.
Con questa dialettica, si evolve. Procedo così da oltre quarant’anni
e il mio lavoro ha beneficiato di una certa coerenza.
Per realizzare buone foto, bisogna appassionarsi.
Non è possibile trascorrere cinque anni di vita in Africa se non si ama davvero l’Africa.
Inutile imporsi di guardare gente che lavora se la cosa non interessa.
Per restare, ad esempio, parecchi mesi in una miniera, bisogna essere molto motivati.
Bisogna amare tutto questo.
Tutto si gioca, poi, in laboratorio. Qui devo cercare di tradurre le mie emozioni
in un linguaggio che non è reale, poiché il bianco e nero è un’astrazione che si realizza
attraverso la gamma dei grigi della stampa fotografica.
Prima di passare alla foto digitale, quando partivo per lunghi reportage,
dovevo aspettare a volte diversi mesi, per far sviluppare le pellicole che riportavo tutte
riavvolte in bobina dentro scatole di metallo.
Soltanto una volta arrivato a Parigi, potevo verificare se sulle pellicole si cogliesse davvero
la magia che avevo sentito sul posto; se ero riuscito, oppure no, a catturare quelle immagini
che avevo tanto atteso vivendo per giorni interi con una comunità o un gruppo,
partecipando alle sue attività, a volte spiando, accucciato da qualche parte anche per ore.
Integrato totalmente con quanto lo circonda,
il fotografo sa che assisterà a qualcosa di inaspettato.
Quando scatto, sono completamente preso dal mio gesto.
È un momento magico e di grande piacere personale.
Oggi che sono invecchiato, ho bisogno di un assistente, di un compagno,
mentre per molti anni ho fatto tutto da solo. Come in America Latina,
dove ho vissuto per diversi mesi, fra le montagne, insieme agli indios.
Sebastião Salgado, Dalla mia Terra alla Terra
Ancora qualche considerazione su Salgado e la sua autobiografia mediata dall’occhio cinematografico di Wenders. Nel film il regista racconta di come venne a contatto con l’autore: «Ho visto per la prima volta questa foto32 in una galleria d’arte, vent’anni fa. Non avevo idea dell’autore. C’era un timbro sul retro, e una firma: Sebastião Salgado. Comprai la foto. Il gallerista tirò fuori da un cassetto altre foto dello stesso autore. Quello che vidi mi colpì profondamente. Specialmente questa immagine: il ritratto di una donna Tuareg cieca. […] Una cosa l’avevo già capita, di questo Salgado: gli importava davvero degli esseri umani. Questo era fondamentale per me. Dopotutto, gli esseri umani sono il sale della terra».

La donna è ritratta pensando ai maestri della fotografia europea (Capa, Cartier-Bresson). Il tributo al canone estetico è dovuto forse alla compostezza e dignità che la contraddistinguono, nonostante la malattia, la povertà e la fame. Ma le restanti foto che compongono il reportage L’Homme en Détresse, realizzato dal 1984 al 1986 a seguito della siccità che fin dal 1972 aveva colpito la regione del Sahel (e che ancora oggi non conosce tregua) sono terribili.
Anch’io ho avuto una sorta di agnizione: una di queste immagini ritrae un gruppo familiare, in primo piano una donna che tiene per mano due bambini piccolissimi, ridotti a scheletri; avanzano faticosamente nella sabbia. Attorno, il nulla. Avevo già visto questa foto molti anni fa, in un articolo intitolato La pietà à morta, non ricordo in quale rivista o quotidiano. Il nome del fotografo non era riportato; mi chiesi chi fosse, ma non riuscii a saperlo. Internet, così come lo intende oggi la comunità degli utenti, nascerà alcuni anni più tardi, nel 1991. E ai suoi esordi non sarà ancora “per tutti” (o quasi) come per quest’ultima generazione. Perciò il dubbio restò, nella rétina come nella memoria (per me come per tanti altri), fino all’agnizione.
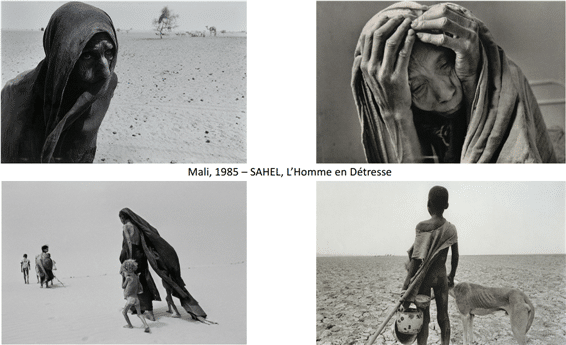
Queste immagini raccontano un castigo che di “divino” non ha nulla, di umano e folle, molto: eserciti di profughi provenienti dal Mali, dall’Etiopia, dal Ciad, dal Sudan, cercano di sfuggire la sete, la fame, la guerra. Si dirigono verso i campi di accoglienza come quello di Korem, in Etiopia. Le foto di Salgado conoscono una grande diffusione internazionale, dopo essere comparse sul quotidiano francese Libération. Nel 1985 verrà conferito al fotografo il premio World Press Photo, e nel 1986 dal suo lavoro nascerà una pubblicazione a cura del Centre National de la Photographie, Sahel, l’homme en détresse, poi ripubblicato per Medici Senza Frontiere con il titolo Sahel, el fine del camino. Salgado continuerà a non essere noto al di fuori dei media con cui ha collaborato, ma avrà la soddisfazione di aver contribuito molto alla causa umanitaria.
Solo nel 2014, grazie al film di Wenders, il mondo inizia davvero a fare la conoscenza di Salgado, a prendere confidenza con la monumentalità della sua opera. Eppure, nonostante la partecipazione del lungometraggio ai festival più importanti, le nomination e i premi, si verifica un fatto inquietante: una buona parte della critica cinematografica lo snobba, o meglio non ne parla, non lo recensisce, semplicemente lo ignora, tutt’al più dedicandogli poche righe. Viene da chiedersi per quale motivo. Non si tratta neppure di un biopic “di nicchia”, ma della narrazione di un grande cineasta, che sigla un tributo di qualità indiscutibile a un grande talento della fotografia del XX e XXI secolo.
E lo sconcerto aumenta, se si considera il successo di critica e pubblico che già Wenders aveva ottenuto con i documentari precedenti: Pina (2011), e Buena Vista Social Club (1999), che aveva contribuito alla notorietà mondiale di un club di straordinari musicisti cubani ultranovantenni (nel 1997 uscì il disco della colonna sonora, che riscosse un successo planetario).
Se oggi Il sale della terra è apprezzato, ricordato, riconosciuto dal grande pubblico (cinefili, appassionati di fotografia, e non solo), lo si deve soprattutto ai festival, agli spettatori che dopo averlo visto hanno creato il “fenomeno” sui social network, diffondendo commenti e immagini.
Senza voler trarre conclusioni forzate, forse è meglio chiudere con una considerazione dello stesso Salgado, che illustra meglio di ogni altra il suo modo di comunicare, privo di qualsivoglia intenzione di piacere ad ogni costo.
Non sono originario del Nord del mondo e non ho
Il senso di colpa di certi miei colleghi.
Non fotografo la povertà materiale perché mi sento colpevole:
fa parte del mondo da cui provengo33.
III. Melanconici e integrati
Λ. ΟΣΑ ΠΕΡΙ ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ.
Διὰ τί πάντες ὅσοι περιττοὶ γεγόνασιν ἄνδρες ἢ κατὰ φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν οὕτως ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστήμασιν, οἷον λέγεται τῶν τε ἡρωϊκῶν τὰ περὶ τὸν Ἡρακλέα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως, διὸ καὶ τὰ ἀρρωστήματα τῶν ἐπιληπτικῶν ἀπ’ ἐκείνου προσηγόρευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νόσον. καὶ ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἔκστασις καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ἐν Οἴτῃ τῶν ἑλκῶν ἔκφυσις γενομένη τοῦτο δηλοῖ· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ Λυσάνδρῳ τῷ Λάκωνι πρὸ τῆς τελευτῆς γενέσθαι τὰ ἕλκη ταῦτα. ἔτι δὲ τὰ περὶ Αἴαντα καὶ Βελλεροφόντην, ὧν ὁ μὲν ἐκστατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ τὰς ἐρημίας ἐδίωκεν, διὸ οὕτως ἐποίησεν Ὅμηρος “αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, ἤτοι ὁ καππεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλᾶτο, ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.”
Ἀριστοτέλης, Προβλήματα
XXX. Problemi legati al Pensiero, all’Intelligenza e alla Saggezza
Come mai tutti coloro che hanno raggiunto l’eccellenza nella filosofia o nella politica o nella poesia o nelle arti sono chiaramente melanconici, e qualcuno di essi a un grado tale da soffrire di disturbi legati alla bile nera?
Un esempio nella mitologia degli eroi ne è Eracle. Egli infatti sembra avesse questa costituzione, e quindi da lui le turbe epilettiche sono state chiamate dagli antichi «male sacro». Il suo accesso furioso nell’incidente con i figli suggerisce questo, come pure l’eruzione di ulcere che si verificò prima della sua sparizione sul monte Eta; questo infatti è in molte persone un sintomo della bile nera.
Anche Lisandro Lacedemone soffrì di queste ulcere avanti di morire.
Ci sono anche le storie di Aiace e Bellerofonte: l’uno uscì completamente di senno, l’altro cercò luoghi deserti per abitare, per la qual cosa Omero dice: «Ma quando anch’egli fu in odio a tutti i numi | allora errava, solo, per la pianura Alea, consumandosi il cuore, fuggendo orma d’uomini».
Aristotele, Problemi34
III.1. Détournement? No grazie
«È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia».
Nel 1989 debutta su Rai Tre un nuovo programma (il 17 aprile ha compiuto trentacinque anni): si chiamava (e si chiama) Blob. Di tutto, di più, e la frase in esergo è la sua sigla. Nasce da un’idea di Enrico Ghezzi, in collaborazione con l’autore Marco Giusti e col dirigente Rai Angelo Guglielmi. Ghezzi all’epoca già aveva rinnovato il linguaggio della critica cinematografica in TV dando vita a Fuori orario. Cose (mai) viste: frammenti di film (o versioni integrali di film solitamente esclusi da palinsesti “conservatori”), cortometraggi, documentari di rilevanza storica, filmati di repertorio. L’intenzione è quella di riprodurre lo stesso modello di memoria storica o meglio, in questo caso, di découpage: una breve striscia quotidiana che crei un racconto paradossale (spesso esilarante, comunque “mostruoso”) servendosi di un montaggio anarchico di pezzi sparsi di programmi, telegiornali, film, cartoons, pubblicità.
Il titolo cita letteralmente un film horror del 1958, Blob. Fluido mortale35. In apertura, la scena di panico del pubblico che fugge dal teatro, terrorizzato dalla informe creatura aliena che sta invadendo ogni anfratto come una colata lavica. L’enfasi della colonna sonora e della frase pronunciata da un poliziotto inorridito chiudono la sigla e avviano la strip vera e propria: la “mostruosità” del programma si riversa sul piccolo schermo con un effetto boomerang, riproponendo tutto il “peggio” della TV, facendola a brandelli. Per i telespettatori è subito un cult, e fin dall’inizio fioccano querele da parte di politici, giornalisti, personaggi “famosi” sbeffeggiati: non dal programma, ma dalla loro stessa inconsistenza.
Blob non è soltanto un esempio felicissimo di humour. Enrico Ghezzi riesce a portare in televisione, medium divulgativo (spesso in senso deteriore) per antonomasia, il modello di lettura della realtà proposto da Guy Debord, suo nume tutelare. Servendosi abilmente e liberamente della tecnica di détournement, alla lettera “deviazione”, “dirottamento”.
Questa la definizione nell’Internationale Situationniste (rivista diretta da Guy Debord) giugno 1958:
Détournement: integrazione della produzione artistica attuale e passata in una costruzione superiore di ambiente, ove non vi sarà più pittura o musica situazionista, ma un uso situazionista delle stesse. In senso più banale il détournement all’interno delle vecchie sfere culturali è un metodo di propaganda, che testimonia dell’usura e della perdita di importanza di queste sfere.
Come sottolineato dal filosofo Mario Perniola36, si tratta certamente di una tecnica artistica derivante dal modernismo, ma si differenzia dal collage o dal ready-made (che capovolge significanti e significati per ottenere un preciso risultato estetico), privandosi dell’intenzionalità. Non è soltanto “il contrario della citazione come verità formulata nel passato che pretende di spiegare il presente37”: se l’arte ha perduto ogni valore, l’opera d’arte ne seguirà la deriva, esprimendo un contro-valore.
La tecnica in realtà viene utilizzata fin dagli esordi della cinematografia: Susan Sontag38 ricorda come lo stesso Georges Méliès, riuscisse ad ottenere con il montaggio una sorta di gioco di prestigio, mettendo così in evidenza una delle peculiarità del cinema: può far accadere tutto, «non esiste nulla che non vi possa essere rappresentato in modo persuasivo».
Ma se per Méliès queste associazioni e disgiunzioni della riproducibilità costituiscono l’essenza della settima arte, la sua magia, Debord ne raffredda i vapori in un serpentino, ottenendo una riduzione, una nigredo che li avvicina e li mescola nello “spettacolare integrato”, espressione delle dittature contro-rivoluzionarie e infine della società delle merci.
Sta di fatto che si tratta di un potente mezzo critico, una lente che scandaglia il reale, e come tale verrà usato non soltanto da Debord, ma da Godard e dallo stesso Warhol.
Ci si chiede, allora, come mai la cinematografia se ne serva attualmente così poco. I documentari, anche quelli che portano sul grande e piccolo schermo (oramai quest’ultimo costituisce un modello per il cinema) biografie di artisti, non hanno ambizioni se non di distribuzione capillare.
Eppure la “decostruzione”, la “disarticolazione” di un’opera d’arte costituiscono forse la più alta forma di tributo, come dimostrano le innumerevoli versioni rivisitate, reinventate, “dirottate” delle opere di Velázquez.
Ci si chiede: potrebbe il cinema offrire modelli di biografie di artisti o documentari sull’arte che non siano meramente divulgativi o celebrativi (pure nell’indiscutibile qualità di alcuni casi)? Potrebbe non appiattirsi sul modello televisivo? Oppure quest’ultimo evolversi come nel caso delle due trasmissioni che ne hanno radicalmente cambiato la modalità comunicativa a partire dagli anni Ottanta?

III.2. Le pietre di Atlantide
«Sono un uomo di Bisanzio giunto a Venezia attraverso la Grecia»
Carlo Scarpa ne Il padiglione sull’Acqua di Stefano Croci e Silvia Siberini
Il Memoriale Brion, meglio noto come “Tomba Brion” (1969) di San Vito di Altivole, più che un monumento sepolcrale è una città sull’acqua. Una polis, con muri a gradini sommersi: sorge dai flutti come Venezia, e come la vita stessa, una tappa biologica e culturale dell’umanità. Città visibile e invisibile, velata e specchiata. La pianta è quella di una civitas ideale, più universale della stessa Venezia. E qui verrà sepolto lo stesso Carlo Scarpa, insieme alla moglie. Ascoltando le testimonianze del figlio, dei suoi collaboratori, e del filosofo giapponese Ryosuke Ohashi, seguiamo attraverso i paesaggi i percorsi creati dall’architetto, percependo concretamente la realtà di un appuntamento a lungo desiderato. È un monumento alle sue memorie architettoniche: l’antichità nelle camere sepolcrali, reminiscenze longobarde nei muri, fino alla pagoda orientale. Una dimora in cui non può mancare un luogo accogliente per i visitatori: il Padiglione della Meditazione, sospeso sull’acqua, eretto a perenne testimonianza dell’amore per la cultura giapponese.
Un amore nutrito e respirato fin da bambino nell’orientale Venezia, che permea tutta l’opera di Carlo Scarpa; pure formatasi sulla secessione viennese, su Frank Lloyd Wright, e in ambito figurativo da Piet Mondrian e Mark Rothko. La componente orientale meditativa della sua architettura poggia sulle regole dell’antica “tettonica” greca, generando una commistione fortemente caratterizzante. Su tutto prevale l’amore per le “scalette”, che congiungono la superficie della città lagunare con le sue fondamenta sottomarine: un elemento architettonico che riemerge ovunque, quasi una firma di Scarpa. Così come il murmur delle acque, che non devono essere “arginate” ma “accolte”: come nella magnifica soluzione “a livelli” adottata per la finestra e il ponte divenuti ingresso della Fondazione Querini Stampalia.
Il padiglione sull’acqua, oltre che il titolo del film di Stefano Croci e Silvia Siberini (presentato nell’edizione Biografilm 2023) è il compendio di tutto ciò che Scarpa ha visto, la celebrazione del suo sguardo: Venezia, città natale, e il Giappone, terra amata con uguale forza e passione, dove è morto. Ora riposa nello stesso giardino progettato per la famiglia Brion, in un angolo delimitato da una pietra che sembra fluttuare senza peso. Suo figlio Tobia ha scelto un labirinto come cornice per il nome e la data.
Nel muro dei “propilei” della tomba Brion, uno degli elementi architettonici ricorrenti in tutta la sua opera: le due aperture circolari che s’intrecciano, congiungendosi come due anime, due mondi che si toccano.
Un altro film aveva reso omaggio alle “fondamenta degli incurabili”, l’anno precedente (2022), e il Biografilm Festival aveva riservato un’intera sezione all’autore intitolandola “Maratona Ancarani”.
Yuri Ancarani, ravennate del 1972 (un altro “bizantino” come Scarpa) è noto per le sue opere di videoarte realizzate con occhio documentaristico.
Il lungometraggio Atlantide, girato a Venezia nell’arco di tre anni e uscito nel 2021 (candidato alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti” e successivamente portato con successo al MoMA di New York), racconta il girovagare senza meta di ragazzi immersi nei labirinti lagunari, schiavi dello status symbol del luogo: il “barchino”: tra questi il giovanissimo Daniele, che vive di espedienti e senza prospettive.
Il regista ci coinvolge in un viaggio più che onirico in cui una melanconia metamorfica si muta in psichedelia dai riflessi verde acido, su acque che divengono cielo capovolto. La ripresa viene ruotata di novanta gradi, e allo spettatore è dato pensare che la navigazione ora si svolga in questa intersezione, tra due mondi che si specchiano e si toccano.
E i ragazzi, come falene, inseguono a tutta velocità i bagliori notturni.
III.3. Artivismo
All’unico pennone sventolava la bandiera della Cina. Ero in mezzo alle macerie,
sbalordito e tremante, sopraffatto dall’odore della morte.
Sotto i miei piedi c’erano indumenti sparsi, libri inzuppati di pioggia, righelli, specchietti, zaini.
Soldati in tute bianche di protezione chimica, carichi di sacchi per
cadaveri di plastica nera, passavano davanti a una scavatrice meccanica ormai muta.
Due settimane prima, quando la scuola era crollata, erano morti settecentoquaranta bambini.
Il 12 maggio del 2008 un terremoto di magnitudo 8.0 aveva colpito la
provincia sudoccidentale del Sichuan, con epicentro nella contea di Wenchuan.
Così potente che le scosse furono sentite a Pechino, a più di millecinquecento chilometri.
Quando la notizia della tragedia si diffuse, l’intera nazione piombò nel lutto.
Non ero dell’umore giusto per continuare a scrivere sul mio blog.
Il 29 maggio, con il mio assistente Zhao Zhao arrivai nella capitale del Sichuan,
Chengdu, e andammo immediatamente a Dujiangyan, una città vicino
all’epicentro che aveva subito gravi danni. Vedemmo ciò che restava della
scuola media Juyuan, ridotta a un cumulo di mattoni, pezzi di cemento e armature di ferro.
Solo lì erano morti duecentottantaquattro bambini e ragazzi.
Fermammo l’auto e scendemmo.
Ai Weiwei, Mille anni di gioie e dolori. Memoir39
Così inizia il capitolo “Indagine dei Cittadini” nelle memorie di Ai Weiwei.
Ai Weiwei è uno dei più importanti artisti del nostro tempo: designer, architetto, regista, performer, fotografo, documentarista, blogger, scrittore, editore, dissidente politico.
Il film della statunitense Alison Klayman, presentato per la prima volta in Italia nell’edizione 2012 del Biografilm Festival (sezione Contemporary Lives), nonché plurivincitore in altri cinema-festival di richiamo (uno su tutti: Sundance 2012, Gran Premio Speciale della Giuria) privilegia soprattutto l’ultimo ruolo elencato, ovvero l’attivismo politico dell’artista.
In realtà un artista finisce quasi sempre per fare politica, per scelta o inconsapevolmente, volente o malgré soi. Soprattutto se si tratta di un contemporaneo. Una crasi di recente conio indica questo status: artivismo, arte con un contenuto sociale esplicito.
Vincenzo Trione (ordinario di Arte e media presso l’Università IULM di Milano) ha pubblicato di recente una monografia su questo tema: Artivismo. Arte, politica, impegno40. E il primo degli exempla citati è per l’appunto Ai Weiwei, «le cui installazioni ci parlano in maniera esplicita e diretta di drammi, di problemi sociali, di oppressioni, di sofferenze, di dittature, di conflitti, di libertà negate41».
Qualche cenno biografico: Ai Weiwei nasce nel 1957 da una famiglia di intellettuali. I genitori, Ai Qing e Gao Ying, sono entrambi letterati. Il padre Ai Qing (che avrà un ruolo importante nelle testimonianze dell’artista documentate da Klayman) è uno dei maggiori poeti cinesi del secolo scorso, più volte candidato al premio Nobel. Nonostante la sua adesione al Partito comunista, nel 1958 Ai Qing viene accusato di “destrismo”: viene perciò esiliato da Pechino insieme alla famiglia. Alla fine degli anni Cinquanta, Ai Qing e la famiglia vengono inviati in un campo di rieducazione militare a Shihezi, nella provincia dello Xinjiang nel nord-ovest della Cina. In seguito vengono deportati in un villaggio ancora più isolato e vivono per anni nel deserto del Gobi. Ai Qing è condannato a estenuanti lavori forzati: per umiliarlo gli viene affidato l’incarico di pulire le latrine del paese. La coraggiosa e serena accettazione da parte del padre di quella condizione resterà impressa nella memoria di Ai Weiwei.
Alla morte di Mao nel 1976 seguono altri rivolgimenti, che portano al processo e destituzione del governo dei “diadochi” (la moglie e tre suoi associati). Comincia la cosiddetta Primavera di Pechino. Ai Qing viene riabilitato come altri dissidenti, e ritorna a Pechino con la famiglia. Con Deng Xiaoping si avvia un processo di liberalizzazione. Si riaprono le accademie d’arte, e Ai Weiwei entra nella Film Academy di Pechino, nel primo corso post Rivoluzione culturale, assieme a futuri grandi registi come Chen Chaige e Zhang Yimou.
Ai Weiwei mostra ben presto il gene dell’insofferenza a qualunque regime, compreso quello del realismo socialista di stampo sovietico. Fonda il collettivo di artisti Stars. La prima mostra del gruppo apre nel 1979, davanti alla China Art Gallery di Pechino. Viene subito dichiarata illegale. Il gruppo organizza una marcia di protesta chiedendo democrazia e libertà di espressione. Finalmente viene concessa una seconda sede per la mostra del collettivo, che riscuoterà un grande successo. Ai Weiwei espone acquerelli ispirati non solo alla tradizione cinese, ma anche al tardo Ottocento europeo, in particolare a Van Gogh.
A ventiquattro anni, nel 1981, con pochi dollari in tasca, Ai Weiwei si trasferisce negli Stati Uniti. A New York studia presso la Parsons New School of Design. Come suo solito insofferente, lascia la scuola dopo sei mesi appena. Frequenta musei e gallerie, restando infine devoto all’arte di Marcel Duchamp.
Le sue prime opere sono influenzate dal dadaismo. Hanging Man è un objet trouvé, con cui rende omaggio a Duchamp trasformandolo nel profilo dell’artista. I semi di girasole, il cibo più povero in Cina, colmano una parte del profilo. Inizia ad occuparsi di fotografia, specie in bianco e nero, raccogliendo più di diecimila negativi, una specie di “blog ante litteram”. Legge avidamente La filosofia di Andy Warhol (dalla A alla B e ritorno).
Nel 2016 alla National Gallery di Melbourne e all’Andy Warhol Museum di Pittsburgh verrà dedicata una grande mostra proprio al rapporto tra Ai Weiwei e Andy Warhol.
Nel 1993, alla notizia di una grave malattia del padre, Ai Weiwei torna in Cina. Il governo è oppressivo e il controllo totale. Ai Weiwei comincia così a manifestare il proprio carattere di dissidente: pubblica tre libri, The Black Cover Book (Il libro nero) nel 1994; The White Cover Book (Il libro bianco) nel 1995, The Grey Cover Book (Il libro grigio) nel 1997, tre opere che contengono interviste e opere di artisti contemporanei cinesi, ma anche immagini di opere di Duchamp e Warhol e loro testi per la prima volta tradotti in cinese. Questi libri sono oggi giudicati opere di importanza storica e manifesto fondamentale per la nascita dell’avanguardia artistica cinese.
Il suo rapporto conflittuale con la millenaria tradizione cinese diviene fondamentale nella sua produzione artistica.
Forse la declinazione più emblematica del suo rapporto con l’arte dell’antica Cina è Dropping a Han Dynasty Urn (Distruzione di un’urna della dinastia Han, 1995). Tre iconici scatti in bianco e nero sono il suggello di una famosa performance: nel primo l’artista, che indossa la divisa degli operai cinesi, si trova in piedi davanti a un muro e stringe tra le mani l’urna Han, antica di oltre duemila anni. Nel secondo la apre e il vaso sta cadendo. Nel terzo l’urna giace a pezzi in terra. L’artista è impassibile, suo scopo è sottolineare l’atto deliberato di barbarie culturale, paragonabile alla distruzione del Patrimonio storico cinese voluto dal governo con la Rivoluzione culturale. E l’urna funeraria è un memento mori.
Non potendo purtroppo qui rievocare tutta l’imponente produzione artistica di Ai Weiwei, possediamo tuttavia gli strumenti per comprendere cosa significhi essere un “artivista”.
Il governo cinese ha tentato di ridurlo al silenzio con ogni mezzo: picchiandolo, oscurando il suo blog, isolandolo in regime di detenzione segreta, demolendo il suo studio.
Ma Ai Weiwei è tuttora irriducibile. Simbolo delle contraddizioni della Cina odierna, continua la sua lotta. Senza chiedere scusa.
In Ai Weiwei – Never Sorry (USA, 2012), la telecamera della regista Alison Klayman, per due anni unico occhio autorizzato a seguirlo per testimoniarne le “gesta”, documenta l’attività di Ai mentre denuncia le ingiustizie del proprio paese, servendosi dei social network ma soprattutto veicolando il messaggio attraverso una produzione artistica (spesso collettiva) vulcanica e inesausta.
Il docu-film esordisce con la presentazione delle esposizioni di Weiwei alla Haus der Kunst di Monaco di Baviera nel settembre 2009, e alla Tate Modern nell’anno successivo.
Nel 2008 a Sichuan un terremoto provoca circa settantamila vittime; tantissimi studenti muoiono sotto le macerie delle scuole. Ai Weiwei rimane colpito dall’immagine di tanti zainetti sommersi dalle rovine. A quell’immagine si richiamerà in un’opera esposta a Monaco, Remembering (2009): sulla facciata del museo, migliaia di zainetti sistemati in modo da formare la frase (in cinese) che aveva detto una donna parlando della figlia morta nel Sichuan: «È vissuta felicemente per sette anni in questo mondo».
L’artista accusa apertamente il governo cinese di aver usato materiali scadenti per costruire gli edifici, e pubblica sul suo blog i nomi dei cinquemila bambini morti. Nel 2009 quello stesso blog, creato nel 2006, viene chiuso dalle autorità.
La mdp di Klayman registra questi e altri momenti, a partire da un primo incontro datato dicembre 2008. Mostra documenti inediti sulle pressioni esercitate dal regime sull’artista, ma si sofferma anche sulle “pause”, sui momenti di vita quotidiana dell’artista, sul suo rapporto con la moglie, il figlio, la madre e il padre, il poeta Ai Qing, venuto a mancare nel 1996.
Il biopic di Klayman corrobora la narrazione del “paladino della libertà di espressione”, suggella la fama di Ai Weiwei icona mondiale del dissenso. Ed è ciò che ci attendiamo, in qualità di spettatori. Ma in qualche modo anticipa le vicende successive, non meno cariche di risonanza e significato.
Nel 2010 la giunta municipale di Shanghai stabilisce che lo studio di Malu Twon debba essere chiuso e demolito. L’11 gennaio viene distrutto, ma Ai Weiwei riesce a recuperare parti dell’edificio.
Per la sua opposizione al regime verrà recluso per 81 giorni, dal 2 aprile al 22 giugno 2011.
Solo il 15 maggio 2011 l’artista potrà vedere la moglie Lu Qiong.
Il 22 giugno, a distanza di 81 giorni dall’arresto, verrà rilasciato su cauzione. Da allora è costantemente tenuto sotto controllo.
Nel 2017 Ai Weiwei dirigerà il documentario Human Flow presentato alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Naturalmente il grande artista cinese non è l’unico “artivista” ospitato al Biografilm Festival: ve ne sono altri, non meno memorabili. È il caso di Letizia Battaglia, premiata nel corso dell’edizione 2019 con un riconoscimento istituito ad hoc: Celebration of Lives Award, assegnatole per il valore etico e civile alla base dei suoi famosi scatti. Il film Letizia Battaglia. Shooting the Mafia della italo-irlandese Kim Longinotto ne realizza un ritratto-simbolo, presentato al Festival di Berlino e al Sundance.
Commovente è Luci per Ustica, di Luciano Manuzzi, anche a causa della recente scomparsa dell’artista Christian Boltanski (Parigi, 6 settembre 1944 – Parigi, 14 luglio 2021), chiamato nel 2007 a Bologna per progettare e realizzare il Museo per la memoria di Ustica. Leggendo i rottami dell’aereo, Boltanski ha trasfigurato il relitto, trasformandolo in un vero e proprio “Luogo di Vita” dedicato alle vittime della Strage.
Con l’installazione delle luci, lampadine che illuminano l’intero spazio occupato dal relitto, dei grandi vetri neri che rappresentano le vittime, dei “sepolcri” che contengono i loro effetti personali, e delle voci registrate che sussurrano al visitatore frasi comuni di vita vissuta dai caduti, Boltanski riesce a raccontare il senso della casualità della morte, e della necessità di ricordare come questa casualità colpisca il visitatore e lo faccia riflettere sulla propria vita, che è la stessa vissuta dai passeggeri del volo abbattuto.
Toccante è la stessa testimonianza dell’artista, il suo sentirsi impotente dinanzi alla strage, con parole che suonano come una lirica: «Eppure non mi posso fermare, ci devo provare ancora».
Su RaiPlay è reperibile il documentario L’archivio dei battiti del cuore di Alessandro Spinnato: è il racconto del viaggio in Giappone intrapreso da Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, per visitare il museo realizzato da Boltanski sull’isola di Teshima. L’artista ha registrato e raccolto i battiti del cuore di migliaia di persone in ogni parte del globo. Una testimonianza, quella della Bonfietti, che simbolicamente rappresenta la riconoscenza e il forte legame dell’Associazione con Christian Boltanski, e la solidarietà con la popolazione dell’isola, vittima in passato di una tragedia ecologica perpetrata ai suoi danni dallo stato giapponese.
III.4. Outsider: Radical Landscapes
Quando il “non luogo42” era ancora u-topia.
Alla morte del padre, Elettra Fiumi (regista e produttrice) ritrova per caso alcuni nastri super 8, e poi un ingente patrimonio documentale sommerso: l’intero archivio dell’architetto “radicale” Fabrizio Fiumi, fondatore insieme a Giorgio Birelli, Carlo Caldini, Paolo Galli, del Gruppo 9999: più che un movimento, un progetto utopico che non realizzerà mai nulla di “concreto”; se si esclude un’immensa mole di disegni, pubblicazioni, video, che hanno dato vita a un’uguale quantità di manifestazioni, performances, azioni ed esperienze collettive, multimediali e psichedeliche.
La sede non venne edificata ma “trovata”, e adattata a molteplici scopi. Il suo nome era sulla bocca di tutti, protagonista di una stagione culturale che ha lasciato tracce profonde e radicate, ben oltre il perimetro di Firenze: Space Electronic.
Ufficialmente una “discoteca”; in realtà, per l’appunto, uno spazio. Creato e inaugurato nel febbraio 1969 su iniziativa di Fabrizio Fiumi e Carlo Caldini (che ne assumeranno la gestione fino al 1972), viene continuamente ripensato/ridisegnato per ospitare tutte le attività creative ideate o “importate” dal collettivo di “architetti-artigiani”, che all’inizio si era battezzato 1999.
Non è facile sintetizzare la storia e l’evoluzione del gruppo che poi si chiamerà, dopo il 1970, 9999. L’ispirazione arriva da un viaggio negli Stati Uniti compiuto da Caldini e Preti (1966-67) e, parallelamente, dall’esperienza californiana di Fabrizio Fiumi: un’elaborazione ancora allo stato germinale delle prime teorie sull’ «architettura come comunicazione elettronica».
Lo Space Electronic di Firenze nasce con l’intento di gemellarsi all’Electric Circus di New York, per ospitare le performances delle avanguardie teatrali (come il Living Theatre) e musicali.
Ne emerge un intero mondo, o meglio un nuovo modo di concepirlo: tutto poteva essere architettura, non più concepita solo come disciplina accademica e realizzazione di spazi abitabili. Un’operazione di taglio e montaggio, simile per certi aspetti a quello cinematografico.
Elettra Fiumi eredita questo metodo e lo fa suo. In Radical Landscape (2022, nel palinsesto del Biografilm Art & Music dell’ultima edizione), mette insieme filmati privati e pubblici del padre, appunti manoscritti, interviste. Restituisce voce e presenza a un umanesimo culturale e collettivo che non era solo fiorentino, e non solo di Fabrizio Fiumi: un progetto di vita, di relazioni con gli altri, che negli anni Sessanta e Settanta troverà spazi e forme di espressione analoghe a Bologna.
Davvero, come sosteneva Susan Sontag, il montaggio può fare tutto.
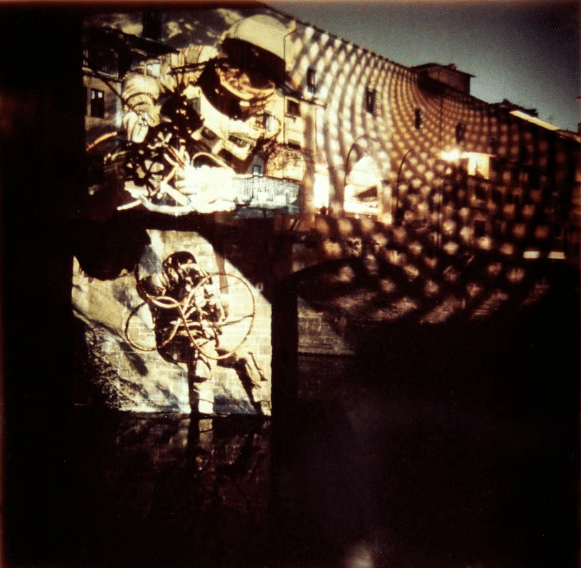
Conclusioni
Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς,
καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους
Il conflitto è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini.
Eraclito, fr. 53 Diels-Kranz
Il conflitto che si è tentato di analizzare in queste pagine è quello tra narrative eroiche e consolatorie e altre che cercano di privilegiare un “ritorno al reale”.
Il che significa, tradotto in termini cinematografici, utilizzare qualsiasi mezzo, anche virtuale, per ottenere un risultato che si avvicini alla realtà di una percezione, senza chiudere l’obiettivo dinanzi al “trauma”: che si verifichi come impatto violento con disastri umanitari, ecologici, bellici; o che si manifesti come disincanto davanti alla medietà umana di un racconto di “gesta epiche” che volevano solo intrattenerci per un centinaio di minuti, o anche meno.
Vale ugualmente per le biografie, specie se tradotte in linguaggio cinematografico. Cercare di restituire lo “sguardo” di un autore, “risarcire” un’opera d’arte o un artista, è impresa non facile. Somiglia in un certo senso al restauro: si può procedere con piccoli tocchi di pennello. Ma in questo modo si rischia anche lo «spettatore addormentato», per dirla con Ennio Flaiano (e non “emancipato”, come predicava Jacques Rancière).
L’arte contemporanea è per tutti, ma è molto lontana da un racconto didascalico quanto lo è dalla narrativa epica, o scientifica, anche quando si serva di tecnologie avanzate.
E d’altro canto il cinema è un mezzo perfetto non soltanto per esprimere il pensiero, compresa la filosofia, traducendola in azione. Ma anche come strumento per “espanderla”, riscriverla, aumentarne la realtà: come avevano intuito Pablo Picasso, Orson Welles, Andrej Tarkovskij, Andy Warhol, Jean Luc-Godard, Guy Debord, Akira Kurosawa, e oggi Wim Wenders, Ai Weiwei, Julian Schnabel, Elettra Fiumi. La drop list potrebbe continuare, gli esempi virtuosi da imitare non mancano. Si può avanzare il dubbio che non sia così indispensabile conformarsi a modelli televisivi per coinvolgere il pubblico.
Forse la domanda da porsi è un’altra, e interessa la sopravvivenza stessa della cinematografia: il cinema, con il suo dispiego di mezzi, costi, materiali non riciclabili, è ancora sostenibile?
Buona parte dell’arte contemporanea lo è già, da tempo.
In occasione della sua partecipazione al Biografilm Festival 2019, con il documentario di Andrey M. Paounov Christo – Walking on Water, l’artista rilasciò un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino.
Alla domanda «Dove va [a finire] tutto il materiale [sottotesto: “così ingombrante e inquinante”]?», Christo risponde: «È tutto materiale industriale, riciclabile. Ad esempio, per quanto riguarda le 5 mila tonnellate di acciaio per The Gate a New York, ancor prima di realizzare il progetto, avevo venduto tutto ai cinesi per fare dei grattacieli. Da uomo che ha ricevuto una formazione marxista, io riciclo tutto, fino alla fine».
Al momento la “settima arte” non pare adeguarsi a questa esigenza, così umana, prima ancora che ecologica. Non mancano tuttavia riflessioni su questo tema, considerato che il cinema non è solo un veicolo d’arte, ma anche un comparto industriale e produttivo con un forte impatto sull’ambiente. In tutta la filiera, compresa la distribuzione e la trasmissione. L’industria televisiva e cinematografica è una delle più energivore al mondo: per la produzione di un’ora di contenuti televisivi vengono emesse tonnellate di anidride carbonica. Con un incremento preoccupante, anno dopo anno, dato il volume crescente di programmi e contenuti e grazie alla diffusione dello streaming. L’impronta di CO₂ lasciata dall’industria dei media si espande senza sosta43.
Per permettere anche al cinema di allinearsi agli standard stabiliti dall’Agenda 2030 dell’ONU con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), è nato il Green Film Research Lab, presentato nella sede ANICA di Roma il 18 aprile 2023: in collaborazione con Trentino Film Commission, è stato elaborato un protocollo disciplinare e di certificazione per valutare l’impatto ambientale ed economico delle produzioni audiovisive in Italia. Un’importante iniziativa, un primo passo per poter continuare ad amare il cinema, così come l’arte a noi più vicina, quella che vive e nutre il nostro tempo.
Bibliografia essenziale
Ai Weiwei, Mille anni di gioie e dolori. Memoir, Feltrinelli, Milano, 2023
Angelucci Daniela, Deleuze e i concetti del cinema, Quodlibet, Macerata, 2012
Annicchiarico Silvana (a cura di), Branzi Andrea (a cura di), Le sette ossessioni del design italiano, Electa, Milano, 2008
Arnheim Rudolf., Cinema come arte, Abscondita, Milano, 2016
Augé Marc, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2014
Barale Alice, Arte e intelligenza artificiale, Jaca Book, Milano, 2020
Barthes Roland, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 2003
Barthes Roland, Miti d’oggi, Einaudi, Torino, 1974
Benjamin Walter, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, Einaudi, Torino, 2012
Bernier Ronald R., The Unspeakable Art of Bill Viola. A Visual Theology, Wipf and Stock, Eugene-Oregon, 2014
Berry David M., Dieter Michael, Postdigital Aesthetics. Art, Computation and Design, Palgrave MacMillan, Londra, 2015
Bertetto Paolo, La macchina del cinema, Laterza, Bari, 2013
Broeckmann Andreas, Machine Art in the Twentieth Century, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts, 2016
Brunetta Gian Piero, La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 1932-2022, La Biennale di Venezia / Marsilio, Venezia, 2022
Buchanan Peter, Piano Renzo, Renzo Piano, Building Workshop, Phaidon Press, Londra, 1997
Centrone Bruno, Μελαγχολικός in Aristotele e il Problema XXX,1, in Studi sui Problemata physici aristotelici, a cura di B. Centrone, Bibliopolis, Napoli, 2011 (collana “Elenchos”, n. 58)
Ciccarelli Lorenzo, Renzo Piano, Frances Lincoln, Londra, 2023
Costa Antonio, Il cinema e le arti visive, Einaudi, Torino, 2022
Danto Arthur C., La trasfigurazione del banale, Laterza, Bari, 2021
Debord Guy, La société du spectacle, Buchet Chastel, Paris, 1967
Debord Guy, La società dello spettacolo, Massari, Bolsena (VT), 2002
Debord Guy, Opere cinematografiche, Bompiani, Milano, 2004
Deleuze Gilles, L’immagine movimento. Cinema 1, Einaudi, Torino, 2016
Deleuze Gilles, L’immagine tempo. Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017
Didi-Huberman Georges, La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini, Boringhieri, Torino, 2011
Eccher Danilo, Christian Boltansky, Charta, Milano, 1997
Farinotti Rossella, Il quadro che visse due volte. Quando l’arte diventa cinema, goware, Firenze, 2012
Feynman Richard, La fisica di Feynman. 3. Meccanica quantistica, “52.8 Antimateria”, Zanichelli, Bologna, 2017
Foucault Michel, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, trad. Emilio Panaitescu, Rizzoli, Milano 1967
Fisher Mark, Schermi, sogni e spettri. Cinema e televisione. K-punk /2, minimum fax, Roma, 2021
Gervasini Mauro, Se continua così. Cinema e fantascienza distopica, Mimesis, Milano, 2023
Ghezzi Enrico, Stati di cinema. Festival ossessione, Bompiani, Milano, 2002
Godard Jean-Luc, Due o tre cose che so di me. Scritti e conversazioni sul cinema, minimum fax, Roma, 2018
Grasso Aldo, Trione Vincenzo (a cura di), Arte in TV. Forme di divulgazione, Johan & Levi, Monza, 2017
Graw Isabel, High Price. Art Between the Market and Celebrity Culture, Sternberg Press, Londra, 2010
Guzzetti Alfred, Two or Three Things I Know about Her. Analysis of a film by Godard, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1981
Harvey David, La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano, 2016
Hardouin Frédéric, Le cinématographe selon Godard. Introduction aux Histoire(s) du cinema ou réflexion sur le temps des arts, L’Harmattan, Paris, 2019
Hoban Phoebe, Basquiat, Castelvecchi, Roma, 2010
Isgrò Emilio, Autocurriculum, Sellerio, Palermo, 2017
Jacobs Steven, Framing Pictures. Film and the Visual Arts, Edinburgh University Press, Edinburgo, 2011
Klibansky Raymond, Panofsky Erwin, Saxl Fritz, Saturno e la melanconia, Studi di storia della filosofia naturale, religione e arte, Einaudi, Torino, 1983
Lacan Jacques, “Scritti”, Volume Primo, RCS Libri, Milano, 2007
Lacan Jacques, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud 1953-1954, Einaudi, Torino, 1978
Lees-Maffei Grace, Fallan Kjetil, Made in Italy. Rethinking a Century of Italian Design, Bloomsbury, Londra, 2014
Machado Penousal, Romero Juan, Greenfield Gary (Editors), Artificial Intelligence and the Arts, Springer, Berlino, 2021
Manzoli Claudio, Marra Claudio (a cura di), V. 3, N. 2, (2018): L’arte mediata: dal Critofilm al Talent Show, “Piano b. Arti e culture visive”, rivista online, Università di Bologna, Bologna, 2019
Maresco Franco, La mia Battaglia. Conversazioni con Letizia Battaglia, Il Saggiatore, Milano, 2023
Martin Barnaby, Hanging Man. La vita, le opere e l’arresto di Ai Weiwei, Il Saggiatore, Milano, 2013
Milani Raffaele, Il cinema underground americano, D’Anna, Firenze, 1978
Millet Catherine, L’art contemporain, Flammarion, Parigi, 2013
Montani Pietro, L’estetica contemporanea, Carocci, Roma, 2004
Morgan Daniel, Late Godard and and the Possibilities of Cinema, University of California Press, Oakland-California, 2012
Morin Edgar, Il cinema o l’uomo immaginario. Saggio di antropologia sociologica, Raffaello Cortina, Milano, 2016
Munari Bruno, Fantasia, Laterza, Roma, 2017
Nietzsche Friedrich Wilhelm, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972
Perniola Ivelise, L’era postdocumentaria, Mimesis Cinema, Milano, 2014
Perniola Mario, Estetica italiana contemporanea, Bompiani, Milano, 2017
Perniola Mario, L’avventura situazionista, Mimesis, Milano, 2013
Rancière Jacques, Aisthesis. Scenes from the Aesthetic Regime of Art, Verso Books, Londra, 2013
Salgado Sebastião, Dalla mia Terra alla Terra, Contrasto, Roma, 2014
Senaldi Marco, Arte e televisione. Da Andy Warhol al Grande Fratello, postmedia books, Milano, 2009
Senaldi Marco, Doppio sguardo. Cinema e arte contemporanea, Bompiani, Milano, 2008
Senaldi Marco, Van Gogh a Hollywood. La leggenda cinematografica dell’artista, Meltemi, Milano, 2020
Spampinato Francesco, Art vs. TV. A Brief History of Contemporary Artists’ Responses to Television, Bloomsbury Academic, Londra, 2022
Stoichita Victor, Breve storia dell’ombra. Dalle origini alla pittura alla pop art, Il Saggiatore, Milano, 2015
Sontag Susan, Contro l’interpretazione. E altri saggi, Mondadori, Milano, 1998
Tafuri Manfredo, La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ’70, Einaudi, Torino, 1980
Tafuri Manfredo, Progetto e utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Laterza, Roma, 1973
Tarkovskij Andrej, Scolpire il tempo, Ubulibri, Milano, 1988
Trione Vincenzo, Artivismo. Arte, politica, impegno, Einaudi, Torino, 2022
Vernant Jean-Pierre, L’immagine e il suo doppio. Dall’era dell’idolo all’alba dell’arte, Mimesis, Milano, 2010
Viola Bill, Nero video, Castelvecchi, Roma, 2016
Warhol Andy, La filosofia di Andy Warhol, Feltrinelli, Milano, 2016
Warhol Andy, The Andy Warhol Diaries, Edited by Pat Hackett, Hachette, New York, 1989
Wenders Wim, L’atto di vedere, Meltemi, Milano, 2022
Zylinska Joanna, The Future of Media, Goldsmiths Press, Londra, 2022
Žižek Slavoj, Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi, Milano, 2002.
Note
- L’analisi qui impostata è di tipo “percettivo”, e non tiene conto degli effettivi “ripensamenti” del pittore rilevati dalle indagini diagnostiche condotte sull’opera a fini conservativi e di restauro.
- Georges Didi-Huberman, La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pag. 13.
- Gilles Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, Einaudi, Torino, 2017, passim.
- Gilles Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1, Einaudi, Torino, 2016, passim.
- Jacques Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io, Comunicazione al XVI Congresso internazionale di psicoanalisi. Zurigo, 17 luglio 1949; in Jacques Lacan, “Scritti”, Volume primo, RCS Libri, Milano, 2007.
- Friedrich W. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1972.
- NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece: https://www.bibelwissenschaft.de/en/bible/NA28/1CO.13 [05.02.2024].
- BIBBIA – Vesione ufficiale CEI, 2008.
- Si veda https://www.sefaria.org/Yevamot.49b.10?lang=bi&with=all&lang2=en [05.02.2024].
- Jacques Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud 1953-1954, Einaudi, Torino, 1978. Nel Cap. VII, “La topica dell’immaginario”, Par. I: «Le scienze, e soprattutto le scienze in gestazione come la nostra, prendono spesso in prestito dei modelli dalle altre scienze. Non immaginate, amici miei, quel che dovete alla geologia. […] Anche l’ottica potrà dir la sua. In questo caso non mi trovo in disaccordo con la tradizione del maestro; più di uno di voi ha certamente notato nella Traumdeutung, al capitolo Psicologia dei processi onirici, il famoso schema in cui Freud inserisce tutto il processo dell’inconscio. All’interno Freud pone i differenti strati, che si differenziano dal livello percettivo, cioè dall’immagine istantanea, S;, S,, ecc., contemporaneamente immagine, ricordo. Queste tracce registrate sono ulteriormente rimosse nell’inconscio. […] Non vi raccomanderò mai abbastanza la meditazione sull’ottica. Cosa curiosa, si è fondato un intero sistema di metafisica sulla geometria e sulla meccanica, cercandovi modelli di comprensione, ma non sembra che fino a oggi si sia tratto tutto il possibile dall’ottica. Dovrebbe tuttavia prestarsi a qualche sogno, questa bizzarra scienza che si sforza di produrre con apparecchi quelle singolari cose che si chiamano immagini, a differenza dalle altre scienze che introducono nella natura un’operazione di ritaglio, una dissezione, un’anatomia. […] In verità un’altra cosa è ancora più sorprendente ed è che l’ottica riposa interamente su di una teoria matematica, senza la quale è assolutamente impossibile strutturarla. Affinché ci sia un’ottica bisogna che a ogni punto dato nello spazio reale corrisponda un punto e uno solo in un altro spazio, che è lo spazio immaginario. È l’ipotesi strutturale fondamentale. Ha l’aria eccessivamente semplice ma senza di essa non si può scrivere la minima equazione, né simbolizzare alcunché, l’ottica è impossibile. Anche coloro che l’ignorano non potrebbero far nulla in ottica, se non ci fosse. Anche qui lo spazio immaginario e lo spazio reale si confondono. Ciò non impedisce che debbano essere pensati come differenti. […] Quando vedete un arcobaleno, vedete qualcosa d’interamente soggettivo. Lo vedete a una certa distanza ricamarsi sul paesaggio. Non è lì. È un fenomeno soggettivo e ciononostante, grazie a un apparecchio fotografico, lo registrate del tutto obiettivamente. Allora che cos’è? […] L’apparecchio fotografico non è forse un apparecchio soggettivo, interamente costruito con l’ausilio di una x e di una y, che abitano nel dominio dove vive il soggetto, cioè nel dominio del linguaggio?»
- Richard Feynman, La fisica di Feynman. 3. Meccanica quantistica, “52.8 Antimateria”, Zanichelli, Bologna, 2017.
- Marco Senaldi, nato nel 1960, filosofo, curatore e teorico d’arte contemporanea, ha insegnato in varie istituzioni accademiche, tra le quali l’Università di Milano Bicocca. Si occupa degli aspetti filosofici dell’arte e del suo impatto a livello mediatico. In questa sede si analizza il suo studio Van Gogh a Hollywood. La leggenda cinematografica dell’artista, Meltemi, Milano, 2020. Dopo essersi soffermato sulle varie possibili tipologie di mitemi riguardanti le biografie di artisti (nel cap. I, “L’artista fra Simbolico e Immaginario”), il critico analizza alcuni casi concreti: non soltanto Van Gogh, ma, a seguire, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Jackson Pollock, Andy Warhol.
- Ibidem.
- Roland Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino, 1974; Tit. orig. Mythologies, Ed. du Seuil, Paris, 1957.
- Victor Stoichita, Breve storia dell’ombra. Dalle origini alla pittura alla pop art, Il Saggiatore, Milano, 2015.
- Marco Senaldi, Van Gogh a Hollywood, cit.
- Jean-Luc Godard, Due o tre cose che so di me. Scritti e conversazioni sul cinema, Minimum fax, Roma, 2018, pagg. 72-73. Il capitolo citato venne pubblicato sui Cahier du cinéma, n. 159, ottobre 1964.
- https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/09/13/e-morto-jean-luc-godard.-liberation-e-ricorso-al-suicidio-assistito_c590526a-f704-4ef5-95d3-598cef2074f3.html [cons. 16/02/2024]
- Marco Senaldi, Van Gogh a Hollywood, cit.
- Il “Principio di Anna Karenina” è un test di verifica d’ipotesi, ispirato dal celeberrimo incipit del romanzo di Lev Tolstoj.
- Andrej Tarkovskij, Scolpire il tempo, Ubulibri, Milano, 1988.
- Frédéric Hardouin, Le cinématographe selon Godard. Introduction aux Histoire(s) du cinema ou réflexion sur le temps des arts, L’Harmattan, Paris, 2019.
- Si veda in proposito la Prefazione del bel volume di Steven Jacobs, Framing Pictures. Film and the Visual Arts, Edinburgh University Press, 2011.
- Ibidem. Steven Jacobs, Framing Pictures, CHAPTER 6, The Video That Knew Too Much: Hitchcock, Contemporary Art and Post-Cinema, POST-CINEMA AND GODARD’S HISTOIRE(S).
- Georges Didi-Huberman, La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, op. cit.
- Il concetto di “destituzione soggettiva” è un tema ricorrente in diverse opere di Jacques Lacan. Ad esempio nel Seminario su La lettera rubata (1955-1956) introduce il concetto di “soggetto barrato”, ovvero la divisione e mancanza costitutiva del soggetto. Si vedano gli Scritti, Vol. I, Fabbri, Milano, 2007. [Prima edizione originale: Écrits, Éditions du Seuil, Paris, 1966.] A pag. 49: «Se l’uomo arriva a pensare l’ordine simbolico è perché vi è anzitutto preso nel suo essere. L’illusione di averlo formato con la sua coscienza proviene dal fatto che è per la via di una beanza specifica della sua relazione immaginaria con il suo simile, che egli è potuto entrare in quest’ordine come soggetto.»
- Guy Debord, La société du spectacle, BUCHET/CHASTEL, Paris, 1967, 1ª ed. originale, passim.
- Guy Debord, La società dello spettacolo, Massari, Bolsena (VT), 2002.
- Slavoj Žižek, Benvenuti nel deserto del reale, Meltemi ed., Roma, 2002.
- Wim Wenders, L’atto di vedere, Meltemi ed., Milano, 2022.
- Sebastião Salgado è nato l’8 febbraio 1944 ad Aimorés, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Vive a Parigi. Dopo studi di Economia, Salgado ha cominciato la sua carriera come fotografo professionista nel 1973 a Parigi, lavorando con le agenzie fotografiche Sygma, Gamma e Magnum Photos fino a quando, nel 1994, insieme a Lélia Wanick Salgado, ha fondato Amazonas images, un’agenzia creata esclusivamente per il suo lavoro. Ha viaggiato in oltre 100 paesi per realizzare i suoi progetti fotografici. Molti di questi, oltre ad apparire in diverse pubblicazioni sulle riviste internazionali, sono stati raccolti in libri come Other Americas (1986), Sahel: l’homme en détresse (1986), Sahel: el fin del camino (1988), La Mano dell’uomo (1993), Terra (1997), IN cammino e Ritratti (2000), Africa (2007). Le mostre itineranti del suo lavoro continuano ad essere presentate in tutto il mondo. Sebastião Salgado ha ricevuto diversi, prestigiosi premi fotografici come tributo per le sue realizzazioni. Inoltre, è stato nominato Goodwill Ambassador dell’UNICEF e membro onorario dell’Accademia di Arti e Scienze degli USA. Nel 2004, Sebastião Salgado ha cominciato il suo lavoro Genesis che presentiamo in questa sede. Il gruppo di immagini è concepito come un potenziale cammino per la riscoperta della vera identità umana nella natura. Insieme, Lélia e Sebastião hanno lavorato fin dai primi anni Novanta al ripristino di una parte della fascia atlantica forestale del Brasile. Nel 1998 sono riusciti a trasformare questo territorio in una riserva naturale e hanno creato l’Instituto Terra. Lo scopo dell’Instituto è la riforestazione, la conservazione e l’educazione all’ambiente.
- Vedi la scheda del film in APPENDICE. La foto di cui parla Wenders è parte del reportage nella miniera di Serra Pelada in Brasile (1986).
- Sebastião Salgado, Dalla mia Terra alla Terra, op. cit.
- Testo e traduzione sono riportati integralmente in Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz Saxl, Saturno e la melanconia, Studi di storia della filosofia naturale, religione e arte, Einaudi, op. cit.
- The Blob, regia di Irvin S. Yeaworth Jr., USA 1958.
- Mario Perniola, L’avventura situazionista, Mimesis, Milano, 2013.
- Ibidem.
- Susan Sontag, Contro l’interpretazione. E altri saggi, Mondadori, Milano, 1998.
- Ai Weiwei, Mille anni di gioie e dolori. Memoir, Feltrinelli, Milano, 2023.
- Vincenzo Trione, Artivismo. Arte, politica, impegno, Einaudi, Torino, 2022.
- Ivi, pag. 12.
- L’espressione è dell’antropologo francese Marc Augé, che nel suo saggio Non-Lieux (ed. Seuil, Paris, 1992), operando un vero e proprio détournement linguistico, attribuisce al termine un contro-valore: i non-luoghi non sono più utopie, come nella filosofia rinascimentale, ma spazi dell’anonimato, ogni giorno affollati da turbe di individui soli: infrastrutture, mezzi di trasporto, supermercati, catene alberghiere; e gli stessi campi profughi dove vengono parcheggiati esseri umani in fuga da guerre e miserie. Si veda l’edizione italiana: Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2014.
- Si veda a tale proposito l’articolo di Annalisa Percoco, Senior Researcher in Geografia dello Sviluppo presso FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei): Cinema e Sostenibilità, https://equilibrimagazine.it/cultura/2023/02/23/il-cinema-per-educarsi-alla-sostenibilita/ [Cons. 7/03/2024].
Questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International. Copyright (c) 2024 Alessandra Mantovani








